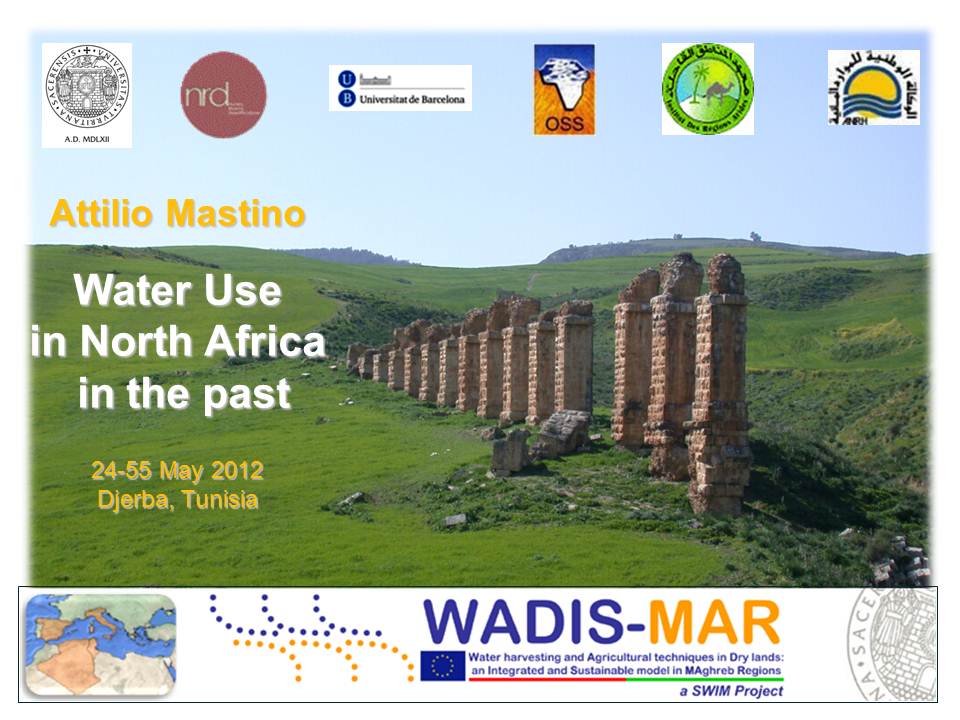Water Use in North Africa in the past.
Water Use in North Africa in the past
Attilio Mastino – Antonio Ibba*
Djerba, 24 maggio 2012
{phocadownload view=file|id=79|text=Scarica la Relazione…|target=b}
WADIS-MAR, Water harvesting and Agricultural techniques in Dry lands: an Integrated and Sustainable model in Maghreb Regions
O. Sono onorato di rappresentare l’Università di Sassari, tornando in Tunisia in un incontro sulla scarsità della risorsa idrica, sulla gestione dell’acqua e i processi di desertificazione, promosso anche dal NRD Nucleo ricerca desertificazione dell’Università di Sassari: torno in Tunisia con emozione, ricordando tante occasioni e tante speranze, anche qui a Djerba, in occasione del XV Congresso de L’Africa Romana. Ma soprattutto voglio ricordare le nostre ricerche archeologiche presso Dougga e Theboursouk ad Henchir Douamis, la collina dei sotterranei, che nel nome ricorda la presenza di tante cisterne per la raccolta dell’acqua al punto di arrivo di un imponente acquedotto. Spero vorrete perdonarmi se per un m,omento vi porterò indietro nel tempo, alla scoperta di luoghi che conservano tracce delle tecnologie impiegate nell’antichità classica per la raccolta dell’acqua, preziosa risorsa per la sopravvivenza nelle aree interne del Maghreb.
1. Alla fine dell’età coloniale, confrontando la situazione dell’Africa Mediterranea francese con quella della Francia, Jean Despois nell’ormai classico volume intitolato “L’Afrique du Nord” pubblicato nel 1963[1] sintetizzava nel termine “inégalité” l’aspetto essenziale del clima nord-africano, evidenziando in particolare l’irregolare distribuzione delle precipitazioni invernali, la scarsità di quelle primaverili, le forti variazioni pluviometriche fra anni contigui, la siccità che dura 4-5 mesi nelle regioni dominate dalla steppa.
« 300 millimètres de pluie bien réparties, affermava Despois, suffisent à assurer un assez bon récolte de céréales, alors que 400 ou 500 mal distribués donnent de médiocres résultats. Les pluies torrentielles sont en grand partie perdues pour l’agriculture, surtout si elles tombent sur un sol déjà saturé…. Les pluies torrentielles amènent des désastres par les ravinements et les inondations qu’elles provoquent, en particulier quand elles ont une violence inaccoutumée. Inversement on assiste souvent à des longs mois secs ou qui n’ont que des pluies faibles suivies de vents violents. Des pluies d’automne trop tardives ou rares empêchent ou gênent les labours et les semailles ; l’insuffisance des pluies de printemps compromet non seulement la récolte des céréales au point de rendre nulle dans certains régions, mais aussi celles du raisin et des olives »[2].
Scrosci intensi ma brevi impediscono all’acqua di penetrare in profondità nel terreno, erodono violentemente le superfici asportando gli strati fertili; è fortissima l’evaporazione, in particolare nelle aree interne, caratterizzate da cieli limpidi e da venti forti e caldi. Durante l’inverno tuttavia una diffusa ed elevata umidità in aree come il Sud-Ovest marocchino e la Tunisia Orientale, in particolare nell’area di Gabès, permettono l’impianto di diverse coltivazioni. Diretta conseguenza del clima sarebbero per lo studioso i corsi d’acqua temporanei (oueds, wadis), solo raramente alimentati dalle nevi e dipendenti per lo più dalle irregolari precipitazioni, abbondanti solo in inverno e quasi aridi in estate e dunque poco efficaci nella lotta contro la siccità e in agricoltura[3].
Con un approccio deterministico oggi non più accettabile, Despois concludeva che il clima aveva influenze devastanti e irreversibili sull’economia locale, sull’organizzazione della società berbera, addirittura sull’umore dei poveri fellah impotenti di fronte a una natura matrigna e dunque quasi giustificati nella loro trasparente ignavia. Se questa lettura, figlia del suo tempo, oggi non trova più credito nel mondo scientific, è tuttavia indubbio che i problemi climatici evidenziati dallo studioso caratterizzano il Maghreb sin dall’antichità: a queste oggettive difficoltà l’uomo ha tentato nel tempo di porre rimedio con soluzioni individuate dalle varie discipline storiche (archeologia ed epigrafia in particolare) e che parzialmente trovano o potrebbero trovare applicazione ancora oggi.
2. Il problema dell’acqua era infatti ben noto nell’Africa romana fra le Colonne d’Ercole sull’Oceanoe le Arae Philenorum in Libia, al confine tra Triplitania e Cirenaica, sia per la forza distruttrice delle piene improvvise[4], sia per quella vivificatrice che permette la nascita degli insediamenti e le attvità produttive.
Possiamo ricordare alcune testimonianze epigrafiche. A Zireg, a Sud dei monti Hodna durante il principato di Settimio Severo vengono concessi agri, pascua, fontes ai coloni insediati in un settore delicato del confine, zona militare e di passaggio delle tribù: l’imperatore africano è convinto che l’acqua sarà un elemento indispensabile per la produttività e la valorizzazione di quelle terre e vuole impedire che questo bene sia disponibile solo per pochi fortunati[5]. Per converso, forse volendo colpire gli odiati domini di Lepcis Magna, che li sfruttavano come braccianti, nel 238 i Berberi distrussero l’acquedotto che permetteva di irrigare le terre a sud-est della colonia, una strategia spesso adottata nel IV secolo dagli Austuriani[6].
Gli impianti di adduzione sono corredo indispensabile di un ricco podere. A Biha Bilta, nell’Alto Tell Tunisino, il solerte proprietario si vanta di aver costruito un pozzo che al tempo di Aureliano gli ha permesso di apportare migliorie al suo fundus e di creare nuova ricchezza[7]. Ad Henchir El-Left, Florentius, procuratore del patrimonio imperiale in Proconsolare, fra il 321-324 dedica a Netturno un lungo canale che dal bacino di adduzione (ninfio!) portava l’acqua sui praedia di Costantino[8]; ad Albulae Terentius Cutteus realizza con i figli e la moglie sulle sue terre un aquagium, un canale di scolo evidentemente indispensabile per l’efficienza della sua fattoria[9].
La necessità quotidiana dell’acqua è sottolineata dalle numerose dediche al genius che protegge la fonte (per esempio alle sorgenti dell’Ampsaga, Oued Rummel, alla Ferme du Caid presso Batna, o ad Hammam Sayala) o a Neptunus, il dio del mare ma più in generale delle acque, per questo venerato in insediamenti lontani dalle coste come nel villaggio di Tituli fra Haidra e El Kef, a Gafsa, a Lambaesis, forse fra i monti dell’Ouarsenis nell’Algeria occidentale[10].
Più in generale nelle iscrizioni del II-IV secolo, fra Libia e Algeria, è diffusa l’attenzione per l’acqua, le sorgenti e gli impianti di adduzione o distribuzione: thermae, aquaeducti, fontes, putea, cisternae sono termini ricorrenti nell’epigrafia africana (invero non particolarmente prolifica su questo tema, una quarantina di testi), impianti essenziali per lo svolgimento della vita civile, che contribuiscono a distinguere un centro urbano da un villaggio, che aumentano il prestigio di un insediamento e gli agi dei suoi abitanti, che denunciano l’adesione della popolazione a modelli di vita romani. Sono opere che hanno una forte ricaduta sulla collettività e per questo sono realizzate sia dall’imperatore o dai suoi funzionari (16 casi), sia pecunia publica da magistrati locali (14 esempi), sia infine con il contributo di facoltosi evergeti alla ricerca del consenso politico ed elettorale nella comunità[11]: a Sabratha Flavius Tullus aquam privatam induxit, costruì bene 12 bacini e infine versò duecentomila sesterzi per la manutenzione dell’impianto che veniva donato alla città[12]. Ritorneremo in seguito su questi aspetti ma già ora è interessante osservare che gli impianti sfruttavano una o più sorgenti poste a non grande distanza dall’insediamento: in generale nell’attuale Tunisia gli aquedotti più lunghi non superano i 10 km (a milliario septimo ricorda un testo di Thugga) e di solito si attestano fra i 4-5 km[13]. La loro importanza era comunque strategica e non a caso è frequente in Numidia l’intervento dei militari, sia come forza lavoro sia come supporto tecnico; in Libia e nelle oasi del predeserto venivano usati gli schiavi per costruire i canali sotterranei.
3. Ben più ampia ma disomogenea la documentazione archeologica giacché questo settore della ricerca è stato parzialmente trascurato in passato. In Marocco le informazioni si concentrano sui centri urbani, alcuni dei quali come Volubilis indagati capillarmente, mentre i siti rurali sono stati poco esplorati; spesso non è noto attraverso quali canali l’acqua raggiungeva i centri abitati. Le prospezioni franco-marocchine nel bacino dell’oued Sebou d’altronde dimostrerebbero che per i vici dell’area, sorti generalmente in prossimità degli oueds, non fu realizzata nessuna importante opera idraulica per la raccolta o la distribuzione dell’acqua; farebbero eccezione alcune opere in prossimità delle coste (cisterne, bacini, canali) collegati ai processi di lavorazione e conservazione del pesce, in gran parte destinato all’esportazione[14].
In Algeria programmaticamente il Service des Antiquités e Stephan Gsell si concentrarono sulla viabilità di età Romana perché su quella si sarebbe potuta impiantare la viabilità moderna, necessaria al controllo di un territorio considerato insicuro. Un grosso passo in avanti lo si deve al colonello Jean Baradez che sfruttando la fotografia area poté individuare nella regione a ridosso dell’Aurès strutture antiche per raccogliere, controllare, regolare le acque pur non potendo allora chiarirne con precisione la cronologia. Sulla scia, ma con attente indagini sul terreno, si mosse un decennio dopo Jean Birebent, con studi specifici limitati tuttavia ai soli impianti dell’Algeria orientale[15].
Abbondano invece le informazioni sulla Tunisia, un protettorato considerato politicamente tranquillo e dove nella prospettiva del governo francese era possibile investire risorse. È infatti un dato di fatto che tanto la Brigade Topographique quanto i cultori delle Antiquità che percorrevano il paese, avevano un occhio particolarmente attento alle opere idrauliche nella convinzione che queste informazioni potevano essere ancora utili nel XIX secolo e fare da volano all’economia della nuova Tunisia, una visione che ancora traspare negli scritti di Despois e Gilbert Picard alla metà del XX secolo. Tutti questi dati furono radunati e commentati già nel 1897 da Paul Gauckler nel suo Enquête sur les installations hydrauliques romaines en Tunisie. In tutti questi lavori è manifesta l’idea che solo i Romani fossero riusciti a sfruttare in maniera capillare le enormi potenzialità agricole dell’Africa e che solo attraverso un recupero di queste conoscenze sarebbe stato possibile rimediare ai danni provocati dai Berberi dediti al nomadismo e dagli invasori arabi, a loro giudizio incapaci di gestire quel patrimonio ed anzi autori di un’insensata distruzione di impianti indispensabili al progresso del paese e alla sua prosperità[16].
Il lavoro di Gauckler era abbastanza sommario per quanto riguarda gli impianti rurali e spesso trascurava le regioni prossime al deserto e le oasi, se non in rari casi. Qui invece la ricerca è stata potenziata negli ultimi 40 anni dalle sistematica prospezioni di Pol Trousset fra Gafsa, il Jérid e Gabès[17]. Questo era stato un filone collaterale nelle indagini condotte in Libia dagli archeologi italiani ed anglosassoni nella prima parte del XX secolo, più recentemente ripreso dall’équipe inglese guidata da Graeme Barker e David Mattingly nell’ambito del progetto UNESCO Farming the Desert dedicato agli insediamenti rurali della Tripolitania[18]. Trousset e Mattingly hanno puntato alla riscoperta e valorizzazione del patrimonio culturale, senza perdere di vista le possibili ricadute pratiche sull’economia locale, hanno attirato l’attenzione sulle tecniche di adduzione delle acque nella regione del pre-deserto, sottolineando una continuità fra mondo pre-romano, romano, bizantino, aglabide, in alcuni casi sino ai giorni nostri, con risultati straordinari che rendono giustizia a un mondo tutt’altro che sottosviluppato e al contrario capace di produrre del surplus per il commercio con i centri urbani della costa.
In anni ancor più recenti, la percezione a livello sociale e politico di cambiamenti climatici globali, ha riportato in auge gli studi di idraulica e riacceso i riflettori sulle soluzioni idriche adoottate dai Romani rifornire città e campagne. Quasi in contemporanea escono nel 2008 fra gli altri alcuni contributi negli Atti del XVII convegno L’Africa Romana, dedicati alle foggaras e alle cisterne della Malga a Cartagine[19] e soprattutto il repertorio di Massimo Casagrande, che raccoglie tutta la bibliografia sugli impianti idrici della Zeugitania e della Byzacena e ne censisce 422 distribuiti in 362 siti differenti, fornendo interessanti osservazioni sulle tecniche e le finalità delle strutture individuate[20]. Sono solo dell’anno seguente gli Atti del Convegno Controle et distribution de l’eau dans le Maghreb antique et médiéval che pur nella loro incompletezza (mancano purtroppo alcune interessanti relazioni presentate a Tunisi nel 2002) offrono una rassegna molto ampia e critica sul progresso degli studi in tutta l’Africa Mediterranea per un arco cronologico che volutamente sfuma dall’età punica a quella aglabide. Infine si ricordano gli Atti del Convegno di Cadice 2009 Aquam perducendam curavit, editi già nel 2010, dedicato in particolare alla situazione della Baetica ma aperto al confronto con altre realtà dell’impero romano d’Occidente, in particolare con due panoramiche sulla Africa Proconsolare e sulla Tingitania.
4. È impossibile in questa sede entrare nei dettagli di questa ricca documentazione e ci limiteremo ad alcuni esempi fra i più diffusi e significativi, sottolineando differenti soluzioni di fronte a problemi comuni.
I già ricordati lavori di Trousset fra Gafsa, lo Chott Jérid, Gabès, El Hamma, Arad, hanno evidenziato come gli impianti idraulici abbiano condizionato la vita agricola e la nascita di società fortemente articolate ed impegnate nella gestione dell’acqua. Le strutture presenti nella regione sono alimentate dalle acque che discendono dalle ultime propaggini del Tell sahariano, captate dagli acquedotti, oppure da quelle portate in superficie con pozzi artesiane come nel Jérid o a Nefzaouna[21].
Nella regione di Sud-Est fra Matmata e Dehibat sino al Jebel Nefousa il rilievo tunisino-tripolitano costituisce invece una zona intermedia fra le Steppe e il Sahara per l’altezza dei monti (715 m), la pluviometria (200 mm), la vicinanza al Mediterraneo. Qui la popolazione sedentaria pratica l’arboricoltura grazie a metodi di irrigazione molto particolari che attingono l’acqua non tanto dalle rarissime fonti ma grazie a terrazze o sbarramenti (jessour) che controllano e incanalano le acque alluvionali o degli oueds Merteba, Seradou, El Hamma[22]. Strutture simili sono state individuate in Libia[23], nella Tunisia sud-orientale nella piana di Augarmi[24], fra Feriana e Kasserine nella regione delle Alte Steppe[25]. Spesso gli archeologi le hanno confuse con le clausurae, sbarramenti lineari lungo le piste in cui si spostavano in antico uomini, armenti e merci, destinati a regolare i flussi piuttosto che a difendere o chiudere ermeticamente il territorio provinciale[26].
I jessour sono infatti dei piccoli e parziali sbarramenti dei letti dei torrenti e nei valloni che trattengono le acque di deflusso e i fertili sedimenti che queste trasportano, riducendo l’erosione idrica. Più jessour sono disposti in sequenza, a distanze regolari, nel letto del torrente. Ogni jesr si compone di uno sbarramento (tabia o katra) perpendicolare al vallone, e di un’area di raccolta dei sedimenti (fondo del jesr) che è una sorta di terrazza a monte della tabia sulla quale si impiantano le coltivazioni e che talora è rafforzata alla base con pietre; ogni tabia ha uno o due scoli, quelli laterali detti menfess, quelli centrali masraf, che permettono di far defluire verso il jesr posto a valle l’acqua in eccesso; le acque si infiltrano progressivamente nel suolo e non evaporano, costituendo una riserva vitale per combattere la siccità. Si stima che con questo metodo 200 mm di pioggia abbiano l’efficacia di 500 mm con evidenti vantaggi per l’agricoltura[27].
I jessour sono noti già in documenti del secolo XI secolo ma è probabile che affondino le loro radici in codici non scritti rialenti al mondo antico. Presuppongono l’esistenza di un’organizzazione collettiva che limita il diritto soggettivo nel nome dell’interesse comune. Ogni jesr infatti non può che trattenere una certa quantità d’acqua e cedere il superfluo al jesr a valle; l’altezza della tabia, la posizione degli scoli, la loro larghezza, la pendenza del jesr non possono essere modificate se non con un accordo generale fra proprietari di jessour contigui e gli stessi proprietari devono garantirne la manutenzione; è vietato ostruire gli scoli per trattenere le acque, danneggiando di conseguenza il vicino; ogni proprietario è responsabile dei danni causati a valle dall’acqua che fuoriesce dal suo jesr.
L’uso dei jessour probabilmente favorì la sedentarizzazione delle tribù del deserto nel Jébel, dove l’élite punico-libica, poi romanizzata, praticava da tempo la coltivazione dell’olivo: la violenta rivalità fra Lepcis Magna e Oea, esplosa nel 71 d.C. con l’intervento armato del comandante della legione, potrebbe nascere dalla necessità di accaparrarsi nuove parcelle di terreno che grazie ai jessour potevano ora dare importanti rendite. È in ogni caso evidente che i jessour fra Libia e Tunisia sono collegati a una serie di fattorie costituitesi in contemporanea alla creazione di una fitta rete di fortini per il controllo del territorio in età giulio-claudia; queste fattorie, forse solo nel IV secolo, furono fortificate e presero la forma dei gsur: il singolare gasr forse deriva dal latino castra e gli stessi occupanti amavano definire queste fattorie con termini militari come turris, castra, oppidum: nella sua forma classica è una torre quadrangolare dalle mura massiccie, con all’interno con due o più magazzini, una pozzo, una stretta porta d’accesso[28].
5. Ai gsur, isolati o raggruppati in piccoli nuclei di cinque o sei edifici, erano annessi degli spazi circolari identificati come aie, silos circolari per lo stoccaggio dei cereali, frantoi e soprattutto cisterne o pozzi che captavano le acque degli oueds: le cisterne (majen) erano di solito sistemate sul bordo degli oueds e i bacini erano scavati nella roccia[29]. L’esempio meglio conservato è quello di Tininai, con pozzetto quadrangolare di circa 2 x 2 m profondo 7 m, alla cui base si aprono 4 canali a croce di 24 x 4 m; l’acqua era estratta con pozzi più piccoli e bacini di decantazione, secondo modelli ben studiati da Rebuffat nelle fattorie della Libia: impianti di questo genere potevano raccogliere dai 50 ai 200 m3 di acqua ma a Tininai la batteria di cisterne arriva a conservare 3000 m3. Ad Ain Merzak presso Bir Scedua sino a qualche anno fa ancora l’acqua veniva captata da una sorgente perenne con l’uso di animali che la pescavano a 20 m di profondità. Il sistema più frequente è però quello di bacini quadrangolari scavati in superficie, rivestiti da malta idraulica e ricoperti da volte o copertura piana, con piccoli fori che permettevano di pescare l’acqua dall’alto. L’acqua era trasportata verso la cisterna da pozzi di captazione e piccoli bacini di decantazione posti a monte della cisterna stessa[30].
6. Una tecnica diffusa nelle aree pre-desertiche fra Libia e Algeria è quella delle foggaras, le gallerie sotterranee capaci di drenare le acque della falda freatica e di condurle verso le oasi; in Marocco il sistema, forse introdotto solo dagli Aglabidi, prende il nome di khettara ma la sua origine è probabilmente iraniana (dove sono note come qanats), introdotta dagli Achemenidi in Egitto nel V secolo a.C. e da qui trasmessa prima ai Garamanti del Fezzan, poi ai Romani; tracce di questo sistema sono state individuate in Andalusia (madjira o pozeria) e più recentemente sono state esportate in Sud America.
Le foggaras sono pozzi di aerazione verticali, scavati a distanze regolari, che collegano con la superficie la galleria sotterranea, posta anche a venti metri di profondità. I pozzi sono indispensabili sia per lo scavo del condotto sia per le successive operazioni di pulizia. Per realizzare la galleria si scavano prima una serie di pozzi a intervalli regolari tra loro e con profondità costanti, poi viene eseguito uno scavo tra le basi di due pozzi contigui sino al congiungimento dei due scavi convergenti, ottenendo così il cunicolo idraulico tra i due pozzi di partenza. In superficie, alla bocca dei pozzi si accumulano i materiali di spurgo così recuperati che segnalano la presenza e la direzione dei condotti sottostanti. A valle la galleria, caratterizzata da una minima pendenza, sbocca in un bacino presso l’insediamento e da qui si diramano una serie di canali per irrigare i campi. Lo scavo inizia a partire dalle aree agricole delle oasi, penetra nel terreno delle vallate alluvionali e risale gli alvei della rete idrografica sino a raggiungere l’insieme degli strati permeabili della falda freatica. Con questo sistema è possibile emungere attraverso gli strati permeabili la falda freatica alimentata dalle normali precipitazioni o dalle condensazioni notturne dell’umidità di superficie, determinata dalle forti escursioni termiche. Acqua di captazione e acqua di condensazione può in questo modo essere convogliata ed utilizzata per l’irrigazione, impedendo un’inutile dispersione di liquidi nel terreno o nell’atmosfera. Maggiore è la superficie drenante di captazione e maggiore sarà l’acqua distribuita nei campi a valle[31].
Con le foggaras i Garamanti, stanziati fra l’Hamada el Jamra ed il Tropico del Cancro, svilupparono un’intensa agricoltura i cui prodotti erano in parte destinati al commercio con le città romane della costa libica. La loro capitale, Garama, con i suoi 20 ettari cinti da mura, i templi, i bagni, i quartieri abitativi, i mercati, le vaste e ricche necropoli, può essere considerata una vera e propria città. Sul loro territorio è stato individuato un articolato sistema di irrigazione, che conta ancora oggi migliaia di foggaras lunghe fra i 500 m e i 2 km[32]. Probabilmente i Garamanti insegnarono ai Getuli questa tecnica e furono questi utlimi a diffonderla nelle aree sahariane algerine di Gourara, Touat, Tidikelt e Ahaggar, fra Tebessa e Batna, regioni dove le gallerie drenanti, circa un migliaio, raggiungono uno sviluppo complessivo tra i 3000 e i 6000 km[33]. In Algeria il drenaggio della falda non avviene mai a grande profondità e i pozzi d’areazione sono realizzati a 2-4 m fra loro a causa della fragilità del terreno e forse anche per recuperare al massimo la precipitazione occulta; i canali sommersi variano fra i 3-10 km; le gallerie strette (60-70 cm) e con altezza variabile fra 1-1,50 m e i 3-4 m, probabilmente in seguito all’abbassamento della falda freatica, che in alcuni casi ha suggerito la realizzazione di una seconda galleria più in basso[34]. In Tunisia sono noti i tunnel drenanti della piana di El Soukra, a occidente di Cartagine, quelli di Sidi Nasseur Allah, a circa 80 km a ovest di El Djem, tra Kairouan e Gafsa, nell’oasi di El Guettar, nell’area di Nefzaoua[35].
7. Le caratteristiche idrogeologiche dell’area a ridosso dell’Aurès settentrionale hanno contribuito ad un forte popolamento in epoca romana, con la nascita di numerosi borghi agricoli che, tramite un articolato e differenziato sistema di approvvigionamento idrico, erano in grado di sfruttare al meglio le falde freatiche di superficie[36]. Probabilmente la foggara di Inemarem nella regione dei monti di Bellezma, nell’Aurès nord Occidentale, era una delle sorgenti dell’Aqua Claudiana di Lamasba. Da qui giunge il celebre regolamento de aquis[37], redatto durante il principato di Elagabalo in seguito a un arbitrato interno alla comunità che oppeva i coloni (in maggioranza dei Numidae) insediatisi sulle terre imperiali. Il testo, per il periodo compreso fra il 25 settembre e dicembre, stabilisce in maniera precisa orari e durata dell’irrigazione per i singoli lotti, in relazione alla posizione del terreno, alla maggiore o minore evaporazione nell’arco della giornata, al livello del bacino di raccolta (aqua descendens o ascendens). Un sistema di chiuse evitava probabilmente che il livello del bacino salisse o scendesse oltre i limiti di guardia. Dal bacino l’acqua era ridistribuita con un canale centrale (matrix riganda) a canali secondari connessi agli appezzamenti di terreno, alcuni organizzati a terrazze (scalae). La quantità d’acqua destinata ai singoli lotti era calcolata in base a un non meglio definibile coefficiente K, una scala di valori che permetteva di essere equanimi e uniformi nell’irrigazione dei terreni. Il regolamento di Lamasba nasce dal pragmatico incontro fra la tradizione giuridica italica e i sistemi di misurazione punici, diffusi fra la popolazione locale ancora agli inizi del III secolo.
La sua applicazione doveva essere diffusa se ancora all’ aqua ascendes o descendes si fa riferimeno in una delle Tablettes Albertini, documento tratto dallo schedario di Flavio Geminio Catullino, ricco possidente nella regione di Tébessa, e redatto nel 494: i lotti venduti da Iulius Restitutus e sua moglie Donata sono coltivati a terrazza (particellas agrorum id est aumas sivi coerentes), e il loro valore è determinato sia dalle piante coltivate sia dai diritti sull’acqua del proprietario[38]. Acutamente Pol Trousset raccorda questi meccanismi di distribuzione idrica con quelli presenti nelle oasi e nei jessour tunisini, dove, come a Lamasba, hanno dato vita a una proprietà molto parcellizzata: per esempio nelle oasi di Touat e Gourara le acque, una volta fuoriuscite dalle foggaras, sono condotte attraverso un canale scoperto in un bacino di distribuzione e da qui immesse nei canali (seguia) dei singoli proprietari, in quantità proporzionali alle quote di proprietà.
Pur di matrice pre-romana, le foggaras si diffusero in Africa in età imperiale e i Romani vi apportarono una serie di accorgimenti tecnici, per esempio l’uso di foderare il canale sommerso con con lastre o pietre, ignoto ai Garamanti, al fine di ridurre le perdite d’acqua; altro espediente era quello di realizzare nel condotto, una piccola canaletta, anch’essa rivestita, per facilitare lo scorrimento dell’acqua: era forse una foggara l’Aqua Paludensis di Thamugadi, costruita nel 183-185, che tuttavia si serviva anche di numerosi pozzi, cisterne e sfruttava le acque della fonte perenne di Ain Morris: l’iscrizione ricorda infatti che tale opera idraulica era in grado di drenare (conquirere) le acque di una falda freatica (aquae paludensis)[39].
8. Jessour, foggaras, pozzi, canali, acquedotti spesso sono i tasselli di un sistema integrato che ancora oggi in uno stesso territorio, per esempio nell’oasi di El Guettar presso Gafsa, puntano a sfruttare le risorse idriche presenti, combattono l’erosione delle terre e i fenomeni di desertificazione, favoriscono l’innalzamento della falda freatica[40]. Gli effetti di questa organizzazione sono descritti in un celebre passo di Plinio il Vecchio, che fu procuratore fiscale in Proconsolare fra il 70-72 e che probabilmente visitò l’oasi di Gabès, antica Tacape, rimanendo colpito dalla sua straordinaria fertilità: “il y a en Afrique, au milieu des sables, … une cité nommée Tacape, dont le territoire, bien irrigué est d’une fertilité miraculeuse. Dans un rayon d’environ trois mille pas, une source fournit une eau abondante sans doute, mais qu’on ne distribue pourtant qu’à heures fixes aux habitants. Là sous un immense palmier, pousse un olivier ; sous l’olivier, un figuier ; sous le figuier, un grenadier ; sous le grenadier, une vigne ; sous la vigne on séme le blé, puis des légumineuses, enfin des herbes potagères : tout cela le meme année, tout cela se nouirrissant à l’ombre du voisin. … Le plus étonnant c’est que la vigne y porte deux fois et qu’on fait le vendange deux fois pour an. Et si il n’épuisait pas la fécondité du sol par des production multiples, l’exubérance ferait périr chaque récolte. Le fait que toute l’année on y recolte quelque chose, et il est certain que les hommes ne favorisent pas cette fertilité”. La sorgente a cui allude Plinio è forse quella di Sed Reha, dove gli archeologi hanno rinvenuto i resti di uno sbarrammento probabilmente di età romana[41]. Plinio è rapito dall’abbondanza dell’oasi, dove i piccoli lotti raggiungono prezzi elevatissimi giustificati tuttavia dalla resa della terra, registra il curioso metodo per calcolare le superfici (Quaterna cubita eius soli in quadratum, nec ut a porrectis metiantur digitis, sed in pugnum contractis), estraneo al sistema agrimensorio romano; sottolinea come la natura abbia premiato l’uomo oltre i suoi meriti ma nel contempo non può che riconoscere agli abitanti dell’oasi la capacità di organizzare e distribuire questa ricchezza per creare maggiore profitto. L’efficienza di questi sistemi di adduzione e la loro incidenza sull’economia è indirettamente provata anche dai rilievi funerari legati ai gsur più importanti: accanto alle scene di guerra, caccia, amministrazione della giustizia, vengono rappresentate carovane cariche di merci e scene di vita agricola: la raccolta dei datteri, la semina e il raccolto dei cereali, i dromedari che arano i campi, quasi una fotografia plastica di quanto Plinio aveva potuto osservare a Gabès.
9. L’uso di un bene prezioso come l’acqua non poteva che essere normato. Se spesso la fonte era considerata un bene privato nella totale disponibilità del dominus del fundus in cui questa si trovava, tuttavia in molti altri casi era l’interesse collettivo ad essere prevalente, come a Lamasba, nelle oasi di Touat e Gourara, a Gabès. Le autorità provinciali favorivano con lo strumento delle servitù rurali l’accesso alle fonte agli uomini e agli armenti, sia constando una frequentazione della sorgente da tempo immemorabile sia ammettendone l’uso ininterrotto da soli dieci anni; in altri casi (per esempio ad Ain Sidi Mansour in Ouarsenis al tempo di Probo) il governatore stesso creava un nuovo diritto, aprendo l’uso della fonte, considerata di interesse generale, a particolari categorie e trasformando il quel bene da privato in pubblico[42].
Ad Ammaedara è necessario l’intervento di Caio Postumio Africano, senatore e patrono della colonia fra il 160-180 per imporre le servitù prediali necessarie a far passare l’acquedotto destinato ad alimentare la città e i campi: sappiamo infatti che i tecnici incaricati di riparare la struttura vi potevano accedere in qualsiasi momento e che potevano utilizzare quanto disponibile nella proprietà per effetture le riparazioni; sino a 15 piedi per lato era vietato costruire case o tombe o piantare alberi e questo era un limite importante, soprattutto quando ci si approssimava alla città e le aree edificabili acquisivano un valore maggiore, soprattutto quelle poste nei pressi di una strada e la strada era spesso la direttrice seguita da un acquedotto[43]. La nomina di Africano denota evidentemente una resistenza dei proprietari ad accogliere un’opera che con lo svantaggio di pochi avrebbe beneficato all’intera collettività: da qui la necessità di scegliere per questa impresa un notabile capace di convincere i più riottosi a non porre veti che avrebbero costretto l’amministrazione a lunghi procedimenti e a costose varianti di progetto. Africano agiva per ordine del proconsole, come suo legato speciale, o dopo aver ottenuto l’autorizzazione del procuratore ad attraversare le terre imperiali. In fondo problemi di questo genere sono gli stessi che i nostri amministratori devono affrontare ai giorni nostri e anche questo aspetto ci rende straordinariamente moderno l’approccio degli antichi Romani all’acqua.
* Si ringraziano per il supporto e per aver voluto discutere con gli autori i vari temi, M. Casagrande, M. B. Cocco, R. Zucca.
[1] Despois 1963, 15-29, 97-110.
[2] Despois 1963, 19.
[3] Despois 1963, 26, 27-28, 98, 103.
[4] AE 1975, 880 da Ureu: … [aquam (?) corrup]/tam post diluviem [—]/to servato recte (?) [—] / propria liberalitate [ex]o[rnavit] …; CIL VIII, 2661 (p. 1739) = ILS 5788 da Lambaesis: Aquam Titulensem quam ante annos / plurimos Lambaesitana civitas in/terverso ductu vi torrentis amiserat / perforato monte instituto etiam a / solo novo ductu …; da Gherait el Garbia (Chiron 2011, 276): Ab impetu aqu[arum —] / Multa loca ed[ucta(?) — / — pa]lude du[— per(?)] / [limi]tem Ten[theitanum — / —]I CVII m[ili(?)] …
[5] Leschi, 1948, 103-116 = Etudes, pp. 75-79.
[6] IRT 896 = AE 1973, 573: … [aquaeductu]m bell(o) dissi[patum] …. Sulla strategia degli Austuriani Felici, Munzi, Tantillo, 2008, 627-632.
[7] AE 1975, 883 = 1978, 835 = 1983, 975 = 2005, 1685: … praeter cetera bona q[uae] / in eodem f(undo) fecit steriles / qu[o]que oleastri surculo[s] / inserendo plurimas o[leas] / instituit puteum [iuxta] / viam pomarium cum tric[hilis] / post collectarium vin[eas] / novellas sub silva aequ[e in]/stituit …
[8] AE 1949, 49 cfr. CIL VIII, 23653 = 23673 = ILTun 565 = ILS 5732.
[9] CIL VIII, 21671 = ILS 5769: …. aquagium suis possessionibus / constituerun(t) et dedicaverunt.
[10] Salama, 1973, 344 note 11-12; BEL FAÏDA, 2002, 1715-1728. Meno probanti le dediche alle Ninfe, legate di solito a un impianto termale o a pozze di acqua calda, cfr. Arnaldi, 2004, 1355-1364.
[11] Cfr. le diverse posizioni di Shaw 1984, 121-173; Slim 1990, 169; Peyras 1991, 208-209; Wilson 1998, 91-92; Wilson 1999, 314.-331; BEL FAÏDA, 2000, 1589-1602 ; BEL FAÏDA, 2009, 123-141; Casagrande 2010, 469. Cfr. anche Casagrande 2008, passim.
[12] IRT 117.
[13] CIL VIII, 1480 (p. 2616) = 26534 = ILTun 1408 = AE 1966, 511 = DFH 36 = ZPE-175-288: [Pro salute Imp(eratoris) Caes(aris) M(arci) Aureli Commodi Antonini Aug(usti)] Pii Sarm[atici Ge]rmanici max[i]mi Britannici p(atris) p(atriae) civitas Aurelia Thugga [a]quam con[duxit e fonte M]occol[i]tano a milliario septimo [sua] pecunia induxi[t et] lacum fecit M(arcus) Antonius Zeno proc[o(n)s(ul) Africae dedic(avit) cur(atore) L(ucio) Terentio Romano] cfr. Casagrande 2010, 461-462, 469.
[14] Lenoir 2009, 41-83; Pons Pujol – Lagostena Barrios 2010, 533-542; cfr. Euzennat 1989.
[15] Baradez, 1949, pp. 165-212; Birebent 1964.
[16] Picard 1959, 59-76; Despois 1963, 120.
[17] Trousset 1986; Ben Ouezdou – Trousset 2009, 1-16.
[18] Barker 1996, passim. Mattingly 1996, passim.
[19] Baklouti 2008. 811-856; Mosca – Di Stefano, 2008, 857-877; De Angelis – Finocchi, 2008, 2179-2196. Sugli impianti di Cartagine, cfr. anche Wilson 1998, 65-102; Rossiter, 2009, 177-197; Di Stefano 2009, 143-164.
[20] Casagrande 2008, in particolare 249-260: in Zeugitania sono stati individuati 249 impianti in 202 siti (118 urbani, 13 rurali, 17 privati), in Byzacena abbiamo 173 impianti in 163 siti (49 urbani, 18 rurali, 8 privati).
[21] Ben Ouezdou – Trousset, 2009, 11.
[22] Ben Ouezdou – Trousset, 2009, 11-12.
[23] Supra; vd. anche Mattingly 1995, 68-77.
[24] Trousset 1974; Trousset 1987; Mrabet 1999; Mrabet 2003.
[25] Hitchner 1995, 143-158.
[26] Pur con differenti impostazioni, Bénabou, 1976, 429-445; Whittaker, 1978, 332-337, 340-350; Trousset, 1980, 935-942; Trousset, 1984, 383-398; Casella, 2004, 211-238.
[27] Ben Ouezdou – Trousset, 2009, 3-4.
[28] Rebuffat, 1982, 193-195; Elmayer, 1985, 78-80; Rebuffat, 1988, 44-60; Mattingly, 1987, 75-83; Mattingly, 1989, 141-143; Mattingly, 1995, 202-209; Mattingly – Dore, 1996, 127-133; Mattingly, 1998, 168-173; Felici, Munzi, Tantillo, 2008, 647-650; Munzi, Felici, Cirelli, Schingo, Zocchi, 2010, 727-731, 737-739. Gsur sono stati localizzati nella valle dell’Wadi Bei el-Kebir e nei bacini del Zem Zem e del Soffegin, ai bordi del Grande Erg Orientale, nel corridoio fra Gabès e lo Chott el Djérid.
[29] Mattingly – Dore, 1996, 133-158.
[30] Rebuffat 1988, 38-40, 43, 46, 53-55.
[31] Mattingly – Wilson 2003; De Angelis – Finocchi, 2008, 2179-2196; Wilson 2009, 19-39.
[32] Mattingly – Wilson 2003, 47-49.
[33] Mattingly – Wilson 2003, 39, cfr. Birebent, 1964, 51-58, 63-66, 81-83, 203-205, 213-215, 267-268, 387-389: foggaras sono note a Souma el Kiata, Henchir Oukhmida e Fridju, nell’altopiano del Mahmel fra i monti Nementchas, a Ksar el Kelb (Vegesala), ad Ain Ferhat, nella valle della Sbikra, Ain Kharoubi, nella piana di Baghai, Badias.
[34] De Angelis – Finocchi, 2008, 2189.
[35] De Angelis – Finocchi, 2008, 2190.
[36] Jacques, 1992, 125-139.
[37] CIL, VIII, 4440 = 18587 cfr. Birebent, 1964, 341-343, 387-389; Trousset 1986, 175-178, 192-193, vd. anche Picard 1959, 64; Shaw, 1982, 61-103; Meuret 1996, 87-112; De Angelis – Finocchi, 2008, 2191; Casagrande 2010, 468.
[38] AE 1952, 209 = 1954, 212 cfr. Shaw 1982, 81.
[39] AE 1934, 40 cfr. Leschi (1934-1935); Birebent, 1964, 325-330; Fentress (1979), 168-70.
[40] De Angelis – Finocchi, 2008, 2188-2189.
[41] Plin. NH, XVIII, 188-189: Civitas Africae in mediis harenis petentibus Syrtis Leptimque Magnam vocatur Tacape, felici super omne miraculum riguo solo. Ternis fere milibus passuum in omnem partem fons abundat, largus quidem, sed et certis horarum spatiis dispensatur inter incolas. Palmae ubi praegrandi subditur olea, huic ficus, fico punica, illi vitis, sub vite seritur frumentum, mox legumen, deinde olus, omnia eodem anno, omniaque aliena umbra aluntur. Quaterna cubita eius soli in quadratum, nec ut a porrectis metiantur digitis, sed in pugnum contractis, quaternis denariis venundantur. super omnia est bifera vite, bis anno vindemiare. Et nisi multiplici partu exinaniatur ubertas, pereunt luxuria singuli fructus. Nunc vero toto anno metitur aliquid, constatque fertilitati non occurrere homines. Cfr. anche Trousset 1986, 169, 173-175.
[42] Salama, 1973, 339-349, cfr. AE 1973, 652.
[43] AE 1988, 1119: Amm[aed]ar[ae] Aug(ustae) s[acrum] / C(aius) Postu[miu]s C(ai) f(ilius) Qui[r(ina)] / Afr[icanus c(larissimus) v(ir)] / [I]IIvir ca[pital(is) tr]ib(unus) leg(ionis) VII Gem(inae) q(uaestor) urb(anus) [ab ac]/[tis] senatus aedil(is) curul(is) p[r]aet(or) [urb(anus)] / [leg(atus) p]ro pr(aetore) patronus col(oniae) aq[uae ductum] / [e legi]bus praediorum iuris su[scepit] / [cum] / [rivo a]quae [q]uae permissu p[roco(n)s(ulis) vel p[roc(uratoris) fluit]. Cfr. Ben Abdallah, 1988, 236-251; Casagrande 2010, 463-466.