San Sperate di Attilio Mastino.
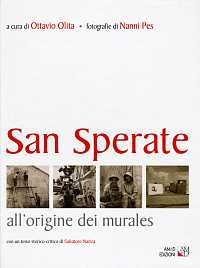 La lunga primavera di San Sperate è iniziata quaranta anni fa, nel 1968, all’indomani del viaggio di Pinuccio Sciola in Spagna e poi nella Parigi sconvolta dal vento della contestazione del maggio studentesco e poi in Messico, alla ricerca di una dimensione mitica immaginata e desiderata a lungo: con questo volume curato da Ottavio Olita siamo condotti per mano attraverso le interviste dei tanti protagonisti di allora a riscoprire le ragioni per le quali il paese contadino del Campidano è uscito da un sonno millenario, quando i suoi abitanti tutti all’improvviso si sono appassionati di arte, hanno scelto la rivoluzione del sorriso, hanno compiuto un percorso culturale che è stato anche un’esperienza collettiva che possiamo riconoscere ormai entrata nella storia della Sardegna.
La lunga primavera di San Sperate è iniziata quaranta anni fa, nel 1968, all’indomani del viaggio di Pinuccio Sciola in Spagna e poi nella Parigi sconvolta dal vento della contestazione del maggio studentesco e poi in Messico, alla ricerca di una dimensione mitica immaginata e desiderata a lungo: con questo volume curato da Ottavio Olita siamo condotti per mano attraverso le interviste dei tanti protagonisti di allora a riscoprire le ragioni per le quali il paese contadino del Campidano è uscito da un sonno millenario, quando i suoi abitanti tutti all’improvviso si sono appassionati di arte, hanno scelto la rivoluzione del sorriso, hanno compiuto un percorso culturale che è stato anche un’esperienza collettiva che possiamo riconoscere ormai entrata nella storia della Sardegna.
Le immagini in bianco e nero di Nanni Pes raccontano più delle parole con una profondità di campo che impressiona, fanno rivivere i tempi lontani del grigio paese di fango dall’aspetto spettrale che all’improvviso è diventato candido, ha riscoperto i colori, le figure, le emozioni, ha condiviso la passione, le curiosità, i desideri di un ragazzo come tanti, chiamato a guidare tutta la sua gente, che non è rimasta a guardare ma si è fatta incantare e quasi sedurre, ha vissuto e sofferto quasi una malattia o meglio un’epidemia.
Leggendo queste pagine mi è venuta in mente la vicenda straordinaria raccontata da Luciano di Samosata nel suo arguto volume Come si deve scrivere la storia che non dimostra i suoi quasi duemila anni: <
Il morbo abderitico, questa sorta di epidemia artistica, si era diffuso ai tempi di Luciano quando tutti si misero a scrivere la storia e non vi sembri offensivo se ho pensato di collegarlo con l’improvvisa passione e l’entusiasmo che ha colpito in un colpo gli abitanti di San Sperate, come ipnotizzati tutti assieme e coinvolti nella passione per la pittura e per l’arte.
Questo volume conserva memoria delle controverse fasi della trasformazione dell’antico paese contadino, tormentato in continuazione dalle alluvioni dei due fiumi, il Rio Mannu-Flumini ed il Bonarba, caratterizzato da tradizioni quasi preistoriche, da un’economia di baratto e di sopravvivenza basata sulle antiche professioni, sul trasporto animale a dorso d’asino, sul frumento impiantato in età romana in un’isola che fu uno per Cicerone uno dei tria frumentaria subsidia rei publicae.
Un paese che poi ha recepito il canto di sirena del mito, un messaggio di armonia, pace e cultura, portato dagli artisti provenienti da tutto il mondo come Eugenio Barba col suo Odin Teatret, i tedeschi Elke Reuter, Rainer Pfnurr, l’olandese Meiner Jansen, lo svizzero Otto Melcher, tra i sardi Foiso Fois, Giorgio Princivalle, Gaetano Brundu, Giovanni Thermes, questi ultimi caratterizzati da un forte astrattismo e simbolismo: allora i muri vengono dipinti di bianco, vengono intonacati i mattoni di fango, i caratteristici ladiris che ricordano una tecnica edilizia documentata in Sardegna dallo scrittore Palladio nel VI secolo d.C., i mattoni di argilla e di paglia prodotti in primavera ed descritti nel de lateribus faciendis. Arrivano i murales astratti, simbolisti, neorealisti, espressionisti, che parlano di un mondo più grande attraverso immagini schematiche spesso spiegate con didascalie, una forma nuova di epigrafia popolare destinata a durare per poco tempo. Ma l’obiettivo non è quello di rendere bello un paese brutto, è soprattutto quello di trovare un pretesto per un grande momento di partecipazione comunitaria e di dibattito intorno all’arte popolare. Contemporaneamente l’Ente Flumendosa bonificava il territorio comunale ed avviava le canalizzazioni che ancora oggi consentono l’irrigazione di una campagna destinata a fiorire in modo straordinario, con i suoi frutteti.
Questa non è però un’opera celebrativa perché in realtà Ottavio Olita è riuscito a restituire il senso delle polemiche di allora, i contrasti tra artisti, la durezza di uno scontro che ha appassionato e diviso il paese, tanto che c’è qualcuno che rimpiange i tempi nei quali l’amministrazione comunale di destra era ostile ai murales ed all’arte. Ho trovato straordinariamente intelligenti le riflessioni di Amalia Schirru e di tanti altri intervistati, capaci di dare una lettura non convenzionale di una vicenda artistica che è stata per anni al centro dell’attenzione dei media e che ha contagiato tanti altri paesi da Serramanna con Antonio Ledda e Ferdinando Medda, a Villasor, ad Orgosolo con Francesco Dal Casino, alla stessa Nuoro, ad Oliena, ad Ozieri, fino ad arrivare oggi a Tinnura in Planargia.
Il ruolo della stampa nella scoperta di questo evento, della primavera di San Sperate è stato rilevante, come testimoniano Vittorino Fiori, Ottavio Olita, Gianni Perrotti, lo scontroso Romolo Concas.
Giganteggia in queste pagine la figura carismatica di Pinuccio Sciola, accanto ai suoi maestri e mecenati, Foiso Fois, Guido Vascellari, a Salisburgo Emilio Vedova: nelle parole di chi l’ha conosciuto ragazzino, Pinuccio compare senza neppure le scarpe ai piedi, ma già circondato da affetto, stima, speranza, affezionato alla vita del paese che si sviluppa con una straordinaria socialità nelle cantine e nelle cucine, integrata nella campagna, ma insieme pieno di curiosità, desideroso di lasciare una traccia di sé su quella pietra che raramente si incontra nelle campagne campidanesi: dunque innanzi tutto la raccolta delle macine sparse in campagna, chiamate a decorare le piazze, poi il lavoro con gli amici, le tante idee bizzarre. Innanzi tutto i viaggi, a Firenze, nella Madrid franchista, a Barcelona, poi a Parigi, a Salisburgo, nel lontano Messico alla scuola di Davide Alfaro Siqueiros grazie all’intervento di Alberto Boscolo.
Nominato ispettore archeologo della Soprintendenza, Pinuccio fu in rapporto con i più qualificati studiosi sardi, come Giovanni Lilliu, Alberto Boscolo, e Salvatore Naitza, di cui ci rimangono in queste pagine due preziosissime testimonianze di rara profondità: io personalmente ricordo l’amicizia di Pinuccio con Renata Serra e con Giovanna Sotgiu, che mi ha fruttato in occasione del mio matrimonio il dono di una scultura in legno di olivo di una madre e di un bimbo e insieme un dipinto a tempera sullo stesso soggetto, quasi un murale con le mani ed i piedi deformati come in un manifesto. E poi più di recente una pietra musicale, che conservo gelosamente tra Bosa e Sassari.
E ancora Gianfranco Pintore, direttore del periodico bilingue Sa Sardigna, espressione della cooperativa ed i tanti artisti coinvolti a San Sperate, come Aligi Sassu, innamorato del paese dipinto, come lo chiamava, ma criticato per i suoi cavalli dai ragazzi del paese, pronti a mobilitarsi per testimoniare come si deve veramente dipingere. Del resto passarono per San Sperate persone come Arnoldo Foà o Dario Fo.
Pinuccio fu il motore della trasformazione del suo paese, che ben presto diventa il paese museo, con il parco megalitico, i murales, il cineforum, il teatro, la musica come il jazz di Alberto Rodriguez, in un vulcanico e magmatico succedersi di proposte contraddittorie e confuse, alcune portate avanti e poi accantonate, facendo leva sulle piccole occasioni di incontro, una processione, la sagra delle pesche, le scoperte archeologiche. Dunque la nascita della cooperative, il paese che si apre, le case che iniziano ad ospitare gli artisti, i cortili, l’impegno per difendere la fisionomia di un centro storico povero ma pieno di significati e di memorie, le resistenze degli amministratori ottusi ed incompetenti.
C’è del resto veramente lo scontro con le autorità locali e nel 1975 con la giunta municipale di destra, con il duro intervento delle forze di polizia e dei carabinieri, le perquisizioni e le intimidazioni, il processo davanti al pretore di Decimomannu, che segnò anche il riconoscimento del valore morale e culturale delle iniziative e l’impegno per difendere tutte le forme di espressione artistica, continuamente tormentata da scritte offensive, dai piccoli interessi di bottega, da invidie locali. Infine il lento pendio che porta Pinuccio ad abbandonare la politica attiva sia pure moderata e sardista ed a distinguersi sempre più nettamente dalle amicizie compromettenti, dall’arrivo di amici delle brigate rosse, dagli assistenti di Toni Negri che in quegli anni circolavano in Sardegna, dalle strumentalizzazioni politiche, nelle quali era rimasto invischiato – scrivono Antonio Sciola e Nanni Pes – per la sua eccessiva ingenuità, per il suo candore, per la sua fiducia negli altri. Lui stesso scrive oggi di aver rischiato di finire in galera come uno scemo, senza rendersi conto dei pericoli che correva. Ma più mi hanno sorpreso la durezza dei giudizi di Primo Pantoli su Pinuccio, accusato di essere politicamente una nullità, un istintivo che si è abbandonato ad una grande ingenuità.
Non trovo giusto però quello che scrive Primo Pantoli con parole di fuoco sul fatto che Pinuccio avrebbe sempre rifiutato il mondo della cultura assumendo una posizione ambigua, accettando in nome della demagogia anche espressioni d’arte popolare decisamente brutte e scadenti, rinunciando al compito degli intellettuali che sarebbe quello di selezionare e di conservare. Soprattutto non mi è piaciuta l’accusa di anti accademico. Voglio ricordare i riconoscimenti accademici di Pinuccio, che sembrano sottovalutati se si pensa alla rete di amicizie che ha coltivato e se io stesso dieci anni fa come preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Sassari avevo avuto modo di proporlo per un contratto di insegnamento al fianco di Aldo Sari e Gino Kalby, un’occasione per far entrare aria nuova nel mondo dell’Università che su L’Unione Sarda era stata apprezzata da Antonangelo Liori.
Al di là di Sciola, che comunque emerge per la forza dell’esempio e della testimonianza, si coglie da queste pagine il senso di una ampia partecipazione popolare, il senso di un percorso corale, di una ribellione e di un’istanza politica profonda, come se si fossero risvegliate forze sopite ma vitalissime, un gruppo di “militanti” decisi ad affermare una visione nuova della vita e del mondo.
Rimane irrisolto il nocciolo duro di questo libro, la domanda inespressa, se gli artisti che hanno colorato i muri di San Sperate tentassero di riscoprire una tradizione locale oppure volessero travolgere e violare l’antica cultura isolana, se i murales dei primi tempi avessero qualcosa a che fare con l’identità sarda oppure se viceversa volessero rompere quell’appartenenza ad una cultura che si vorrebbe fatta di silenzi e di grigiore.
Primo Pantoli non ritiene che in Pinuccio Sciola ci sia qualcosa di sardo e trova banale osservare che la lavorazione della pietra possa esser stata scelta come forma d’arte allo scopo di condurre l’artista sulla scia degli eroici costruttori dei nuraghes. C’è dietro queste osservazioni la vecchia e stantia polemica dell’esistenza di un’arte sarda, per il fatto che anche la Sardegna interna sarebbe stata interessata da una rete di relazioni e di influenze arrivate dall’esterno, senza una forma autonoma e originale di cultura. C’è anche un giudizio clamoroso sull’Accademia d’arte di Sassari, che sarebbe una specie di aborto, mentre d’ora in poi non si dovrebbe più parlare di arte Sarda ma di arte in Sardegna, secondo un’espressione che a me non appare così intelligente di Vittorino Fiori.
C’è il pregiudizio che l’arte protosarda sia stata iconoclasta, aniconica, complessivamente opaca e povera, comunque con un gusto estetico ben diverso da quello del muralismo contemporaneo, carico di vivacità di contrasti tanto da avvicinarlo al fumetto. Lo spessore dell’interesse degli artisti di San Sperate per la Sardegna profonda in realtà non può essere messa in discussione: basterebbero le foto degli artisti che si confrontano con i bambini, le relazioni sociali, l’anonimato o meglio il collettivo delle opere, i modi dell’esprimersi. Si parte sempre dal riconoscimento della lingua sarda, adottata ad esempio a Laconi nel 1979 in occasione del processo per la realizzazione di un murale abusivo. Ma sono le strutture della società sarda che emergono e si confrontano sui muri, come se il valore della scelta di ambientare i dipinti in questo paese, come più tardi ad Orgosolo, volesse far partire ogni discorso dal riconoscimento di un’autoctonia e di un’identità come valori assoluti, ai quali associare la comunità con una partecipazione democratica, fondata sull’antimilitarismo come a Pratobello e sulla pace. Dunque i temi prescelti, il lavoro, il riposo, la festa, gli animali, una forma forte e collettiva di arte, un laboratorio figurativo dell’identità contadina, scoperta e valorizzata perché portatrice di un patrimonio culturale fin là non compreso. La Sardegna dunque come polo prezioso di un rapporto con il cosmopolitismo degli artisti e dei soggetti coinvolti, come espressione dell’arte popolaresca in rapporto ai grandi professionisti.
Oggi San Sperate conserva poche tracce di quella stagione straordinaria, anche se il fiorire di Bed & breakfast, la nascita dell’ufficio turistico gestito dalla cooperativa Fentanas, lo sviluppo del sistema cooperativo, rappresentano uno degli effetti di una crescita che è stata anche economica, ma soprattutto culturale, fondata sull’orgoglio di appartenenza ad una comunità che si è messa in sintonia con la vicina capitale Cagliari, che è stato il polo di riferimento lontano sempre sullo sfondo, la misura del rapporto tra la periferia e il centro, tra la campagna e la città.
Mi ha commosso la testimonianza di Cenzo Porcu, orgoglioso per le parole del figlio che ha scoperto qualcosa del padre in ogni angolo di San Sperate, un paese che conserva il senso di una lunga primavera, che ha saputo costruire – scrive Ottavio Olita – una coscienza, la voglia di riscatto, il bisogno di essere protagonista della propria storia.
In questi giorni Pablo Volta ha pubblicato per la Ilisso il volume Sardegna come l’Odissea: un’opera straordinaria scritta a San Sperate, dove il celebre fotografo italo argentino ha scelto di vivere dal 1987. Un’opera che conferma come proprio l’incanto della Sardegna abbia toccato il cuore degli artisti di allora.
NO ?
Nel capitolo Un paese ignorato dalla storia, Ottavio ricostruisce attraverso le parole di Enrico Milesi su La grotta della vipera la lenta evoluzione della piccola villa medievale di Ortixedru, l’orto del cedro, divenuto San Sperate già prima del XV secolo: il nuovo nome è stato un poco superficialmente collegato all’asparago, su sparau. Più credibile è il collegamento col martire africano Speratus, il capo dei famosissimi martiri scillitani uccisi a Cartagine alla fine del regno di Marco Aurelio: le sue reliquie sarebbero state trasportate in Sardegna da uno dei vescovi esiliati dal re vandalo Trasamondo all’inizio del VI secolo, mentre a Cagliariu era vescovo il pio Brumasio, se è vero che il paese campidanese ha preso il nome da questo santo. Un bambino Speratus morto a 14 anni è ricordato a Cagliari nel VI secolo ed un presbitero Isperate è menzionato nel con daghe di San Pietro di Silki attorno al 1200, come se i fedeli sardi avessero assunto il nome del venerato martire africano.
Molti dubbi possono avanzarsi invece sull’autenticità della lapide un tempo conservata nella parrocchiale di San Sperate, trascritta nel Seicento, che attribuiva al vescovo Brumasio la traslazione delle reliquie:
hic sunt reliquiae sancti Sperati et aliorum mi— martiribus a Brumasio episcopo.
Come è noto Brumasio potrebbe essere lo stesso vescovo di Cagliari Brumasius Primasius che accolse Fulgenzio e gli altri vescovi esiliati da Trasamondo in Sardegna (vita Fulgentii 24). Ricordato in tre Sermoni cartaginesi di Sant’Agostino, Sperato ed i suoi compagni hanno forse ispirato Pinuccio Sciola per la statua di Sant’Agostino collocata nel quartiere della Marina a Cagliari per volontà di don Vincevo Fois e della comunità parrocchiale, presso l’antica chiesa che ricorda la traslazione in Sardegna del corpo del vescovo di Ippona.


