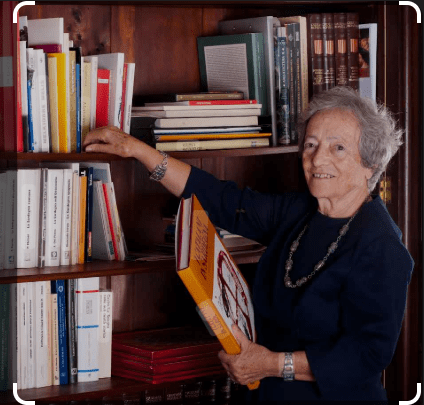Il volume di studi in memoria di Renata Serra, Cagliari, 27 ottobre 2023. Sala del Consiglio Comunale
L’intervento di Attilio Mastino
Il più lontano ricordo che ho di Renata Serra risale alla fine degli anni 60, a Sa Duchessa, nello studio della sua amica Giovana Sotgiu, la mia maestra, che ieri ha compiuto 98 anni di età e che vi saluta tutti con affetto. Con entrambe – la Serra e la Sotgiu, accompagnati da Franco Porrà – nell’estate 74 sono stato a Dubrovnik Ragusa nell’ex Jugoslavia di Tito, per il convegno internazionale Eirene, in un hotel megagalattico che non mi potevo permettere e infatti pranzavamo in camera con i prodotti arrivati da Sinnai: ricordo le interminabili e per me defatiganti visite ai negozi di antiquariato nel corso principale, mille vetrine di artigianato artistico in argento una dopo l’altra, e il colpo di mano di Renata che mi aveva anticipato l’ultimo giorno e aveva acquistato un gioiello straordinario, un ragno d’argento con la sua ragnatela preziosa che intendevo regalare a mia zia Vincenza: Lo stavo già pagando. Me lo portò via sotto gli occhi senza scrupoli e mi accusò a posteriori, quando il ragno iniziò a perdere le zampe, che la colpa era la mia invidia.
Perché Renata con me è stata soprattutto questa, con un rapporto ironico e pieno di sorrisi, che è diventato pian piano di amicizia vera, con lei e con Alberto Deplano, come sul colle di Corchinas a Cornus assieme a Franco Porrà, a Giovanna Sotgiu, alla professoressa di sanscrito Anna Radicchi, quest’ultima esausta a pranzo tanto da scongiurarmi di evitare altre escursioni “in montagna”. Renata non si stancava mai, come in Tunisia e in Algeria dove aveva studiato le basiliche paleocristiane; soprattutto in Sardegna, dove aveva i suoi amici veri, i suoi allievi, i suoi artisti prediletti.
Ce li faceva conoscere nella Scuola di studi Sardi diretta da Giovanni Lilliu, studiando con Marcella Bonello la cattedrale di Santa Giusta, oppure con Mimma Olita e Antonella Mione i due dipinti settecenteschi del Duomo di Cagliari con una relazione pubblicata su Studi Sardi del 1979 o le tante piste seguite con l’allievo prediletto Aldo Sari ad Alghero e in tutta l’isola; con Paolo Benito Serra a Fordongianus; con Gianni Tore, con Anna Maria Saiu, con Alma Casula. Ci parlava dei suoi maestri, Raffaello Delogu, Renato Salinas, Corrado Maltese, Alberto Boscolo. Raccoglieva un’enormità di schede con le foto di Oscar Savio.
Nel suo primo insegnamento a Carbonia e Iglesias aveva conosciuto Don Leone Porru, con il quale avrebbe poi studiato il santuario sulcitano e i suoi frammenti scultorei, le sue pitture, la tradizione relativa ad Antioco arrivato dalla Mauritania in sulcitana insula Sardiniae contermina su una parva navicula.
E poi a Cagliari don Vincenzo Fois che conoscevo da ragazzo nel CSI, rettore di S. Agostino, scomparso nel 2020: una figura di sacerdote capace di coinvolgerci tutti, fino a Pavia, l’antica Ticinum, per le reliquie trasportate dai monaci inviati a Cagliari da Liutprando, che le aveva acquistate e fatte prelevare dal primitivo santuario alle nostre spalle dove il corpo di Agostino restò per oltre due secoli, più tardi collocato nella splendida arca marmorea voluta dai Visconti: lì in San Pietro in ciel d’oro ho visto recentemente una scultura di Pinuccio Sciola donata da Don Vincenzo, che rappresenta il vescovo di Ippona nel suo letto di morte.
A Sassari mi aveva sorpreso l’amicizia profondissima con il canonico del Duomo Pietro Desole autore del bel volume sulla Cattedrale di San Nicola, i retabli, il dipinto della crocefissione, il paliotto, la rappresentazione dei martiri turritani nel bassorilievo marmoreo del presbiterio seicentesco sopraelevato: scene che ricordano da vicino gli scavi a Torres promossi dall’arcivescovo Manca de Cedrelles e si sono ispirati alle statue della cripta del San Gavino che rappresentano i sancti innumerabiles.
A Bosa per la cattedrale di San Pietro, tema della mia relazione per la Scuola di specializzazione che rilesse accuratamente che la Serra volle pubblicata dopo averla riletta accuratamente; il tema è oggetto del bellissimo articolo di Bruno Billeci. E poi ancora a Bosa per il tesoro del duomo con questo reliquario cinquecentesco di bottega cagliaritana; oppure nel castello dei Malaspina, correggendo la lettura degli affreschi di età giudicale, con Mariano IV; a Sagama per l’attribuzione a Nino Pisano dell’Arcangelo Gabriele.
A Cabras con Raimondo Zucca, per la chiesa bizantina di San Giovanni di Sinis oppure nel duomo di Oristano.
Il dolore più grande dieci anni fa per la scomparsa dell’allievo Roberto Coroneo, Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, che aveva ricordato con emozione sulla rivista “Domitia” nel 2014, ripercorrendo una strada di formazione e di continuo confronto, ricordando i mille successi, l’apprezzamento generale e il rimpianto di tutti i colleghi.
A Sinnai con Cecilia Contu e gli eredi di Anselmo Contu che a mio avviso sono alla base di questo sconfinato amore per la Sardegna, quando si trattava di costruire dalle fondamenta, dopo Raffaello Delogu, una disciplina che si era limitata quasi esclusivamente all’architettura: si aprivano praterie su tanti campi della storia dell’arte in Sardegna, la pittura, la scultura, l’oreficeria. Sullo sfondo mi pare ci fosse una visione aperta, progressista, sardista, che si manifesta ad esempio nell’inedito carteggio di Emilio Lussu per l’Archivio Storico Sardo del 2018.
E poi gli artisti, da Costantino Nivola a Pinuccio Sciola a San Sperate, che aveva conosciuto per il tramite di Salvatore Naitza e di Alberto Rodriguez, quando il paese contadino del Campidano è uscito da un sonno millenario, quando i suoi abitanti tutti all’improvviso si sono appassionati di arte, hanno creduto nella rivoluzione del sorriso, hanno compiuto un percorso culturale che è stato anche un’esperienza collettiva che oggi possiamo riconoscere ormai entrata nella storia della Sardegna. Ne ha parlato nel volume intitolato Il legno, l’argilla, la pietra. Sculture di Sciola tra il 1960 e il 1990. Fino ad arrivare negli ultimi anni a Mariano Chelo, l’artista che gli avevo fatto conoscere e che ha lo studio in Via Garibaldi, proprio accanto alla bella casa di famiglia in pieno centro, casa che mai ha voluto lasciare. Qui sono esposte le opere un po’ naif di Alberto, con il draghetto colorato beneaugurante che spesso mi è stato donato con grande affetto; mi dicono che ora Alberto si dedica alla gioielleria e alla rappresentazione di barche a vela che navigano su un mare davvero unico.
Le belle pagine di Mauro Dadea in questo volume fortemente voluto dalla Deputazione di storia patria e dall’amica Luisa D’Arienzo colmano oggi una lacuna, ci presentano le tante opere di Renata, riaprono piste e prospettive di ricerca su una storia dell’arte in Sardegna molto allargata dai mosaici tardo antichi del IV secolo fino al medioevo e al Rinascimento: oltre 12 secoli, studiati per nuclei tematici, il contributo originale dell’arte barbarica della Sardegna, prodotto di vere e proprie scuole artigianali poco note; l’età romanica, l’architettura sardo-catalana o gotico-catalana. Oppure i tesori delle chiese partendo da una geografia ricca e rispettosa di tutte le esperienze: dalla chiesa di Bonaria o di San Michele o di San Domenico a Cagliari fino a Telti, Nuxis, Ardauli, Zuri; oppure l’arte giudicale, le innovazioni catalane e spagnole. Infine i maestri, come il Maestro di Ozieri attraverso la lettura del bel volume di Maria Vittoria Spissu allieva di Caterina Virdis. In un momento di sincerità, Renata ammise con me di aver letto un po’ troppo criticamente il volume. Vedo che a Mauro Dadea la questione non è sfuggita.
Poi Pietro Cavaro, il manierismo di Francesco Pinna, fino a Gaetano Cima.
La storia della disciplina, il ruolo di Giovanni Spano; la riflessione sullo stato attuale della ricerca nella storia dell’arte in Sardegna nel tumultuoso incontro in cittadella del 1982, con questa sottolineatura – in Sardegna – che in realtà allagava lo sguardo ad ambito europeo, alle grandi scuole, alle grandi correnti culturali, facendo dell’isola un osservatorio, quasi un crocevia di impulsi differenti.
Nell’articolo che ho scritto pensando a lei, ho tentato di riproporre il tema del rapporto tra i mosaici africani e quelli della Sardegna tanto cari a Renata Serra e a Simonetta Angiolillo, che in questo volume rilegge la villa romana di Capo Frasca: Carales giganteggia come la grande capitale delle province transmarine del regno vandalo, in un quadro cristiano che non rinuncia alla cultura classica pagana e al mito, che popolava ancora la fantasia nei naviganti nel Mare Sardum: sono gli dei pagani che accompagnano il corteo nunziale di Vitula e di Giovanni a Carales, ut ratis incolumis Sardorum litora tangat. L’erba sardonia sarebbe stata addolcita dalle roselline di Sitifis.
Sul rapporto tra pagani e cristiani, come non pensare all’omelia proprio di Sant’Agostino recentemente riscoperta, pronunciata nella basilica della nostra Thignica, Ain Tounga in Tunisia, rivolgendosi i fedeli: Vos ante paucos annos pagani eratis, modo christiani estis, parentes vestri daemoniis serviebant.
Renata Serra ci lascia la sua visione dell’arte, il senso del bello, il gusto per la scoperta: alcune opere monumentali come Pittura e scultura dall’età romanica alla fine del 500 pubblicata da Ilisso nel 1990 con le schede di Roberto Coroneo, i volumi curati per Poliedro, Jaka Book, Electa, soprattutto questa sua fedeltà alle riviste più amate, Archivio Storico Sardo e Studi Sardi; quest’ultima ancora ci manca.
Questo libro ci restituisce una visione del mondo, un metodo di studio, un orizzonte geografico, in qualche modo anche la sua voce.