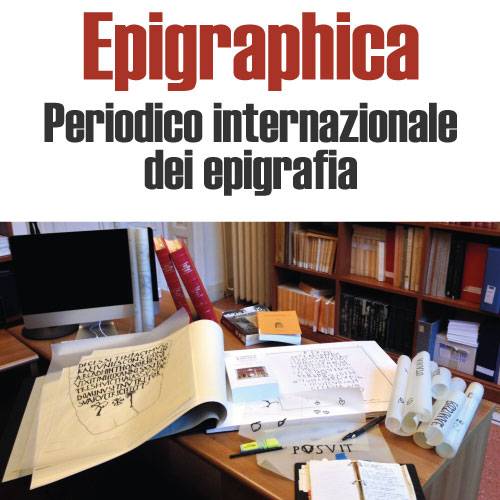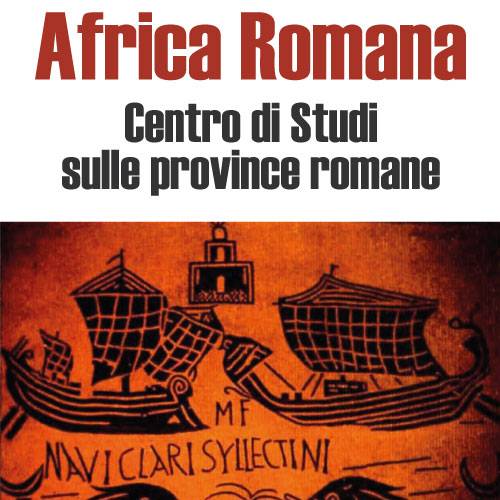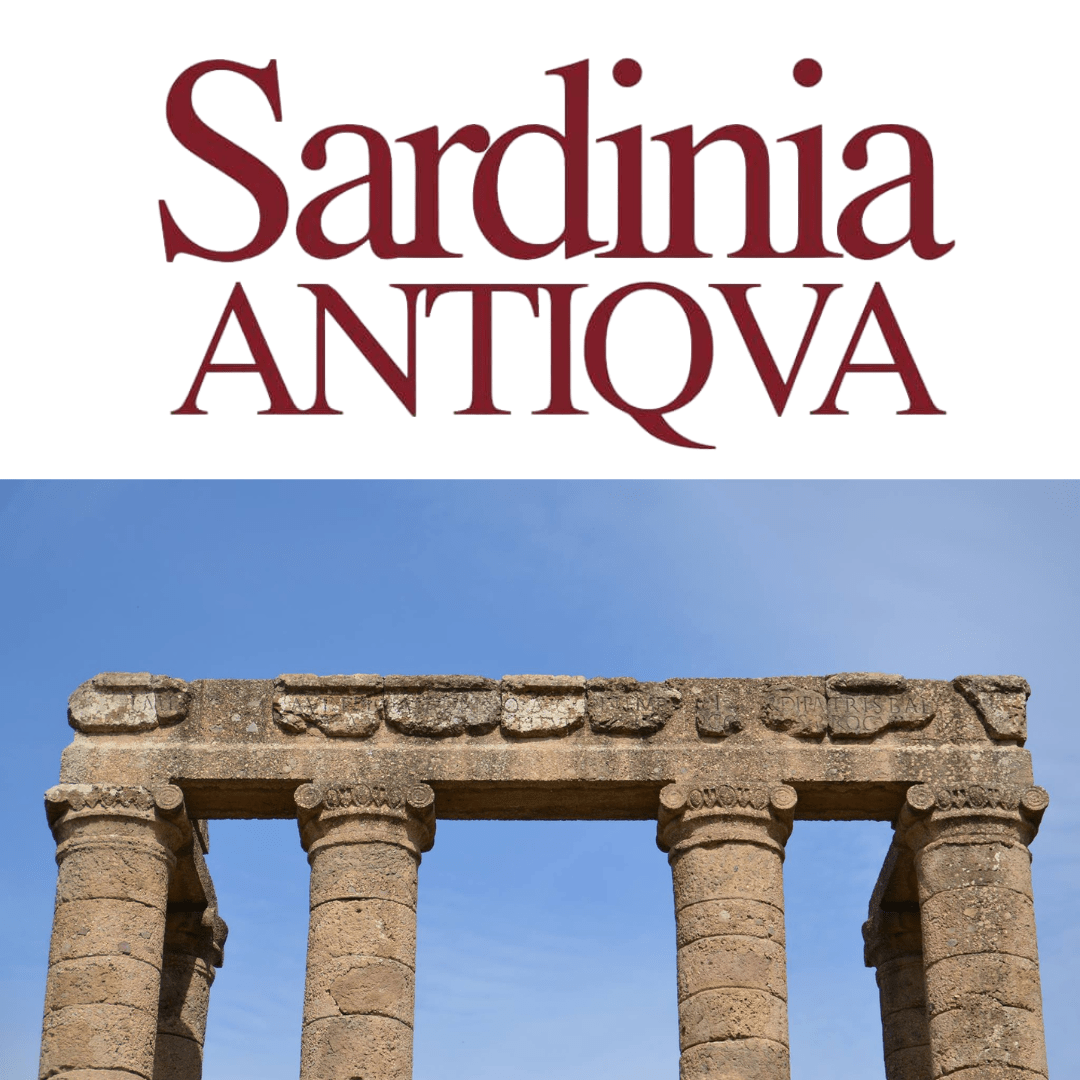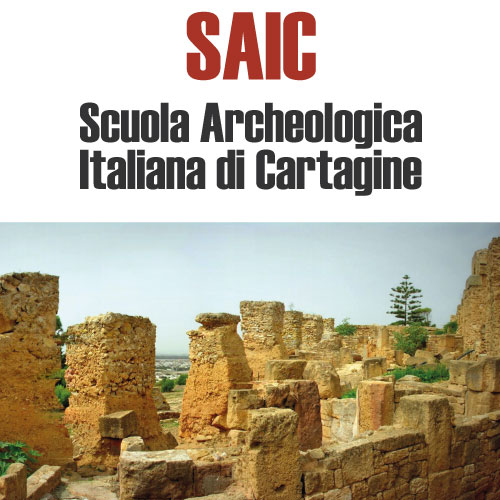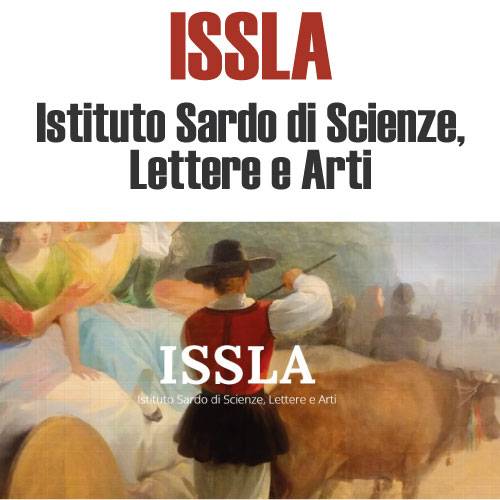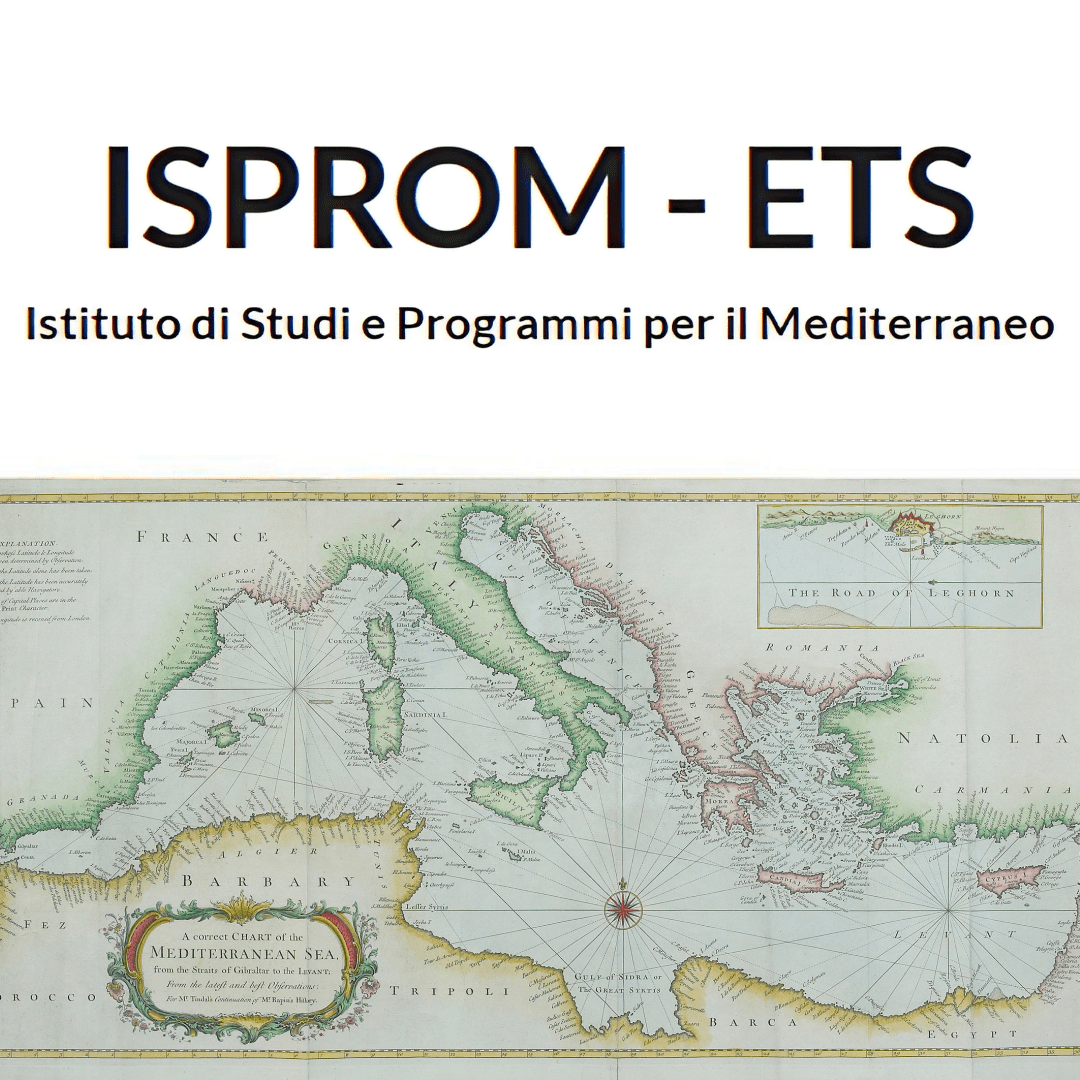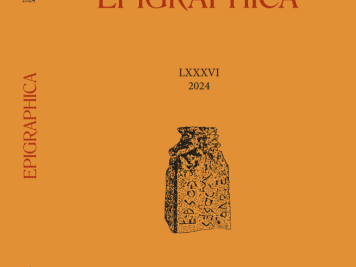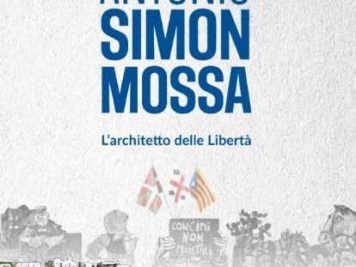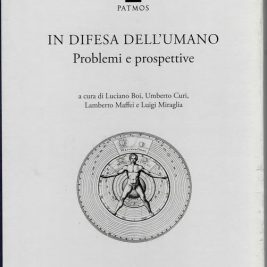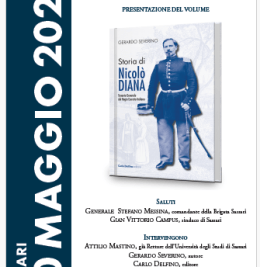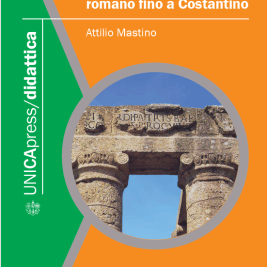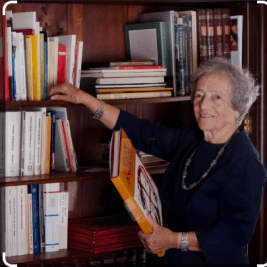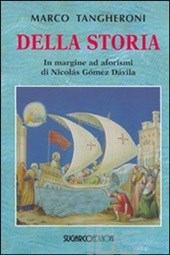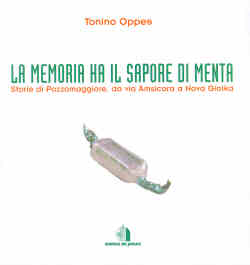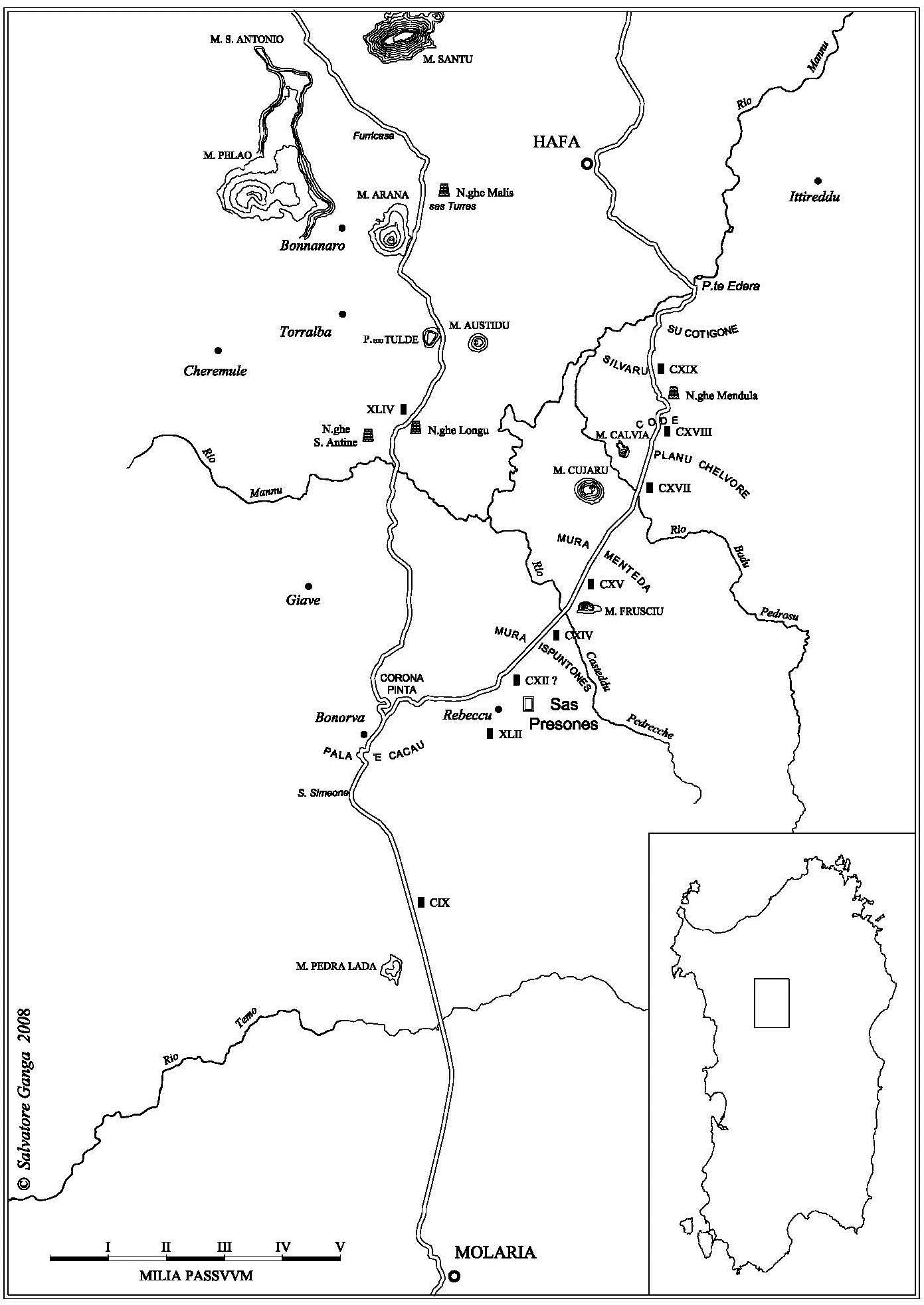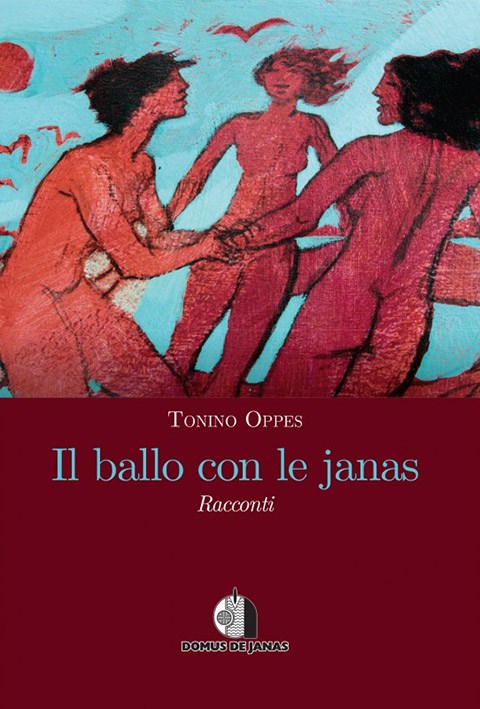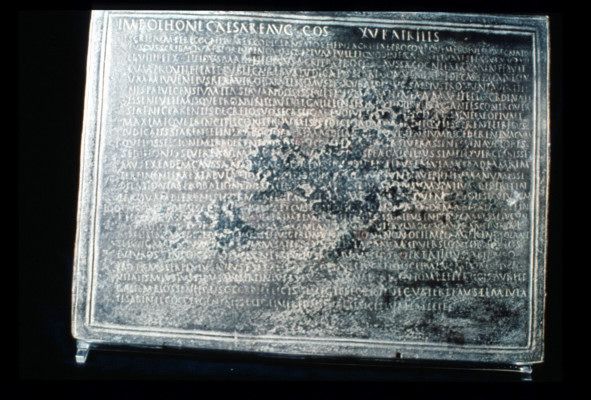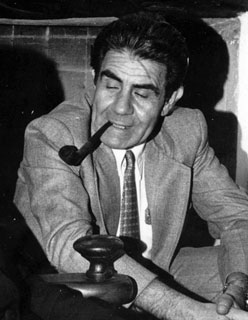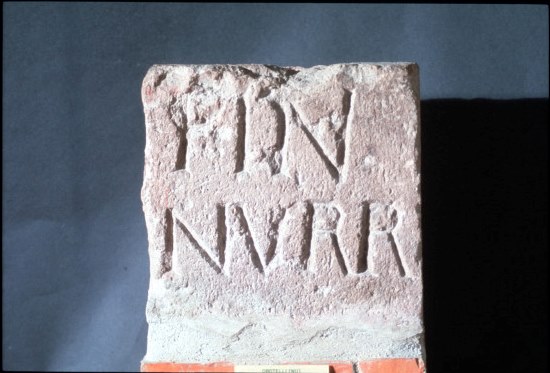Attilio Mastino – Stefania Frau
Jugurtha contre l’impérialisme romain à la tête de la natio des Numidae
Constantine (Algérie), 14 mai 2016
Colloque sur Massinissa
Centre National de Recherche Préhistorique, Anthropologique et Historique.
1. L’admiration de Salluste pour Jugurtha est bien connue. Dans le chapitre VI du Bellum Iugurthinum, juste après l’introduction contre la dégénération morale de la nobilitas romaine, aspect qui provoque en lui une profonde indignation et un dégoût total de la politique, Jugurtha est décrit comme un personnage positif. Jugurtha rappelle sous de nombreux aspects son grand-père Massinissa : dès sa première jeunesse il apparaît physiquement vigoureux, pollens viribus, beau, decora facie, mais surtout doué d’un caractère énergique, sed multo maxume ingenio validus (Iug. 6,1) ; actif et vif. Il ne se laissait corrompre ni par les plaisirs ni par l’oisiveté, non se luxu neque inertiae conrumpendum dedit ; mais suivant l’usage du peuple des Numides, il montait à cheval, lançait le javelot, luttait à la course avec ses amis ; il se consacrait à la pratique aristocratique de la chasse au lion et bien que l’emportant sur tous il était pourtant cher à tous (6, 1). Salluste énumère les qualités du prince numide et suit avec admiration et presque avec enthousiasme son éducation : après son émargination initiale à la cour, Jugurtha parvint ensuite à une position prestigieuse, qui indiquait qu’il était un chef charismatique, un protagoniste destiné à régner grâce à l’exercice de la virtus et à son application et à sa modération ; il était reconnu au centre du système politique et culturel du royaume de Numidie.
Selon Tite Live, Massinissa, élevé à Carthage mais profondément berbère, possède lui aussi ces qualités : il n’existait pas dans toute la Numidie de chevalier plus courageux; personne ne résistait mieux que lui à la fatigue et aux longues chevauchées dans le désert sans boire ni manger. Sa générosité envers les siens était sans limites, mais il n’avait aucune pitié des traîtres ; les échecs ne le décourageaient pas, il avait confiance en l’avenir et, dès que possible, il recommençait à lutter.