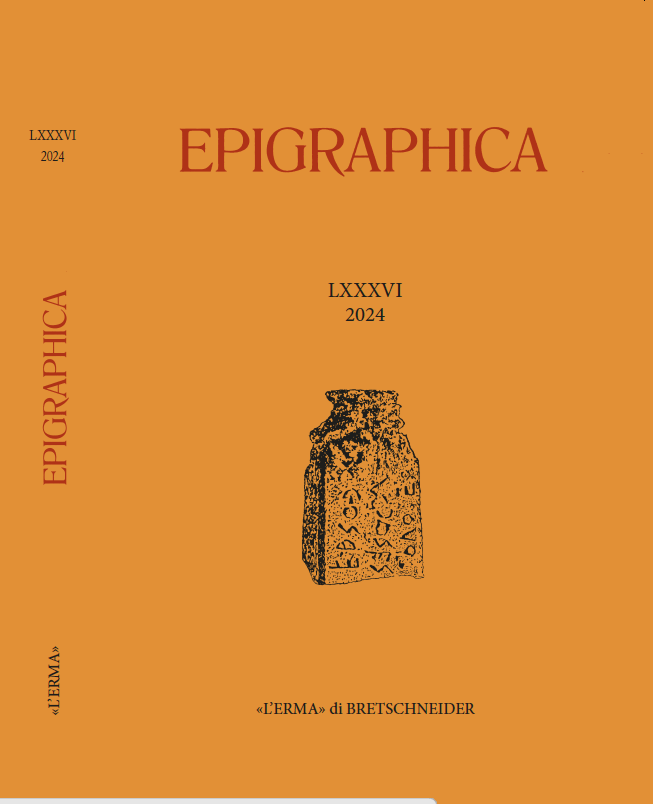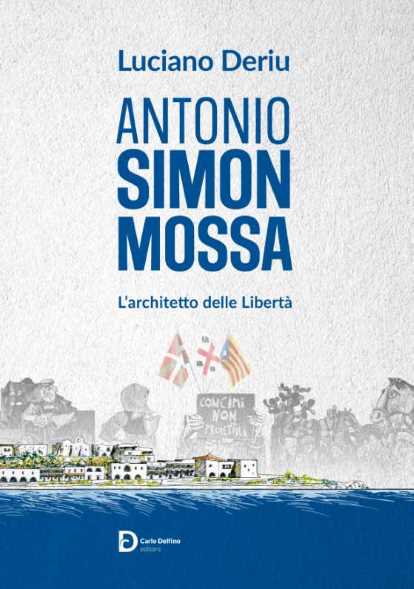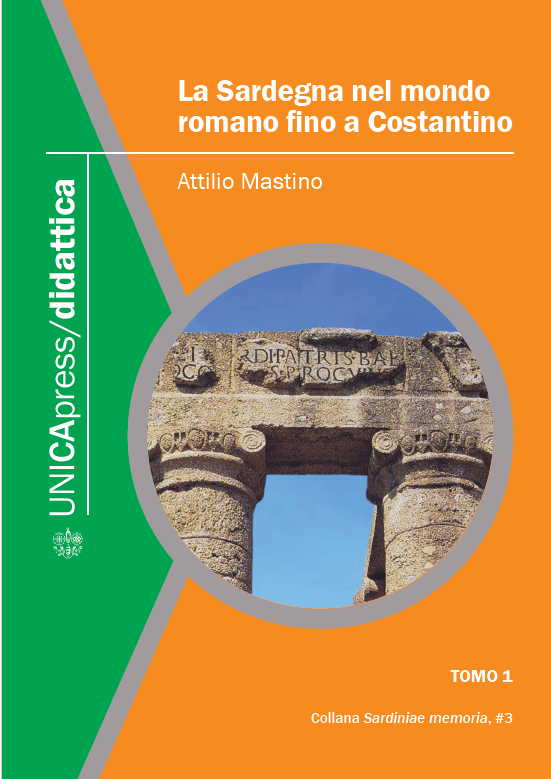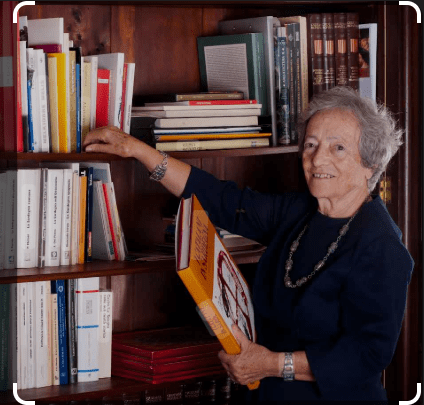FEDE E CULTURA: IL MONDO DI RAIMONDO TURTAS
Storia, lingua e identità
Bitti 22 marzo 2025
La scoperta delle specificità del Cristianesimo delle origini in Sardegna: Raimondo Turtas
Cari amici,
m’immagino che Padre Turtas, se fosse ancora con noi, avrebbe seguito con spirito critico i nostri interventi, per quanto mi abbia sempre difeso da lui uno scudo, quello di essere l’allievo prediletto della mia maestra bittese Giovanna Sotgiu. L’abbiamo ricordata in questa sala quindici anni fa nel convegno promosso da Claudio Farre e Giorgio Rusta – per il quale porto i saluti di Mustapha Khanoussi, ricordando l’accoglienza tumultuosa una mattina presto a Theborsouk (Accabakela, Baluba) Mi ha scritto oggi Giorgio: <<Bongiorno Professó, comente istates? A dolu mannu non bi resesso ca semus in s’Annossata, unu de sos locos de so coro de ziu remunnu, aprontanne sa esta de 25 de Martu>>.

Quando scomparve a Sassari nel 2018 a 87 anni di età lo ricordammo come Maestro rigoroso e severo, amico sincero, esponente di punta del movimento per l’ingresso della lingua sarda nella liturgia, secondo i canoni del Concilio Plenario Sardo e le allora recenti prescrizioni di Papa Francesco. La questione della lingua e della cultura della Sardegna è centrale per inquadrare la sua figura atipica e sarà approfondita nel corso di questa giornata: per Turtas la lingua sarda derivata direttamente dal latino volgare, con questo particolare carattere conservativo nel centro montano, può essere oggi una risorsa irrinunciabile e un simbolo della profondità della storia e della capacità di elaborazione anche poetica e musicale delle comunità locali. Oggi diamo per acquisto un radicamento territoriale di una lingua sarda che mantiene una freschezza e una capacità espressiva innanzi tutto in rapporto con un luogo, con una geografia, con un ambiente naturale e umano; abbiamo raggiunto il senso profondo di una ricchezza che deve essere difesa e coltivata nel rispetto di una storia lunga dove la lingua sarda è anche pensiero, riflessione, strumento per intendere la realtà, per entrare in comunicazione profonda con gli altri, per identificare un’appartenenza. Tra i ricordi più luminosi che conserviamo c’è la partecipazione alla Santa Messa per S’Annossada, nell’antico santuario di Bitti caro alla sua famiglia, dove Turtas pronunciava le sue straordinarie omelie in una lingua che ci emozionava per essere limpidamente legata al latino, in occasione della festa: un momento intenso per tornare commossi alle sue origini lontane. Eravamo arrivati in tanti da Sassari venticinque anni fa per ascoltarlo: quando finalmente cominciò l’omelia – ero anni che attendevo di sentirlo – fu interrotto da una turista sgarbata che diceva che il figlio non capiva una parola. Sappiamo tutti che Turtas non era un uomo che si faceva impressionare, e dunque continuò imperterrito in Sardo promettendo una traduzione in italiano alla fine della messa. Sorridevamo leggendo alla fine degli anni 80 i suoi interventi sull’Ortobene, quando sparava con la mitragliatrice sui vescovi per le lentezze del Concilio Plenario Sardo fin dall’insediamento in Ogliastra delle commissioni antepreparatorie per la Missa in limba, considerata essenziale per riconoscere uno specifico identitario. Terminato vent’anni dopo il lunghissimo Concilio effettivamente aperto solo nel 1992, la mitragliatrice fu imbracciata di nuovo dopo il 2001 per sparare ancora sui vescovi questa volta perché, alla rovescia, non davano attuazione ai decreti sinodali – pure prudentissimi – sul tema del rapporto tra l’universalità della chiesa di Dio all’inizio del terzo millennio e la dimensione locale. Conoscendo bene la proposta elaborata dal parroco di Bulzi don Francesco Tamponi, Turtas riteneva che il cammino verso la piena valorizzazione della lingua sarda presonera tra nuraghes e baddes soliànas (G.M. Dettori) – marginalizzata nel contesto religioso – sia stato segnato da numerosi ostacoli, non solo legati alla tradizione liturgica, ma anche da una visione di inferiorità culturale che ha accompagnato la lingua sarda, percepita come “minore” rispetto ad altre lingue. Del resto lo ha ribadito nei giorni scorsi ancora una volta la CEI. Turtas credeva positivamente all’identità del popolo sardo anche in campo religioso, apprezzava la fase sperimentale in atto per Sa die de Sa Sardigna in tema di Missa in limba; per riprendere categorie care a Bachisio Bandinu ha contribuito a costruire l’autostima dei Sardi e perfino arrvava ad ammettere che alcuni retaggi pagani (la superstizione e la magia, il concetto distorto di giustizia) potessero ancora sopravvivere in Sardegna e richiedessero dunque una chiara strategia locale fondata sulla coscienza critica e sulla riscrittura della storia senza una tesi preconcetta e una finalizzazione obbligata. Io arrivo anche a dire che forse non avrebbe apprezzato molti concetti astratti elaborati dagli antropologi e imprudentemente accolti in una delle ultime encicliche di Papa Francesco (Fratelli tutti 148) a proposito dell’esigenza del meticciato – un’espressione orrenda per il tempo che abitiamo. Tanti episodi: la visita al nuraghe Loelle, a Su Romanzesu con Giosué Ligios, nella sua casa a Sassari in viale Dante, dove aveva cucinato per noi.
Del resto con molti di noi si era scontrato frontalmente, come in occasione delle celebrazioni per i 450 anni dell’Università volute dai nostri colleghi storici delle istituzioni, partendo da quel 1562 della nascita del collegio gesuitico, data che lui stesso aveva messo in copertina del volume dedicato alla Casa dell’Università presso la chiesa di San Giuseppe (La Casa dell’Università. La politica edilizia della Compagnia di Gesù nei decenni di formazione dell’Ateneo sassarese (1562-1632)): arrivavano Giorgio Napolitano e Gianfranco Fini e chiaramente la polemica interna rischiava di creare un imbarazzo che generosamente non volle suscitare, tacque e poi ribadì comunque che l’avvio dei corsi di Filosofia e Teologia era avvenuto solo nel 1612 e vent’anni dopo la trasformazione del Collegio in Università di diritto regio.. E aveva anche ironizzato sull’uso incrociato delle parole sigillo o di stemma che facevamo per richiamare i martiri Gavino e Gianuario di Turris Libisonis nel sigillo storico disegnato dal pubblicitario Gavino Sanna, che poi rettificammo di comune accordo.
Dunque non trattava temi locali, considerati da tanti inferiori o di nicchia: del resto le tappe della sua formazione sono davvero internazionali, dopo il Seminario di Cuglieri dove conobbe il caro Mons. Antonio F. Spada: Gallarate – presso l’Istituto filosofico Aloysianum tra il ’59 e il ’63, dove ottenne la Licenza in Filosofia, poi Lione – presso la Faculté de théologie, Fourvière – compiendo ricerche sulla storia della teologia medievale. Tra il 1965 e il 1969 studiò a Roma presso la Pontificia Università Gregoriana, nella Facoltà di Storia ecclesiastica, giovandosi del confronto con i più grandi maestri; infine dal 1967 risiedette a Londra presso l’Institute of Historical Research, dove si dedicò alla storia delle missioni protestanti inglesi dalla fine del secolo XVIII conseguendo nel 1972 il titolo di “doctor in Historia ecclesiastica”.Ho un mio ricordo – ho visto non errato – di una lunga missione in Madagascar prima di tornare in Sardegna.
Con questo incredibile retroterra culturale, nello stesso anno arrivava finalmente alla Facoltà di Magistero di Sassari appena costituita, poi di Lettere e Filosofia, inizialmente assistente incaricato di Storia Contemporanea, poi titolare di Storia moderna (1977) e di Storia della chiesa (1984). Sono convinto che proprio l’esperienza interazionale abbia pesato per guardare con occhi nuovi alla Sardegna, alla sua posizione nel Mediterraneo, al valore della cultura e dell’identità locale, alla necessità di una riforma degli studi che scoprisse strade nuove. Ecco la sua partecipazione ai Convegni de L’Africa Romana, come a Nuoro per il IX convegno del 1991 quando presentò una relazione sui rapporti tra Africa e Sardegna nell’epistolario di Gregorio Magno (509-604) oppure le note sul monachesimo in Sardegna fra Fulgenzio di Ruspe e Gregorio Magno sulla Rivista della storia della chiesa in Sardegna del 1987, la nascita delle prime diocesi ben prima di Costantino e i loro territori come per Sulci su Sandalion nel 1995. Il convegno su Eusebio curato da me con Giovanna Sotgiu e Natalino Spaccapelo nel 1996 dove parlò degli informatori sardi di Gregorio Magno. Tutti temi che avrebbero avviato approfondimenti da parte sua e dei suoi allievi, fino ai giorni nostri, con il prezioso spunto sulle provincie ecclesiastiche e i confini territoriali subprovinciali della Sardegna pre-giudicale. Basta sfogliare però il suo capolavoro, il volume del Giubileo (Storia della Chiesa in Sardegna. Dalle Origini al 2000, oltre mille pagine) per capire quanto fosse stata accurata le revisione critica delle fonti, la severità verso i falsari e la valutazione puntuale degli studi precedenti; con l’impegno di aggiornare periodicamente l’opera che costituisce anche per l’età antica un punto di vista essenziale, integrata col volume su Gregorio Magno di Tomasino Pinna del 1989. Non mi azzardo a parlare dei campi di sua diretta competenza, l’età medioevale e moderna. Dopo il pensionamento nel 2003 scrisse ancora su Gregorio Magno: La situazione politica e militare in Sardegna e Corsica secondo il Registrum epistolarum di Gregorio Magno del 2007;e sui Gesuiti: I Gesuiti in Sardegna. 450 anni di storia (1559-2009), del 2010. Alla fine, su incarico del Rettore, era impegnato nell’edizione di un imponente corpus documentario per la Storia dell’Università di Sassari e nella revisione del suo volume principale.
Il lettore coglie l’attenzione inusuale in un manuale di storia della chiesa per il rapporto tra la provincia romana e il Barbaricum, attenzione che era fondata sulle sue origini bittesi e sulla lunga riflessione critica, come quando ad Orune visitammo in gruppo gli scavi di Alessandro Teatini nella località alpestre di Sant’Efis, tra le polemiche con la Soprintendenza. Qui passava la strada direttissima Olbia Carales che toccava secondo l’Itinerario Antoniniano la stazione di Caput Thyrsi, a S di Buddusò: strada rifatta verso il 365 da un personaggio centrale come quel governatore Flavio Massimino che sappiamo da Ammiano Marcellino amico e sodale di un mago sardo che riusciva ad evocare i morti e, grazie ad essi, indovinare il futuro e compiere malefici: il padre del preside Flavio Massimino (che conosciamo attraverso i miliari barbaricini) aveva acquisito nel Barbaricum dacico la capacità di interpretare il volo e il canto degli uccelli, gli augurales alites e i cantus oscinum: proprio grazie a queste competenze ornitomantiche che gli provenivano dalla cultura barbarica di origine (carpico-gotica), suo padre aveva predetto al figlio Maximinus un futuro di grandi successi nella carriera, ma alla fine una morte per mano del boia. Cosa che avvenne realmente nell’età di Graziano, dopo l’uccisione del mago sardo che gli era stato amico. C’è davvero la cultura tradizionale della Sardegna interna, il mondo della magia, la devozione per Diana e Silvano, i demoni del bosco oscuro di Sorabile, l’attuale Fonni; le tabellae defixionum con le maledizioni, alcune in osso come a Sulci o in piombo come ad Olbia che cita i malos homines da ligare oppure ad Orosei dove è ripetuta per tre volte a parola nur(a)go (?), collegata forse con la parola di sostrato nurak, che ricorre sulla Campeda di Molaria o a Posada. Infine a Nulvi dove registriamo la triplice invocazione ad un dominus, il dio degli inferi, rogo: tutti cimeli (cofanetti di piombo scritti con all’interno delle ossa) che ci hanno conservato le maledizioni nei confronti dei nemici, i ladri, i malvagi, gli abigeatari. Sembra di trovare la Sardegna arcaica coi suoi problemi specifici e le sue virtrù descritta anche di recente da Bachisio Bandinu. Un quadro analogo alle defixiones è rappresentato dall’ostracon di Neapolis, dal santuario di Marsia, con l’invito al dio: «O Marsuas di Neapolis, rendi misero (?), muto e sordo Decimo (?) Ostilio Donato, per quanto tu possa rispondere all’uomo». Possiamo riferire ad uno stesso ambito culturale le pratiche oracolari, gli anatemi con l’invocazione a Cagliari del demone Abraxas (l’Anticristo indicato in col numerale greco 365), il culto dei morti, fino ad alcune pratiche magiche documentate nella età paleocristiana, quando operavano dei maléfici, indovini e stregoni capaci di gestire forze oscure e potenti (Fulgenzio, Epistol. XIII; Gregorio Magno, Ep., IX, 205). Coinvolti risultano anche esponenti della chiesa sarda, come il chierico Paolo in maleficiis deprehensus (Gregorio Magno, Ep. IV, 24). Possiamo aggiungere, ben distinto, il piombo di Cornus con l’invocazione greca a Salàmazaza legato a Mitra. Infine le invocazioni per respingere il demonio come quella con l’ordine di tenersi lontano dai corpi dei soldati della caserma del centurione Longino a Carales: +. / Hic abes a do/mino diabule + Oppure l’iscrizione di Tharros che augura la lebbra ai violatori della tomba prima del giorno del giudizio: Si [quis] / (h)anc sepultu[ram] ebertere bolu[erit] (h)abeat parte(m) c[um] Iuda et lebra[m] G(iezi). In un quadro sardo vorremmo collocare anche il richiamo minaccioso al giorno del giudizio di Porto Torres: —— / [— coniuro oppure adiuro] / per diem trem[endu]m iudicii [quo ?] / anima ventura [ut] nullus audea[t in] / sepultura mea [mole]stare ossa m[ea].
Se torniamo per un momento ad Orune, proprio gli scavi di Sant’Efis hanno squarciato un velo sul secolo successivo e restituito la moneta di Valentiniano III, con i resti della strada e la splendida lampada vitrea del Museo Nazionale Sanna con la scena di traditio legis: Cristo consegna la legge a 6 dei 12 apostoli inviati ad evangelizzare il mondo, giungendo dunque fino al Barbaricum della Sardinia. Oggetto che è quanto di più elegante e curato si possa immaginare per una chiesa sarda ancora alle origini, nel terribile momento del passaggio dal paganesimo al cristianesimo, quando secondo l’Agostino dell’omelia di Thignica recentemente riscoperta i fedeli erano ancora schiavi delle passioni pagane: Vos ante paucos annos pagani eratis, modo christiani estis, parentes vestri daemoniis serviebant. Così in Sardegna c’erano i provinciales cristiani che non servivano più i demoni e c’erano i barbari dell’interno, alcuni battezzati come l’Ospitone di età bizantina, anch’essi ormai aperti alla nuova religione.
Nel volume del Giubileo ci sono interamente queste premesse, se si pensa che Turtas è riuscito forse tra i primi a dare una sintesi della situazione sociale della Sardegna durante le persecuzioni utilizzando le nuove scoperte nell’atrio metropoli di San Gavino di Porto Torres: appare ora luminosamente la conoscenza delle Sacre scritture, riprese nelle nuove epigrafi, con questa rivalutazione della figura femminile come quella domina Flavia Cyriace che possedeva un patrimonio che volle lasciare ai poveri e non ai suoi eredi e con un ribaltamento rispetto all’Atilia Pomptilla pagana della Grotta delle vipere di Cagliari, perché qui non è la donna che offre la sua vita per la salvezza del marito, ma anzi è il marito Demeter che si augurava invecchiando di poter lasciare il suo spirito nelle braccia dell’amata (nam et ego optabam in manibus / tuis anans spiritum dare). Essa è casta, solerte guardiana, delle più belle doti ornata, ai poveri lascia ora ogni suo bene e non ai suoi eredi, in un periodo che è sicuramente il IV secolo, visto che successive sono le due iscrizioni datate con anno consolare al 395 (Musa) e al 415 (puer Victorinus fidelis).
Questa attenzione per i poveri in una provincia sottoviluppata come la Sardegna, dove la povertà doveva essere particolarmente diffusa, ci rimanda alla situazione sociale delle città in una terra caratterizzata da forti differenze sociali che tornano nell’epitafio scoperto proprio 25 anni fa di Matera: dopo la dedica iniziale pagana (Agli dei Mani), si esalta la fede cristiana di Matera, morta settantenne nel IV secolo e forse coinvolta nalla persecuzione dioclezianea. Lei che spesso il popolo considerò soccorritrice degli stranieri. Con il fulgido esempio della sua vita terrena dimostrò anche coraggiosamente alla sua stessa gente che tutti considerava come figli. Non ebbe paura della morte violenta ma superò ogni prova (confidando) in Cristo; a gloria di lei la luce risplenderà con un’aureola perenne; lei che Cristo stesso aveva destinato come genitrice delle madri e degli indigenti. Per ciò il consorte racconta tali cose della dolce compagna. Dove notevole è la distinzione tra il populus dei credenti e il vulgus dei bisognosi.
Sono significativi i riferimenti all’attività caritativa della defunta, indirizzata a favore dei peregrini, delle matres e forse degli orfani, degli inopes, in generale erga omnes: l’attributo auxilium peregrinorum trova un significativo confronto ancora in Sardegna nell’epitafio di Secundus a Olbia, pater orfanorum, inopum refugium, peregrinorum fautor, espressioni che certo alludono alle virtù del perfetto cristiano, ma che hanno fatto pensare ad uno xenodochium, ad un ospizio per stranieri, ad una struttura permanente installata in un’epoca così antica e gestita da Secundus, come sembrano ricordare la moglie Paulina ed il figlio Ianuarius. Il termine pater orfanorum è evidentemente ripreso dal salmo 68: 5-6, perché Dio è Padre degli orfani e difensore delle vedove nella sua santa dimora. L’espressione auxilium peregrinorum si confronta bene – sia pure molti anni dopo – von gli attributi di un Karissimus, amicorum omnium pr(a)estator bonus, pauperum mandatis serviens, sepolto a Tharros nel IV secolo.
Infineprezioso è il riferimento alle opere benefiche tanti esponenti dell’aristocrazia locale a vantaggio degli inopes o dei pauperes, tema che sembra richiamare un fervido impegno di carità cristiana, in particolare verso i mendicanti, in una società caratterizzata da profonde divisioni sociali. In tutti questi casi ci sarebbero elementi per pensare alla parallela esistenza di personaggi inseriti nella classe sociale dei ricchi possessores; gli epitafi di Tharros e di Olbia sembrano conservare un «emblematico elemento di continuità: l’immagine del ricco proprietario, uomo di grande integrità morale, padre degli orfani, rifugio dei poveri, aiuto dei pellegrini». Anche il caso di F(lavia) Cyriace a Turris Libisonis con le espressioni rem suam lpauperibus] linquit nec quidem ipsa po[steris suisl (?) richiama all’ opposizione «povertà in fatto (di) ricchezze vs ricchezza in fatto di costumi», che ha profonde radici nella cultura pagana. Del resto dall’epistolario di Gregorio Magno sappiamo che a Turris in età bizantina il vescovo Mariniano, arrivando fino all’ esarca d’Africa Gennadio, avrebbe dovuto difendere contro il dux Sardiniae Theodorus i poveri della sua Chiesa, in tutti i modi vessati e afflitti da svariate usure: civitatis suae pauperes omnino vexari et commodalibus affligi dispendiis. Matera fu esponente di spicco della comunità turritana, una ricca proprietaria, un’aristocratica sicuramente in grado di far fronte con i propri mezzi ad un’azione caritativa a favore di un ambiente sociale degradato, che avrà avuto anche precisi costi economici.
Tutti temi che tornano con immediata semplicità nel volume di Turtas, che qualche anno dopo si era mostrato possibilista sulla possibilità che l’iscrizione di Adeodata conservi traccia della persecuziome dioclezianea, se la vergine immacolata che porta lo stesso nome del figlio di Agostino è stata a sanctis marturibus suscepta, nel senso che è stata sepolta a Monte Agellu presso la tomba di Gavino, Proto e Gianuario; e aveva anche negato che l’antichissima espressione turritana potesse essere collegata con la tarda e attuale liturgia esequiale In paradisum deducant te angeli, in tuo adventu suscipiant te martyres et perducant te in civitatem Sancatam Jerusalem.
Infine il tema della risurrezione come a Cagliari (non ad Olmedo) per il diacono Silvio che aspetta nella tomba che, grazie alla potenza di Cristo, la sua carne possa vivere di nuovo ed attende di vedere le gioie dell’ultima luce, mentre Cristo finalmente potrà regnare in eterno (Hic situs Silbius ecle/siae sanctae minister / expectat Christi ope / rursus sua vivere carne / et gaudia lucis nobae / ipso dominante videre. / Vixit ann(is) XXXIII d(epositus) in pace nonis / XP April(is) XP).
Se portiamo avanti il ragionamento di Padre Turtas, le categorie difese dai cristiani sardi che guardano con preoccupazione ai problemi della società di una provincia povera e sottosviluppata con forti differenze sociali sono nell’ordine: i poveri, gli orfani, le vedove, i ciechi, i prigionieri, gli oppressi, gli stranieri. Quanto di queste espressioni è riferito alla situazione reale della provincia Sardegna e quanto deriva dalle notissime fonti bibliche ed evangeliche ?
I poveri: Apri la bocca e giudica con equità e rendi giustizia all’infelice e al povero (Proverbi, 31,9).
Perché soccorrevo il povero che chiedeva aiuto, l’orfano che ne era privo. La benedizione del morente scendeva su di me e al cuore della vedova infondevo la gioia (Giobbe, 20, 12-13).
Dio salva il misero dalla spada e il povero dalla mano del potente (Giobbe 5:15).
Dio non porta rispetto all’apparenza dei grandi, non considera il ricco più del povero, poiché sono tutti opera delle sue mani (Giobbe 34, 17).
E Cristo nel discorso delle beatitudini: Gesù, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: “Beati voi che siete poveri, perché il regno di Dio è vostro. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete (Luca 6, 20-21).
Dio ha scelto quelli che sono poveri secondo il mondo perché sono ricchi in fede ed eredi del regno che ha promesso a quelli che lo amano (Giacomo 2:5).
I ciechi e i prigionieri Lo spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri; mi ha mandato per annunciare la liberazione ai prigionieri e il ricupero della vista ai ciechi; per rimettere in libertà gli oppressi (Luca 4:18).
Gli orfani: Non maltratterai la vedova o l’orfano. Se tu lo maltratti, quando invocherà da me l’aiuto, io ascolterò il suo grido, la mia collera si accenderà e vi farò morire di spada: le vostre mogli saranno vedove e i vostri figli orfani (Esodo 22, 21:23).
Imparate a fare il bene, ricercate la giustizia, soccorrete l’oppresso, rendete giustizia all’orfano,
difendete la causa della vedova (Isaia 1,17).
Una religione pura e senza macchia davanti a Dio nostro Padre è questa: soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puri da questo mondo (Giacomo 1:27).
Onora le vedove,quelle che sono veramente vedove. 1, Timoteo 5:3
Gli stranieri: il latino usa il termine peregrinus, che è stato inteso in passato con riferimento alle folle che visitavano le tombe dei martiri. In realtà il termine è generico ed indica gli stranieri di passaggio anche i non credenti, i forestieri, gli immigrati, gli esuli, le persone sradicate dalla propria terra a causa di guerre o carestie:
Ecco ciò che dice il Signore degli eserciti: Praticate la giustizia e la fedeltà; esercitate la pietà e la misericordia ciascuno verso il suo prossimo. Non frodate la vedova, l’orfano, il pellegrino, il misero e nessuno nel cuore trami il male contro il proprio fratello (Zaccaria 7, 9-10).
Il Signore protegge lo straniero, egli sostiene l’orfano e la vedova,ma sconvolge le vie degli empi (Salmo 146, 9).
Poiché, se veramente emenderete la vostra condotta e le vostre azioni, se realmente pronunzierete giuste sentenze fra un uomo e il suo avversario; se non opprimerete lo straniero, l’orfano e la vedova, se non spargerete il sangue innocente in questo luogo e se non seguirete per vostra disgrazia altri dei, io vi farò abitare in questo luogo, nel paese che diedi ai vostri padri da lungo tempo e per sempre (Geremia 7, 5-7).
Del resto Gesù si identifica con lo straniero bisognoso: Ero forestiero e mi avete ospitato… ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo dei miei fratelli più piccoli l’avete fatto ame (Matteo 25)
Infine, permettetemi di ricordare come le recentissime scoperte avvenute in molte località della Sardegna dopo la scomparsa di Padre Turtas hanno confermato molte sue intuizioni: una tra tutte la dignità e la antichità della chiesa sarda, come risulta oltre che dalla posizione del vescovo di Carales al concilio di Arles sotto Costantino, dall’insegnamento di Eusebio poi primo vescovo di Vercelli e del Piemonte pagano e di Lucifero di Carales, dal ruolo dei vescovi arrivati con Fulgenzio di Ruspe in età vandalica, dall’arrivo delle reliquie di Sant’Agostino di Ippona; ancora dalla conoscenza delle Scritture come abbiamo dimostrato e nel testo caralitano del Miserere e di altre preghiere; il tema del giorno del giudizio, della resurrezione, della luce nuova di Cristo; infine dalla dignità della donna nella chiesa sarda, come per Flavia Cyriace, per le Famulae Dei non solo Imbenia, per le monache di San Lorenzo a Carales con l’Abatissa Redempta, del monastero di San Gavino e Lussorio, di S. Erma, di San Vito, quest’ultimo istituito da una Vitula che potrebbe essere identificata con una omonima nobile maura, ricordata dal poeta Draconzio per il matrimonio con Iohannes, con l’auspicio che l’erba sardonia del marito possa unirsi amorevolmente con le roselline di Sitifis. Oggi ad esempio dal testo scritto sul pavimento della villa dei mosaici marini di Porto Torres alla foce del Riu Mannu con la frase agostiniana (IX, 10,26) Deogratias qui praestitiit vitam, che apre uno scenario di incredibile complessità allontanandoci dal Monte Agellu.Del resto gli scavi di Orune avevano già messo in discussione un luogo comune, quello della scarsa evangelizzazione delle campagne sarde, retoricamente evocata da Gregorio Magno.
Credo che oggi dobbiamo dire che con Turtas abbiamo perso un Maestro, uno studioso grande, capace di leggere la realtà della Chiesa in Sardegna con occhio critico ma anche con amore e dedizione, senza rinunciare alla ricchezza della ritualità tradizionale e dell’associazionismo cattolico in tutta l’isola. Per me personalmente è stato punto di riferimento costante, che non lesinava critiche severe ma anche era capace di stimoli e suggerimenti, con amicizia e affetto. Attilio Mastino