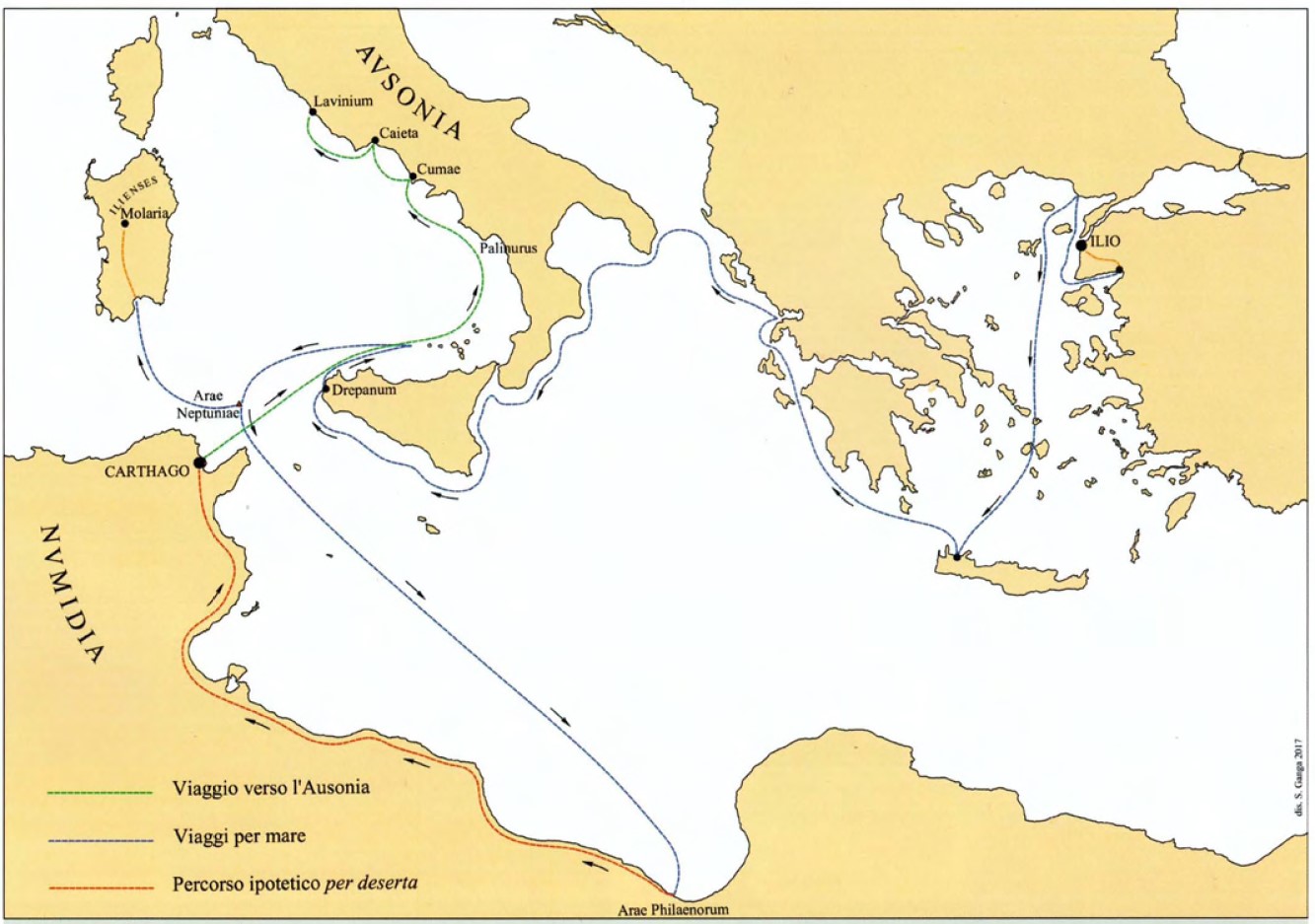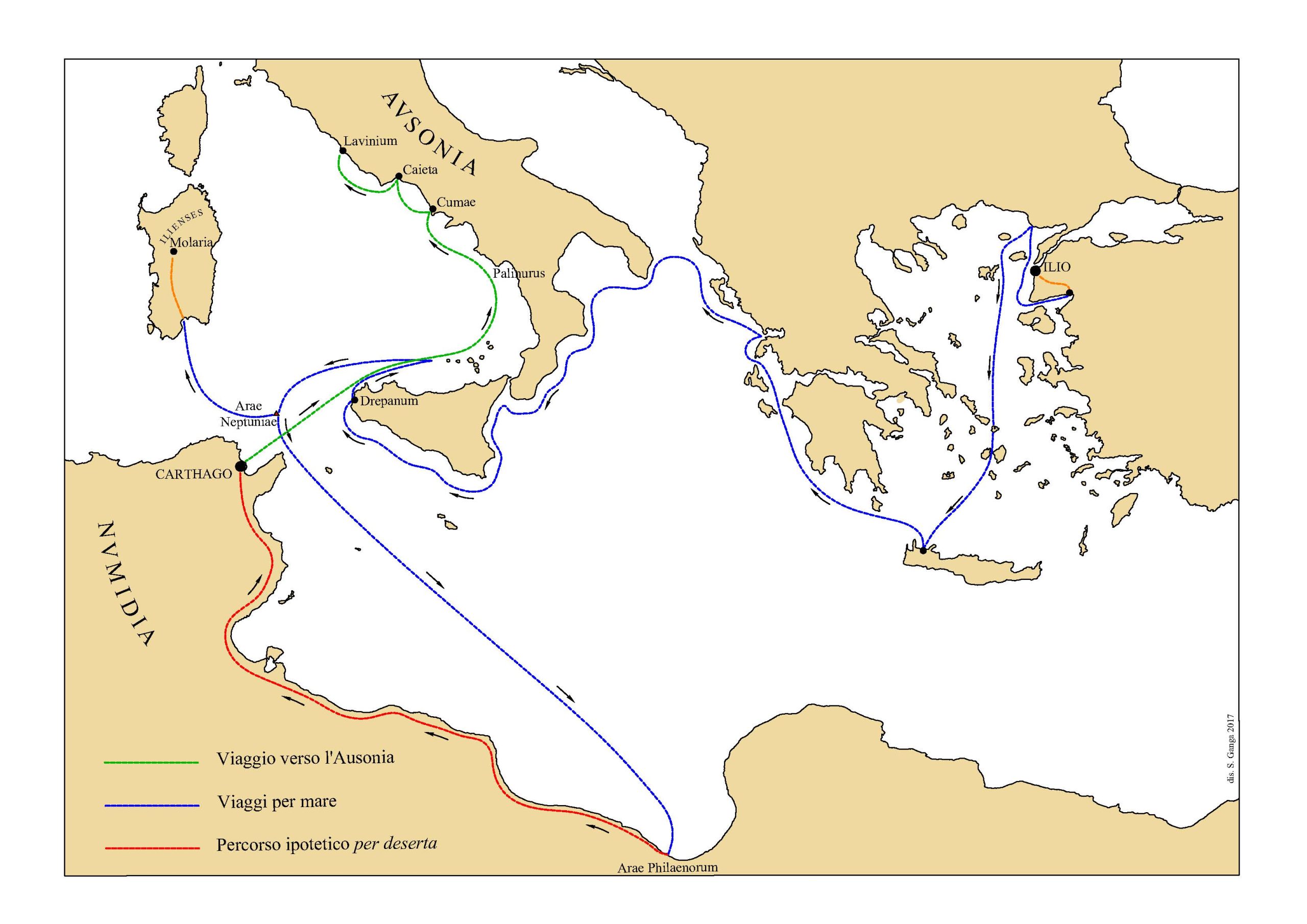Il viaggio di Enea fino a Cartagine.
Presentazione del volume Fare teologia in Sardegna
Attilio Mastino
Presentazione del volume Fare teologia in Sardegna
Per i 90 anni della Facoltà Teologica della Sardegna (1927-2017),
a cura di Tonino Cabizzosu e Daniele Vinci
Studi e ricerche di cultura religiosa, Testi e monografie XIV
Editrice Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna University Press 2017
Cagliari, 19 gennaio 2017
 Desidero ringraziare in apertura il Preside della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna prof. Francesco Maceri per avermi chiamato a presentare – assieme a Fabio Trudu – questo volume di studi pubblicati Per i 90 anni della Facoltà Teologica della Sardegna (1927-2017), a cura di Tonino Cabizzosu e Daniele Vinci, sintetizzando questi ricchissimi 14 articoli, mai interventi di circostanza, mai banali, scritti da colleghi e amici che si sono cimentati in questa impresa, con sguardi incrociati su tanti temi diversi, che ci consentono di penetrare in profondità ma rapidamente nei meccanismi di funzionamento di un’istituzione che è andata acquisendo sempre più prestigio e apprezzamento, e questo soprattutto grazie alla ininterrotta direzione affidata ai Padri Gesuiti e all’azione di tanti studiosi, animatori, collaboratori, che hanno seguito i giovani seminaristi tra Liceo e Facoltà, pieni di spirito cristiano e di passione civile.
Desidero ringraziare in apertura il Preside della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna prof. Francesco Maceri per avermi chiamato a presentare – assieme a Fabio Trudu – questo volume di studi pubblicati Per i 90 anni della Facoltà Teologica della Sardegna (1927-2017), a cura di Tonino Cabizzosu e Daniele Vinci, sintetizzando questi ricchissimi 14 articoli, mai interventi di circostanza, mai banali, scritti da colleghi e amici che si sono cimentati in questa impresa, con sguardi incrociati su tanti temi diversi, che ci consentono di penetrare in profondità ma rapidamente nei meccanismi di funzionamento di un’istituzione che è andata acquisendo sempre più prestigio e apprezzamento, e questo soprattutto grazie alla ininterrotta direzione affidata ai Padri Gesuiti e all’azione di tanti studiosi, animatori, collaboratori, che hanno seguito i giovani seminaristi tra Liceo e Facoltà, pieni di spirito cristiano e di passione civile.
I loro nomi, il loro impegno, la loro fatica quotidiana tornano in queste pagine con una riflessione sistematica, fatta anche con le tabelle con i nomi dei professori, i profili di alcuni docenti illustri, le schede sugli argomenti dei corsi e i libri di testo, prospetti riassuntivi per anno e per disciplina. Possiamo ora seguire il complesso processo di discernimento vocazionale che ha avuto alti e bassi sia sul piano della qualità che su quello della quantità nel corso di questo lungo periodo, quasi un secolo di vita (anche se ho visto che la Pontificia sul web rivendica una continuità con la storia secolare delle due università isolane), con tanti esempi di persone esemplari, che sono espressione di un popolo autentico, di un’umanità in cammino.
Quest’opera si affianca ai due volumi Per una Storia del Seminario di Cuglieri, di cui ho potuto leggere il I tomo dedicato al periodo 1927-1971 uscito poche settimane fa e presentato da Tonino Cabizzosu proprio nella nuova Aula Magna del Seminario di Cuglieri il 9 dicembre scorso, con la spettacolare documentazione delle relazioni annuali dei rettori. Un ritorno a Cuglieri atteso per anni, dopo l’incauto tentativo del gesuita Egidio Guidubaldi di riprendere possesso del Seminario passato alla Regione, per realizzare un’iniziativa di tipo sociale. Ma soprattutto come dimenticare oggi, a distanza di una settimana dalla scomparsa, le posizione del nostro amato Padre Raimondo Turtas, che presso la Facoltà teologica della Sardegna tra il 1950 e il ’53, conseguì il titolo di Licenza in Sacra Teologia ? Avevo potuto rileggere nei giorni di Natale a Bosa le pagine che aveva scritto su Cuglieri nel volume dedicato alla Storia della Chiesa in Sardegna in occasione del Giubileo del 2000, dove si raccontano molti retroscena e si giudica del tutto inadeguato l’insegnamento impartito per decenni in alcune discipline soprattutto nel settore biblico. Al di là della polemica che spesso ci divideva (come a proposito della data del 1562 dalla quale in realtà lui stesso aveva fatto partire i 450 anni di storia del Collegio gesuitico turritano), oggi sento solo il dolore per la scomparsa, l’ammirazione per le sue passioni, il senso di un’assenza che peserà nei nostri studi.
Del resto con questo volume entriamo di più nei dettagli, possiamo cogliere l’utilizzo di manuali e di dispense più o meno aggiornati, abbiamo un quadro dell’attività di ricerca e di produzione editoriale che pian piano si irrobustisce, soprattutto possiamo studiare la crescita culturale che ha investito la comunità dei seminaristi durante e dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II, anche grazie all’azione di alcuni vescovi. Se è vero che la nascita del Seminario Regionale fu una diretta conseguenza del Primo Concilio Plenario Sardo svoltosi ad Oristano nel maggio 1924, lo spartiacque tra la Universitas Gurulitana e quella Caralitana è rappresentato proprio dal Concilio Ecumenico, un evento epocale che la Facoltà Teologica ha voluto ricordare a Sassari nell’Aula Magna della mia Università il 23 aprile 2013, l’avvenimento più notevole della chiesa del secolo scorso, quasi un vessillo innalzato tra le nazioni, un evento di profezia e di resurrezione: anche noi laici sentivamo in quei giorni davvero la novità di un tempo nuovo, la gioia per la rinnovata dimensione universale della Chiesa, ancora il desiderio di una rinascita etica, la speranza per il futuro, il senso della fine di una storia, che spingeva a una svolta: debbo dire che con la chiusura del Seminario cuglieritano i vescovi ebbero coraggio ma adottarono una decisione che forse fu allora troppo affrettata e radicale.
Questo volume contiene tante piccole cose preziose, incrocia fonti diverse, fornisce dati, fa tornare alla mente nomi ben noti e cose che abbiamo vissuto, almeno io, dall’altra parte della barricata, dalla parte dei laici, come l’arrivo a Cuglieri della Statua del Sacro Cuore trasportata sul leoncino dei Panichi che credo sia la prima fotografia della mia vita dalla terrazza della casa di mio nonno. Ma tante cose mi erano ignote, alcune sorprendenti e vive. L’insegnamento nel Pontificio Seminario Regionale Sardo nel suo divenire, con i limiti di una tradizione neotomistica e i fermenti di rinnovamento, il lungo cammino della teologia morale, la presentazione del trattato De ecclesia, il diritto ecclesiale tra innovazione e profezia, la presenza femminile, l’impatto con la realtà di un villaggio sperduto della Sardegna come Cuglieri, al piede del Monte Bardosu sovrastato dalla basilica mariana: un paese disteso sulla collina come un vecchio addormentato che pure raccoglieva una comunità locale che vantava tradizioni lontanissime (penso alla diocesi tardoantica di Cornus) ma lamentava spaventosi ritardi storici; la virtù politica e teologica della concordia, fino alla piccola perla della scoperta del manoscritto inedito ottocentesco di Ozieri con i gosos in castigliano e sardo, testimonianza preziosa del carattere plurilingue della cultura sarda.
Allora mi viene voglia riprendere un pensiero recente di Antonio Corda (sull’ultimo numero di Caster) e citare la Sura del Misericordioso del Corano, dove si ricorda che il Signore al momento della Creazione lasciò liberi i mari perché si incontrassero, e oggi ne escono perle e coralli; sue sono le navi che corrono, corrono alte sul mare come vessilli (LV, 19 ss.). Dall’uno e dall’altro mare, quello dolce e fresco, quello salmastro ed amaro, l’uomo mangia la carne fresca dei pesci e ricava gli ornamenti che indossa e vede navi fendere le onde (XXXV, 12).
Gli alunni del Seminario Regionale e della Facoltà hanno potuto fendere le onde, raccogliere perle e coralli, contribuire a costruire una Sardegna nuova e più felice, con sacrificio personale e con errori, ma anche con tanta attenzione per i problemi delle famiglie, per i giovani, per una società che vediamo cambiare sotto i nostri occhi ogni giorno che passa, dove i sacerdoti e i laici possono davvero contribuire a fare la differenza, possono accompagnare e capire, consapevoli dei limiti e dei tradimenti, ma anche ripieni di dedizione, impegno disinteressato, capacità di ascolto della Parola. Con errori certamente e insufficienze, ma con uno slancio umano davvero positivo.
Più in generale ci sono altre cose che mi hanno colpito, come questo legame saldissimo ed originario con il Seminario piemontese di Chieri, la cittadina a SE di Torino dove avvenne la formazione fino al 1841 di Giovanni Bosco: quando dové lasciare il Seminario- scrive Don Bosco – “mi tornò dolorosissima quella separazione, separazione da un luogo dove ero vissuto per sei anni, dove ebbi educazione, scienza, spirito ecclesiastico e tutti i segni di bontà e di affetto che si possono desiderare”. Il legame tra Chieri e Torino fu costruito dai Padri Gesuiti che viaggiavano da Genova e che pubblicavano le loro opere e le tesi di dottorato in Piemonte, continuando quella tradizione che non era stata interrotta dalla “Perfetta Fusione” della Sardegna con gli stati di terraferma del 1847, prima della fine del Regno di Sardegna. E poi l’impegno costante della Compagnia di Gesù, che ha fornito oltre il 70% del personale docente, pur con l’episodio dello scontro coi vescovi e con gli allievi che alla fine ha portato al trasferimento a Cagliari, vissuto come una tragedia dalla comunità locale della diocesi di Bosa, che si è sentita tradita.
Come si è detto la scelta di Cuglieri fu effettuata da Pio XI dopo il Concilio Plenario Sardo del 1924, per ospitare il Seminario maggiore e le due Facoltà di Filosofia e di Teologia, in questa località saluberrima negli anni della malaria: <<è uno dei posti più pittoreschi della Sardegna scriveva mons. Gaetano Malchioldi il 12 settembre 1924, con il santuario della Basilica collegiata dedicata alla Madonna della neve. E’ certamente uno dei più bei punti della Sardegna. Vigneti, uliveti ricchissimi e boschi fanno bella cornice alla borgata dalla quale si gode uno dei più suggestivi panorami>>. Pio XI nella Costituzione apostolica Nostrarum Partem letta dal Cardinale legato Gaetano Bisleti avrebbe scritto il 5 agosto 1927 in occasione della festa della Madonna della Neve che il Seminario sorgeva ormai a Cuglieri su progetto dell’arch. Giuseppe Momo, in un luogo speciale: <<is enim et in media situs est insula et amoenissimus ac saluberrimus est, nemoribus consitus, optimis lymphis irrigatus, ut vix aptior inveniri possit>>. Solo più tardi emergerà il disagio, l’isolamento, l’assenza di collegamenti, il gelo invernale. Debbo dire onestamente che mi resta il sospetto che abbia pesato molto di più di quanto non si ammetta per la scelta di Cuglieri in chiave antimodernista anche la figura del cuglieritano Bonfiglio Mura (1810-82), rettore dell’Università di Perugia prima e dell’Università Sapienza di Roma fino al 1870, negli anni cruciali della polemica su Roma Capitale dopo l’Unità d’Italia. La ferita subìta nell’Ottocento continuava ancora a sanguinare.
Possiamo seguire lo sviluppo nel tempo dell’attività di formazione e il continuo divenire del sapere teologico in modo strutturato dal liceo al Baccellierato, dalla licenza alla tesi di dottorato, che anticipava molte soluzioni che le Università statali hanno adottato solo di recente. Eppure il Seminario unico regionale ereditava decenni di una teologia scolastica che si era un po’ logorata nei seminari delle diverse diocesi chiusa verso le scienze moderne, alcune considerate “scienze ausiliarie”, in una dimensione apologetica e nozionistica, inizialmente non interessata alla ricerca autonoma in campo biblico.
Nel 1927 la nascita del Pontificio Seminario Regionale Sardo intitolato al Sacro Cuore di Gesù (patroni Carlo Borromeo e Luigi Gonzaga), costituì dunque un passo in avanti notevole per la Chiesa sarda, pur con tutti i limiti che in questo volume vengono ammessi, già nelle “regole disciplinari” pubblicate nel 1934 e nel 1940 commentate nell’articolo di Riccardo Pinna, regole di comportamento comunitario e individuale eppure da considerarsi in qualche modo anticipatrici del Concilio, dei documenti pontifici successivi e perfino del progetto educativo approvato dalla Conferenza Episcopale Sarda nel 2013: dunque la Ratio fundamentis institutionis sacerdotalis del 6 gennaio 1970, gli ambiti formativi nel seminario maggiore, l’autenticità della chiamata di un sacerdote che non può essere emarginato nella solitudine, ma deve coltivare il rapporto con la famiglia di origine, con la parrocchia, con il proprio vescovo. Con l’Esortazione apostolica post-sinodale di Giovanni Paolo II Pastores dabo vobis (25 marzo 1992) si definiva il percorso formativo di sacerdoti capaci di comprendere, perdonare e consolare, fedeli alla vera compassione, alla coerenza e in particolare all’equilibrio di giudizio e di comportamento, con maturità affettiva, sacrificio di se stessi. A due anni fa risale il secondo volume del progetto educativo “Annunziatori liberi e gioiosi per una chiesa in missione”, che dà spazio ai laboratori culturali di musica sacra, all’arte iconografica, alla comunicazione, all’accoglienza e alla cura degli ambienti, alle nuove frontiere di una teologia più al passo coi tempi.
Colpisce l’impegno diretto della Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università in costante rapporto con la Direzione del Pontificio Seminario Regionale Sardo e la Facoltà Teologica dal 1927 al 1970, sia in termini finanziari per la costruzione dell’edificio, sia in termini organizzativi, sia sul piano della didattica e degli studi; più tardi della Conferenza episcopale sarda, forse inizialmente impreparata nonostante l’impegno di Ottorino Alberti rettore del Seminario dal 1972.
A Cuglieri, a partire dal rettorato di Padre Giuseppe Peano, possiamo seguire il complesso rapporto con il Fascismo e la descrizione dei disagi affrontati dalla comunità del Seminario Regionale che non ha mai cessato di operare durante la seconda guerra mondiale, mettendo prodigiosamente in salvo circa 400 allievi come in un bozzolo protettivo pur tra mille disagi e difficoltà, grazie alla solidarietà di tutto il paese.
Fu forse la presenza del Seminario a Cuglieri a consentire la riscoperta della Storia della Sanctissima Cornensis Ecclesia (citata così nel Concilio Lateranense Romano del 649), grazie al’attività archeologica del cugino dell’arciprete Giovanni Pes, Pietro appena laureato con Giovanni Lilliu, impegnato negli scavi di Columbaris a Santa Caterina, dove il Seminario aveva costruito una colonia estiva: ne troviamo traccia fin dal 1955 su L’Eco del Regionale”, ma le scoperte più importanti si sviluppano negli anni successivi con lo scavo del battistero di San Giovanni, la basilica funeraria in stile africano voluta forse dai vescovi esiliati dai Vandali, la grande basilica a 5 navate che ospitò forse i compagni di Fulgenzio all’inizio del VI secolo. Mons. Giovani Mastino era solito ricordarci in modo un poco romanzesco e fantasioso la solenne apertura del sarcofago di Maximus collocato tra le due absidi nella basilica funeraria, alla presenza del vescovo di Bosa Francesco Spanedda e del Parroco Giovanni Pes, quando sollevato il coperchio ormai senza la lastra epigrafica (ritrovata poi in un’ovile vicino) per un attimo i sacerdoti presenti poterono intravvedere la fisionomia del defunto che si disfaceva in polvere.
Si legge in questo volume più in generale il legame strettissimo tra la cittadina di Cuglieri e il Seminario, che il trasferimento a Cagliari dopo 44 anni avrebbe rimesso in discussione, impoverendo enormemente il territorio e la diocesi: nella polemica di quegli ultimi anni causata dalla visita psico-pedagogica esplosiva del 1969, sembrò andare perduto lo sforzo sovrumano compiuto dai cuglieritani per proteggere e alimentare i seminaristi durante la guerra e poi l’impegno ininterrotto garantito dai cittadini e dal sindaco per rispondere ai bisogni del Seminario in termini di acqua, luce, strade, collegamenti. Le opere realizzate a partire dal 1971 restarono in abbandono. Appena pochi anni prima era stato ottenuto il riconoscimento statale per il diploma liceale e si era finalmente completato l’impianto per il riscaldamento dell’edificio, assolutamente necessario durante il rigido inverno cuglieritano. Anche i benefici che i giovani laici di Azione Cattolica avevano acquisito frequentando corsi, conferenze di illustri visitatori, lezioni, escursioni, pellegrinaggi, musica finirono per interrompersi. La Madonnina fu messa in liquidazione. Ne sono testimone io stesso, che andavo periodicamente a Cuglieri per stampare i nostri giornali liceali, del CSI e della GIAC con il ciclostile del Seminario generosamente messo a disposizione dai padri.
Eppure emerge da queste pagine il senso del prestigio di cui docenti e studenti provenienti dal Seminario Regionale godevano in Sardegna e non solo, il loro rapporto con le autorità, soprattutto nel secondo dopoguerra il collateralismo politico nel quale tutti eravamo immersi. Positivi furono i rapporti con l’Azione Cattolica, in particolare con la GIAC (destinata presto ad essere assorbita), con gli Scout, con il Centro Sportivo Italiano, con l’attività catechistica presso la chiesa di San Giovanni (come negli articoli di Tonino Loddo e di Ignazio Ferreli, quest’ultimo oggi ordinario di Filosofia teoretica), con la lega della Perseveranza nei nuovi locali costruiti sul triangolo del reliquato tra Fidine e Sianu, tra la provinciale per Santulussurgiu e Viale delle Rimembranze, per iniziativa dei Padri Pasquale Di Girolamo e Enrico Trabucchi. Ne conservo un ricordo vivo, perché trascorrevo a Cuglieri i mesi che vanno dalla festa della Madonna della Neve fino all’inizio dell’anno scolastico. La palazzina della Lega era una sorta di chiassosissimo ritrovo per giovani ed adulti cuglieritani, con i suoi biliardini, il suo bar, il suo salone, la sua musica assordante, il suo fumo, i suoi films. Soltanto in una fase successiva vennero sviluppate alcune iniziative nelle quali fummo coinvolti, tra Santa Caterina di Pittinuri e la casa di accoglienza di La Madonnina di Santulussurgiu, che allora frequentavamo spesso sotto la guida del compianto don Giuseppe Budroni.
Ha ragione Loddo a sostenere l’iniziale debolezza della preparazione pastorale dei futuri sacerdoti a Cuglieri nel suo articolo dedicato all’Omònoia: secondo una visione “a posteriori” dai documenti risulta che l’isolamento geografico del piccolo paese non permetteva ai docenti e agli alunni di sviluppare esperienze pastorali significative, a causa dello scarso confronto culturale, aggiunge Cabizzosu anche per la poca sensibilità dei Padri verso l’identità sarda (lingua, storia, tradizioni). Eppure c’erano tante cose da amare: io stesso ho vivo il ricordo del laboratorio sismologico di Padre Antonio Furreddu, con i rulli di carta che scorrevano raccogliendo dalla rupe naturale qualunque segnale di movimento della crosta terrestre; le sue numerose pubblicazioni sulle grotte della Sardegna, questa incredibile conoscenza del territorio, la sua attività speleologica anche nei nostri paesi. Oppure le passeggiate fino a Su Monte ‘e s’Ozzu, alla cascata di Massabbari oltre Casteddu Ezzu, al mare di Santa Caterina, di Puzzu e S’Archittu, al margine meridionale della diocesi che continuava l’antico confine tra Cornus e Tharros sul Rio Pischinappiu, testimonianza della decurtazione del territorio dopo la sconfitta di Hampsicora; l’opera catechistica di San Giovanni con padre Paolo Gamba; l’attività dei pueri cantores di Padre Egidio Boschi. Ignazio Ferreli mette in evidenza il progetto relazionale sviluppato dai professori e dagli educatori del Seminario Regionale cuglieritano e rivolto in primis agli alunni interni e anche all’intera comunità di Cuglieri. L’autore vede nella “virtù della concordia” la radice di ogni aspetto relazionale che trova il suo fondamento nel progetto di Dio “che vuole tutti gli uomini uno” (Gv. 17,21). Emerge la bizzarra figura di Carlo Ferraris di Celle, docente di filosofia e bibliotecario, ingegnere navale, che progettò personalmente a Cuglieri alle spalle del Seminario, nel 1956 la via crucis con il Calvario e il Santo Sepolcro, oltre che con le sue edicole e le sue maioliche volute da Padre Gamba; solo nel 1961 sarebbe arrivata la statua del Redentore. Eppure il rapporto di collaborazione con la Parrocchia di Cuglieri e la diocesi di Bosa fu anche di competizione e talora di conflitto.
Diretta conseguenza del Concilio, più di quanto non si ammetta, mi pare sia stata proprio la chiusura del Seminario tridentino di Cuglieri, nel 1970, il trasferimento a Cagliari durante il rettorato di Padre Giuseppe Bosio, un evento drammatico, difficile, inizialmente frainteso perché non motivato adeguatamente, che avevamo contestato su “Libertà” interpretando i sentimenti di molti sardi e di molti diocesani, criticando l’isolamento dei seminaristi nel contesto cittadino cagliaritano, l’iniziale dispersione degli allievi tra il Seminario Regionale di Via Parragues e per i teologi in altre sedi di Istituti Religiosi e perfino a pensione in famiglie private, fino ad arrivare alla Facoltà Teologica di Via Sanjust nei locali della Compagnia di Gesù, gli scarsi rapporti proprio con le Università storiche statali di Cagliari e Sassari fondate dai Gesuiti, tema che era stato utilizzato per giustificare il trasferimento in una grande città. Il tutto con la motivazione, in realtà giustissima, di cercare una “densità” urbana sufficiente per accompagnare la formazione dei Seminaristi con concrete esperienze pastorali. Oggi non saprei dire quanto questa mia posizione fosse fondata o solo localistica, magari ispirata dal can. Antonio F. Spada oppure dal vescovo Spanedda, al quale d’altra parte non credo possiamo attribuire la responsabilità della pubblicazione integrale su “Libertà” dei risultati che dovevano rimanere riservati della visita psico-pedagogica di tutti i seminaristi affidata nel 1969 ad un’équipe dell’Ateneo salesiano di Roma. Un evento che avrebbe disgustato soprattutto i Padri Gesuiti, allontanandoli per sempre dai loro allievi e provocando il trasferimento a Cagliari prima dei liceali poi dei teologi.
Emerge da queste pagine il valore di un patrimonio ecclesiale e culturale prezioso e vivo, come scrive Francesco Maceri, Preside e titolare del corso di teologia morale fondamentale, per riscoprire il legame profondo che unisce la teologia e la cultura, l’intelligenza della fede e gli interrogativi dello spirito umano, passando per alcuni momenti fondamentali come il Concilio Ecumenico che l’articolo di Giacomo Rossi (emerito di Filosofia e Teologia morale) dimostra essere alla base dello sviluppo della teologia morale di oggi tanto attenta ai valori della persona, alla sua fragilità, al tema della misericordia e dell’etica della vita, dopo i duri anni cuglieritani raccontati da Roberto Caria, attraverso un riesame critico del manuale neo-tomistico adottato per decenni, i pregi e i limiti delle Institutiones theologiae moralis di Genicot-Salsmans e degli altri manuali, che ci fanno toccare con mano quell’inflessibile durezza contro il modernismo, che è un po’ alla base del Seminario Regionale, di cui era rimasta vittima una personalità come il maestro del mio maestro, Bachisio Raimondo Motzo. Più di recente, il percorso di rinnovamento fu avviato col secondo Concilio Plenario Sardo con le sue commissioni ante preparatorie nel 1986, aperto nel 1992, faticosamente portato avanti fino al 1999 e addirittura al 2001 con la pubblicazione del volume su La Chiesa di Dio in Sardegna alla soglia del terzo millennio si interroga sulle vie dell’evangelizzazione dell’isola.
E dunque le tante cose positive, le nuove discipline, come la Bioetica nell’azione formativa di Umberto Burroni, ben delineata da Stefano Mele, partendo dal magistero di Paolo VI; oggi, nei giorni dell’approvazione del testamento biologico dopo la vicenda di Walter Piludu ma anche della colpevole rinuncia al riconoscimento in Italia dello ius soli queste pagine risultano quanto mai attuali, alla luce dei “nuovi compiti” che il Concilio Plenario Sardo attribuisce all’intera comunità cristiana; istruttivo è il percorso tracciato in tema di ecclesiologia (a cavallo tra dogmatica e sistematica) nell’articolo di Mario Farci (ordinario di Teologia dogmatica), dalla costituzione istitutiva fino alla costituzione apostolica di Pio XI Deus scientiarum dominus del 1931, destinata ad un rinnovamento che (cito) <<non sembra evidente negli studi cuglieritani fino al corso del 1969 tenuto da Francesco Spanedda su La chiesa di Gesù Cristo, la tradizione>>. Questo riconoscimento mi sembra giustissimo, anche se il ruolo di Spanedda (baccelliere a Cuglieri nel 1928, licenziato l’anno successivo) nel Concilio e dopo il Concilio appare costantemente sottovalutato dagli storici: in passato avevo osservato forse troppo bruscamente che Raimondo Turtas nel volume sulla Storia della Chiesa in Sardegna ridimensionava il ruolo svolto dai vescovi sardi al Concilio, mi sembra con la sola eccezione di Mons. Giovanni Pirastru, di Iglesias, impegnato a sollecitare interventi convergenti dei vescovi sardi sul versante della dignità umana e dei diritti della persona. Gliel’avevo fatto notare e sorprendentemente aveva ammesso con me che nessun altro vescovo sardo come Spanedda ebbe in quegli anni una dimensione internazionale e un ascolto altrettanto ampio. Ho visto citati da Tonino Cabizzosu nel volume di tre anni fa sui vescovi sardi al Concilio i numerosi interventi scritti di mons. Spanedda, arrivato a Bosa nel 1956, chiamato a far parte della Commissione teologica internazionale, nella Commissione De doctrina fidei et mororum; uno degli interventi è intitolato ad finem Concilii, gli emendamenti e le sue adesioni agli interventi di colleghi sui temi de apostolatu laicorum e, appunto, De sacrorum alumnis formandis. Infine la sua firma su molte costituzioni conciliari, penso a quella sulle chiese orientali (con attenzione per il culto di San Costantino), sull’ecumenismo, ancora sull’apostolato dei laici. Era del resto il vescovo nel cui territorio operava da cinquanta anni proprio il Pontificio Seminario tridentino regionale, la Facoltà di teologia e filosofia, che costituì una delle preoccupazioni dei vescovi isolani, che certo si riflettono in alcune pagine del Concilio. Le sue origini sassaresi (era nato a Ploaghe) e il suo ministero nell’antica diocesi di Bosa lo portavano a enfatizzare con noi il ruolo del Collegium Mazzotti e la casa di accoglienza di La Madonnina di Santulussurgiu, che allora frequentavamo spesso. In Cattedrale egli ci raccontava il Concilio con lo stupore di chi assisteva ad un evento storico, osservava commosso le nuove aperture di una teologia troppo chiusa come quella italiana, entrava in contatto per la prima volta con i teologi francesi e tedeschi, istituiva rapporti e legami con decine di altri vescovi in particolare di oltrecortina, che si sarebbero sviluppati nel tempo. C’era nelle sue parole il sapore fresco di un avvenimento che in qualche modo settimana dopo settimana egli riusciva a farci vivere insieme con lui, soprattutto nell’Azione Cattolica, nel Centro Sportivo Italiano, in parrocchia, sul settimanale Libertà. Un avvenimento che per tre anni ci avrebbe riguardato tutti.
Seguono gli anni del movimento liturgico, del movimento ecumenico, del nuovo impulso missionario, della dinamicizzazione del laicato e dello sviluppo della teologia su di esso, dopo l’approvazione dei nuovi statuti del 1974. Ancora la storia della Chiesa in particolare in Sardegna, partendo proprio dal libro di Raimondo Turtas per l’anno santo del 2000. Giovanni Paolo II il 15 aprile 1979 promulgava la costituzione apostolica “Sapientia Christiana. De studiorum Universitatibus et Facultatibus ecclesiasticis”, ancora oggi la magna charta degli studi ecclesiastici, un po’ il modello della dichiarazione di Bologna di otto anni dopo, dove si distingue la docendi ratio dalla discipulorum institutio, posta accanto e strettamente congiunta alla scientiae pervestigatio, alla ricerca scientifica: in universitatibus docendi rationem necesse est cum scientiae pervestigationem coniunctam esse ut usus moresque mutantes et procedentes sequatur.
L’articolo di Alessandro Fadda affronta l’insegnamento del diritto ecclesiale tra innovazione e profezia, partendo dal codice di diritto canonico del 1917 fino ad arrivare a quello del 1983, esito delle disposizioni sinodali all’indomani de Concilio sui dieci Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant, verso un’ecclesiologia di comunione che sottolinei la natura societaria della Chiesa, la qualificazione del potere della Chiesa come servizio, la pastoralità che non demolisca l’autorità, il radicamento territoriale della chiesa locale per diocesi, la corresponsabilità. L’autore crede vada superato il concetto di collaborazione, cooperazione perfino di sinodalità che pure esprime, attraverso il richiamo alla parola greca sunodos e alla parola latina conventus il tema vitale della necessità – per christifideles e pastori – del percorrere una strada insieme: conferenze episcopali, provincia ecclesiastica, sinodo diocesano, consiglio presbiterale e collegio dei consultori, consiglio pastorale. E ciò non in astratto ma con riferimento alle diocesi sarde nell’ultimo quarantennio, partendo proprio dal Sinodo delle Diocesi di Alghero e Bosa indetto il I gennaio 1986 e concluso il 31 marzo 1991, con le sessioni svolte a Bosa, Cuglieri, Macomer e Alghero: sinodo promosso dall’ex arciprete di Cuglieri divenuto vescovo delle diocesi unite, Giovanni Pes. Primo sinodo tra quelli celebrati in molte diocesi isolane a Nuoro, Cagliari, Oristano, Ales Terralba, quest’ultimo concluso solo due anni fa. Tutto ciò in parallelo col secondo Concilio Plenario Sardo tra il 1992 e il 2001, che in realtà è il sesto della serie a carattere “nazionale” isolano, dopo Torres nel 1089, Ardara nel 1135 e nel 1205, Santa Giusta nel 1226, Bonarcado attorno al 1272, Oristano nel 1924.
C’è in queste pagine anche una riflessione sulla recente inculturazione della teologia nella realtà isolana come nell’articolo di Dionigi Spanu (emerito di Teologia spirituale) con gli studi che partono dall’incontro con i discepoli di Emmaus e riprendono la gioia del Vangelo attraverso i sermoni di Agostino al popolo di Ippona a proposito dei sacerdoti e vescovi pastori di Dio: hoc est Christum pascere, hoc est Christo pascere, hoc est in Christo pascere, preter Christum sibi non pascere. Da qui, fino alla spiritualità ignaziana e alla beata Maria Gabriella Sagheddu.
Soprattutto mi ha colpito l’atteggiamento aperto di Tonino Cabizzosu e degli altri autori verso un tema rimosso per decenni – pur presente nelle opere sulla Sardegna cristiana di Damiano Filia a partire dal 1909 – quello della lingua sarda, della identità della Sardegna arcaica e della Sardegna di oggi: un tema che passa attraverso il progetto <<Innodia Sarda>> che lega il Dipartimento di Scienze umanistiche di Sassari alla Facoltà di Teologia della Sardegna e che è testimoniato nell’articolo di Giampaolo Mele che va ben oltre questa scoperta inattesa, i gozos di Santo Effisio Martir in un castigliano sopravvissuto nella Sardegna dell’Ottocento: Delante del Rey Soberano, / gran capitano valoroso, / Tenednos de vuestra mano, / Effis santo Glorioso. Dunque l’attenzione verso la cultura e l’identità sarda è una delle acquisizioni più importanti e più significative degli ultimi decenni, alle quali hanno dato un contributo non solo le omelie in Sardo a S’annossata di Bitti di Padre Turtas ma tanti altri protagonisti di questo volume.
Quanto si sia aperta la Facoltà Teologica ai problemi relativi all’identità religiosa della Sardegna è del resto testimoniato oggi dalle tematiche affrontate in molti articoli scientifici pubblicati sulla prestigiosa rivista “Theologica & Historica”, nella partecipazione a convegni nell’isola e nella penisola, nell’impegno in corso della Facoltà a tradurre la Bibbia e i testi per la celebrazione della messa in lingua sarda così da presentarli alla Santa Sede per l’approvazione, in attuazione di uno dei Canoni del Concilio Plenario Sardo. Nel suo articolo su “Il divenire storico, dimensione essenziale per il sapere teologico” Tonino Cabizzosu entra profondamente nel tema all’interno della più ampia docenza di Storia della chiesa contemporanea, come è evidente dai titoli dei lavori di tesi e dalle numerose ricerche, sul Clero diocesano e regolare, sulle Congregazioni religiose e gli Istituti sorti in Sardegna, sulle Donne, chiesa e società isolana, su ben 34 Vescovi, sui Sinodi, sugli Archivi parrocchiali.
Dobbiamo ammettere che nei primi anni cagliaritani il rapporto della Facoltà con le due Università fu quasi inesistente: ricordo negli anni 80 diverse prese di posizione sul fatto che la Facoltà Teologica svolgeva la sua attività di ricerca senza trovare punti di contatto, occasioni di incontro, obiettivi comuni: sarebbe stato il nostro amato Padre Natalino Spaccapelo a raccogliere quella protesta, a colmare quella divaricazione e a dare molti segnali di collaborazione che ancora continuano, prima con Sebastiano Mosso, poi con Maurizio Teani e oggi con Francesco Maceri, partendo dal volume su Eusebio di Vercelli alla fine degli anni 90, poi con Simmaco, Fulgenzio e Gregorio Magno, la collana sempre più prestigiosa e la straordinaria rivista Teologica & Historica aperta ai laici, arrivata al 26° numero. Lasciatemi ricordare almeno gli Atti del convegno del 2007 Orientis radiata fulgore, curati da Lucio Casula, Antonio Corda, Antonio Piras, con i contributi di alcuni amici che chi hanno lasciato, Vincenzo Aiello, Roberto Coroneo, Réginald Grégoire, Gabriele Marasco. Oppure i fondamentali studi sul nostro Fulgenzio di Ruspe e il suo contesto, Lingua et ingenium del 2010. E poi le numerose opere pubblicate nei testi e monografie della Pontificia Facoltà Teologica University Press, fino ai recentissimi lavori di Tonino Cabizzosu.
Oggi, dopo 46 anni della Facoltà Teologica del Sacro Cuore a Cagliari, il giudizio è dunque molto differente, nonostante la crisi delle vocazioni, ma anzi proprio per questo, con l’apertura alla società civile, al mondo laicale, alle docenti donna; con il legame con gli Istituti di Scienze religiose di Cagliari e di Sassari, con l’Istituto Euromediterraneo voluto da Mons. Saba, anche dopo la recente riforma. Con gli accordi stipulati con le due Università di Cagliari e di Sassari.
A questo proposito come dimenticare l’articolo di Rita Lai sull’opera e sulla presenza femminile nella vita della Facoltà Teologica, con le docenti, le alunne, le collaboratrici. “La presenza femminile in Facoltà, per quanto esigua e scarna, è stata sempre qualitativamente significativa” già dagli anni cuglieritani. Tra le docenti possiamo partire dal 1983 e dalla nostra Suor Aurora Cambilargiu per la Filosofia, da Lucia Zamboni nel 1984 per comunicazione sociale, Renata Serra per la Storia dell’arte in Sardegna. Attualmente in servizio sono Danila Artizzu, Myriam Ferrari Vincenza Ibba, Rita Lai, Donatella Nardi; e poi le alunne a partire dall’ultimo anno del Concilio, il 1965, con le tre tesi dottorali di Anna Maria Girau nel 1996, Vincenza Ibba nel 2014, Rita Lai nel 2016. Mi sono appassionato a scorrere i titoli delle ricerche e delle tesi, con una straordinaria varietà e ricchezza, che la dicono lunga sulla superficialità di alcuni giudizi sommari. Tra le alunne emerge la figura della serva di Dio Simonetta Tronci, una studentessa “normale”, scomparsa a 23 anni il 18 aprile 1984, lasciando un vuoto davvero smisurato. Per la fase a noi più vicina, vorrei aggiungere altre collaborazioni al femminile, come in tanti articoli della rivista o in veri e propri volumi, come quelle di Maria Corona Corrias e Giovanna Sotgiu, che curarono nel 1996 l’organizzazione del Convegno aperto da Mons. Tarcisio Bertone sulla Sardegna paleocristiana. Oppure Rossana Martorelli col volume sui Martiri e devozione nella Sardegna altomedievale e medievale del 2012; Bianca Fadda su L’archivio della famiglia Alliata di Pisa Il fondo diplomatico e la Sardegna (1261-1375) nel 2015. Nella nuova serie “Studi e ricerche di cultura religiosa”. Rossana Martorelli, Antonio Piras, Pier Giorgio Spanu pubblicano il volume Isole e terraferma nel primo cristianesimo. Identità locale ed interscambi culturali, religiosi e produttivi, PFTS University Press, Cagliari 2015. Potremmo andare oltre.
Mi sono fatto un’idea chiara dell’evoluzione della Facoltà Teologica in questi anni soprattutto partecipando per 12 anni come Prorettore e per 5 anni come Rettore dell’Università di Sassari alle inaugurazioni dell’anno accademico, con la messa nella chiesa di Cristo Re e con le relazioni del Gran Cancelliere e del Preside; da ultimo ho capito che la Facoltà Teologica che si è presentata in questa aula col Preside Francesco Teani a Papa Francesco il 23 settembre 2013 è l’espressione di una tradizione lunga, di una storia prestigiosa della quale il periodo cuglieritano è parte essenziale. Quel giorno Papa Bergoglio nel suo splendido discorso tenuto a Cagliari, parlò di Università partendo proprio dallo sconforto dei discepoli trovati ad Emmaus: Papa Francesco ci raccontò la crisi di oggi come assenza di istruzione e di conoscenza, interpretandola anche come possibile opportunità verso un mondo nuovo: <<Penso non solo che ci sia una strada da percorrere, ma che proprio il momento storico che viviamo ci spinga a cercare e trovare vie di speranza, che aprano orizzonti nuovi alla nostra società>>. Il Papa riteneva che il ruolo dell’Università sia prezioso, come luogo di elaborazione e trasmissione del sapere, di formazione alla “sapienza” nel senso più profondo del termine, di educazione integrale della persona. L’Università come luogo del discernimento, in cui si elabora la cultura della prossimità, la cultura della vicinanza, come luogo di formazione alla solidarietà, in cui si promuove, si insegna, si vive questa cultura del dialogo, che non livella indiscriminatamente differenze e pluralismi – uno dei rischi della globalizzazione è questo -, e neppure li estremizza facendoli diventare motivo di scontro, ma apre al confronto costruttivo. Questo significa comprendere e valorizzare le ricchezze dell’altro, considerandolo non con indifferenza o con timore, ma come fattore di crescita. Non c’è futuro per nessun paese, per nessuna società, per il nostro mondo, se non sapremo essere tutti più solidali. Solidarietà quindi come modo di fare la storia, come ambito vitale in cui i conflitti, le tensioni, anche gli opposti raggiungono un’armonia che genera vita>>.
Parole che mi pare possano essere declinate oggi anche laicamente e rappresentare la vocazione alla formazione e alla ricerca propria della scuola e dell’università, entrambe libere da condizionamenti, rispettose del pluralismo, attente al futuro dell’umanità.
Ecco, proprio uno sguardo verso il futuro della Sardegna, verso le prospettive e l’orizzonte di cambiamento ritorna in tanti di questi lavori, sempre per evitare – come scrive Mario Farci – <<il rischio di parlare di una Chiesa che esiste solo sui libri>> ma cercando di mantenere quello che è stato lo straordinario obiettivo del Seminario Regionale Sardo fin dalle sue origini, quello di trovare sinergie tra le dieci diocesi della Sardegna, di superare ogni frammentazione localistica, di ascoltare il parere di tutti, di collegare tra loro i territori e le esperienze della Sardegna.
Sappiamo tutti che proprio in questi giorni sono arrivati i tempi nuovi rappresentati dal Patto per l’inclusione “Sardegna 100 Chiese” firmato dal Presidente della Regione Francesco Pigliaru e dal Presidente della CES mons. Arrigo Miglio: tra le proposte presentate figurano la promozione delle istituzioni formative di Sassari (Istituto Euro Mediterraneo) e Cagliari (Facoltà Teologica della Sardegna), in collaborazione con i due atenei sardi e il coinvolgimento di numerose associazioni culturali, oltre al recupero dell’ex Seminario di Cuglieri, che si avvia a diventare un nuovo polo formativo dedicato alle tematiche sociali. Con speranza, faticosamente ci affacciamo verso una realtà davvero nuova.
Foto: Il Leoncino che trasporta fino il Seminario Regionale di Cuglieri la statua del Redentore (replica della scultura di Carmela Adami). La foto è stata scattata dall’autore nell’estate 1961 dal balcone del secondo piano della casa del nonno Attilio Mastino.
Il viaggio di Enea fino a Cartagine
Attilio Mastino
Il viaggio di Enea fino a Cartagine
Paestum, Borsa Mediterranea del turismo archeologico, 27 ottobre 2017
Incontro “Il viaggio di Enea”
La Farnesina e la ricerca archeologica nel Mediterraneo
1. Virgilio riassume il tema delle relazioni mediterranee nel mondo antico nell’episodio della tempesta raccontato nel I libro dell’Eneide: le navi di Enea, partite da Drepanum in Sicilia, dove è stato sepolto Anchise, arrivate all’altezza delle isole Eolie, vengono disperse dai venti scatenati da Eolo, istigato da Giunone (la Tanit-Caelestis dei Punici). La tramontana (Aquilo) investe la vela della nave di Enea e solleva le onde fino al cielo; si spezzano i remi e la nave, offrendo i fianchi ai marosi, è ormai incapace di governare; le onde frante in cresta minacciano la stabilità di alcune triremi, mentre le altre sono spinte verso le secche, dove si formano mulinelli di sabbia (1, 102-7). Notus, il vento da Sud corrispondente all’Austro, getta tre navi sugli scogli, su quei saxa latentia chiamati Arae [Neptuniae o Propitiae] dagli Itali, che si innalzano sul mare di Libia con un dorso smisurato (1, 108-110). Euro poi, vento di Sud-Est (dunque lo Scirocco), spinge altre tre navi (si noti la ripetuta triplicazione rituale), le incaglia sui fondali e le circonda a poppa e sui fianchi con un argine di sabbia, rendendo impossibile la navigazione; è appunto ad Euro che è attribuita da Enea la responsabilità maggiore della presunta perdita di 13 delle 20 navi (1, 383). Una settima nave, quella dei Licii guidata da Oronte, viene investita di poppa da un’ondata ed affonda in un vortice dopo aver ruotato per tre volte su sé stessa (1, 113-9); alla fine risulterà essere l’unica nave andata a fondo. Anche le navi di Ilioneo, di Acate, di Abante e di Alete si trovano in difficoltà, perché le ondate provocano ampi squarci lungo le fiancate, aprendo pericolose falle (1, 120-3); alcune sono gettate dagli Austri in vada caeca …./…. perque invia saxa (1, 536-7), anche se poi gli Eneadi riescono a toccare terra.
Si discute sulla localizzazione della flotta di Enea nel corso della tempesta e sulla durata della navigazione inizialmente in direzione dell’Ausonia, il Lazio abitato dai Silvii e poi dai Latini, in realtà dirottata dai venti verso Cartagine dalle Arae Philenorum al fondo della Grande Sirte: oggi si preferisce però seguire Servio ed identificare di conseguenza le Arae del v. 109 con le Arae Neptuniae o Propitiae, scogli tra Africa, Sicilia, Sardegna ed Italia (citati anche in Plin., NH 5, 7, 42); su tali scogli (residuo di una più vasta isola sommersa), scelti ad indicare il confine tra l’impero romano e l’area sottoposta al controllo cartaginese, sarebbe stato stipulato uno dei trattati tra Roma e Cartagine, forse quello del 234 a.C.: ibi Afri et Romani foedus inierunt et fines imperii sui illic esse voluerunt (Serv., ad Aen. 1, 108). Tali Arae Neptuniae sono generalmente identificate con lo scoglio Keith nella grande secca di Skerki, poco a Sud-Est di Cagliari, ove i fondali sabbiosi raggiungono a 4-5 metri di profondità e dove è certo difficile navigare col mare in burrasca, anche per le imbarcazioni di modesto pescaggio quali dovevano essere le triremi immaginate da Virgilio, a causa della forte corrente e in qualche caso dei frangenti.
Alla luce degli ultimi studi mentre Enea spinto da Aquilone avrebbe navigato verso Sud fino alla Grade Sirte secondo la rotta già attribuita agli Argonauti (Arae Philenorum), raggiungendo Cartagine in costruzione (dove avrebbe conosciuto la regina fenicia Didone), i suoi compagni (gli Iliensi) con le tre navi spinte da Noto sarebbero sbarcati in Sardegna, originando un popolo della Barbaria al confine con il fiume Tirso: per Diodoro Siculo i Sardi Iolei-Iliensi discendenti dei Greci e dei Troiani ancora all’età di Cesare erano liberi, non soggetti alla dominazione di altri popoli, indipendenti e sovrani (V, 15). A giudizio degli studiosi sarebbero stati i fondatori della letteratura latina Ennio (con gli Annales) e Catone (con le Origines) a creare una sorta di “parentela etnica” tra Romani, Siculi e Sardi, tutti discendenti dai profughi che avevano abbandonato Ilio in fiamme: entrambi gli autori (Ennio e Catone) hanno effettivamente partecipato in Sardegna alla guerra annibalica e combattuto contro i Sardi Pelliti in una terra fertile e marchiata dai nuraghi, le arcaiche costruzioni preistoriche che il mito greco voleva edificate su un progetto dell’eroe Dedalo giunto da Creta e poi da Camico in Sicilia (dalla corte del re Kokalos), prima di ritirasi a Cuma: l’interesse per i mirabilia sardi è tipico della storiografia siceliota, come testimonia proprio la vitalità del mito di Dedalo.
2. La fondazione di Cartagine tra Didone e Augusto.
Dieci anni fa ad Olbia per il XVIII convegno de L’Africa Romana avevamo richiamato lo sbarco di Enea a Cartagine, raccontato nell’Eneide: con gli occhi dell’eroe ci rimane l’immagine dei costruttori di Cartagine, sul colle della Byrsa concesso dai Numidi ingannati dalla regina che astutamente aveva tracciato il perimetro della città con la pelle di toro tagliata a strisce.
Enea dalle colline vicine osserva con l’amico Acate la città, il traffico, le vie; ammira i palazzi (un tempo capanne), le porte, il lastricato delle vie (miratur molem Aeneas, magalia quondam, / miratur portas strepitumque et strata viarum). Scrive Francesco Della Corte ne La mappa dell’Eneide: la città è tutta un cantiere attivo di lavori: i porti scavati per formare un bacino, con i teatri, i tribunali, i templi.
Sono gli architetti della regina Didone che Virgilio rappresenta pieni d’ardore, affaccendati e impegnati nella costruzione della colonia fenicia, con le sue mura gli ingenta moenia, con le sue torri, con i suoi templi, la basilica per l’amministrazione della giustizia, la curia per ospitare il senato: come si vede Virgilio pian piano dalla città di Didone arriva alla colonia romana Iulia Augusta.
I Tiri pieni d’ardore lavorano con gran chiasso:
alcuni elevano mura, costruiscono la rocca
e rotolano macigni con le mani, altri scelgono
il luogo dove alzare la propria casa e intorno
vi disegnano un solco, altri eleggono i giudici,
le cariche pubbliche e il sacro senato;
alcuni scavano i porti, altri in profondità
gettano le fondamenta d’un teatro o ricavano
da blocchi di pietra colonne smisurate,
altissimi ornamenti della futura scena.
Nel rappresentare i costruttori di Cartagine che si affaccendano come migliaia di api in un alveare al principio dell’estate per produrre il miele che profuma di timo, è evidente che Virgilio pensa alla colonia augustea che negli anni in cui scrive sorge come una grande capitale mediterranea, dove il Proconsole d’Africa si trasferisce da Utica, con la nuova basilica giudiziaria tipicamente romana, che sarebbe del tutto anacronistica in età fenicia. Nel fervore degli structores Tyrii della Carthago di Didone, Enea profugo da Troia ma anche ospite accolto con rispetto dalla Regina, vede, con gli occhi di Virgilio, il solco dell’aratro che segna il limite sacro di una colonia, rinnovando il dolore e la speranza che anima coloro i quali costruiscono una nuova città, in contrasto con la visione della sua originaria patria -Ilio- distrutta dalle fiamme.
Non c’è dubbio che Virgilio rifletta nel racconto della Cartagine nascente l’esperienza urbanologica di età augustea in Africa, con il theatrum dalle immanes columnae della frons scaenae tratte dalle cave in cui maestranze addestrate lavorano indefessamente a trarre il materiale lapideo della nuova città. O ancora con le portae delle mura e gli strata viarum, le viae urbane silice stratae. I versi virgiliani esaltano l’attività degli uomini di buona volontà, anche se pure gli dei e le dee sono considerati a tutti gli effetti coinvolti in uno studium e in un’ars che nobilita chi la pratica. Più in generale, Virgilio trova le parole per rappresentare il paesaggio trasformato dall’uomo ai margini del lago di Tunisi, presso il tempio di Giunone eretto dalla regina, là dove si era compiuto il ritrovamento del teschio di un cavallo annunciato dall’oracolo:
“O fortunati coloro le cui mura già sorgono!”
esclama Enea, guardando i tetti della città.
Il dolore di Enea si moltiplica quando proprio nel tempio di Giunone osserva gli affreschi che rappresentano la scena di Achille che trascina il cadavere di Ettore e lo vende a peso d’oro a Priamo; la distruzione di Troia, la città orientale dalla quale proviene:
Sunt lacrimae rerum et mentem mortalia tangunt,
la storia è lacrime, e l’umano soffrire commuove la mente.
Non possiamo andare oltre e mi limiterei a richiamare i numerosi autori che si sono occupati della permanenza di Enea a Cartagine e del rapporto con la regina. Da ultimo Francesca Rigotti ha attualizzato il tema di Didone-Elissa fondatrice di Cartagine, che nel suicidio col ferro e col fuoco vede <<un motivo in più per sottrarla alla dimensione femminea del primato del cuore e riassegnala al primato della politica nella sua qualità di eroina fondatrice e guida della sua gente, di regina capace di affrontare dure prove>>, una donna divina, un capo guerriero certamente a suo agio nel mondo degli eroi fondatori, inesorabilmente maschi.
Più di recente Virgilia Lima sui “Dialoghi Mediterranei” ha riflettuto sui profughi di ieri e di oggi, tra diffidenza, accoglienza e integrazione: sulle orme di Enea, da hostis a fondatore di Roma, nemico per i Rutuli del Lazio, ma hospes per la prima Didone e per i fenici. Il gioco virgiliano tra le parole hostis ed hospes è attualissimo: come non avvicinare Enea fuggiasco che abbandona la città in fiamme agli immigrati di oggi provenienti da Palmira o da Rakka o da Idblil presso Ebla, accolti con emozione ma anche con sospetto in un’Europa scintillante e desiderata, incapace di accogliere e integrare i profughi di guerra ?
Sull’ara provinciale dedicata a Cartagine da P. Perellius Edulus nell’età di Augusto è rappresentato Enea rivestito della corazza che su impulso degli dei trasporta il padre Anchise (che indossa una toga romana) e il figlioletto Ascanio in abito frigio, con un’inversione che indica il desiderio di Roma di tornare alle origini troiane, un progetto che solo Costantino realizzerà con la nascita della seconda Roma, a Costantinopoli: l’immagine, che vediamo in tante altre località mediterranee toccate nel mitico viaggio dell’eroe che salva i suoi Penati, sintetizza la storia di generazioni diverse che arrivano fino ai nostri giorni, se Enea progettava veramente la formazione di una nuova città, di una nuova discendenza, di una nuova lingua, in una parola di una nuova cultura di pace in un Mediterraneo devastato dalla guerra.
3. L’Africa in età romana.
Questa riflessione è iniziata fin dal 1982 con la storia trentennale dei nostri incontri intitolati “L’Africa Romana”, che hanno segnato una prospettiva di ricerca nuova, interattiva, con la presenza di centinaia di archeologi storici, epigrafisti, studenti, con l’ampia collaborazione con i diversi Istituti di ricerca, con molte Università, con numerose Società Scientifiche internazionali, infine con i giovani dell’Associazione Nazionale Archeologi.
In questa impresa, abbiamo sempre voluto distinguere la componente “africana” e “mediterranea” durante il periodo romano al di là della definizione di sintesi “L’Africa Romana”. I nostri Convegni hanno avuto da sempre e continueranno ad avere l’obiettivo di studiare non la romanizzazione del Mediterraneo, ma alla rovescia il contributo che il Nord Africa ha dato alla romanità. In questa direzione è andato il progetto che oltre vent’anni fa ha portato alla costituzione del Centro di studi interdisciplinari sulle province romane dell’Università di Sassari, che concentra la sua attenzione su tematiche provinciali prevalentemente africane: rispetto alla Storia di Roma, che privilegia una concezione unitaria, abbiamo voluto evidenziare il processo delle annessioni dei territori mediterranei da parte di Roma ed in particolare le specificità regionali, le persistenze indigene, gli apporti originali che le differenti realtà nazionali e locali hanno espresso all’interno dell’impero romano. In questo senso lo studio della storia di una provincia o di un insieme di province può giustamente considerarsi come il complemento se non addirittura l’antitesi della Storia Romana tradizionale vista esclusivamente sotto il profilo istituzionale ed organizzativo ed intesa come ricostruzione di quella corrente che provocò un processo di livellamento che introdusse anche sul piano culturale e sociale unitari elementi romani.
Questo tipo di analisi, che nel rapporto tra centro e periferia valorizza gli apporti specifici delle diverse province e supera il tema dell’egemonia e dell’imperialismo, ha lo scopo di evidenziare la complessità del fenomeno della romanizzazione ed insieme di indicare, sul piano culturale, artistico, religioso, linguistico, le diverse soluzioni istituzionali di volta in volta adottate, le articolazioni locali ed il contributo delle singole aree: assistiamo spesso ad una vera e propria maturazione del sistema istituzionale romano, con evidenti innovazioni costituzionali; e insieme sembra andarsi modificando in continuazione l’equilibrio tra colonizzatori romani e popolazioni locali, con l’allargamento a nuovi gruppi etnici ed a nuovi territori. In molti casi i Romani poterono acquisire l’amicizia di popoli federati, legati con un foedus o addirittura tramite parentele etniche più o meno mitiche. L’occupazione dei territori extra-italici fu sostenuta soprattutto grazie al favore dei popoli alleati, alla deduzione di colonie, all’insediamento di veterani, all’attività di gruppi di mercanti italici, ad una vivace politica di municipalizzazione che finì per coinvolgere quasi tutte le città provinciali, alcune delle quali espressero anche imperatori, come Leptis Magna per i Severi.
L’utilizzazione delle fonti può consentire una valutazione globale del mondo antico e tardo antico: dalle indagini storiche e archeologiche più recenti, dalla cooperazione italo-tunisina, dalle ultime pubblicazioni scientifiche, emergono le nuove linee del processo di organizzazione municipale romana, nelle sue stratificazioni storiche e nei suoi condizionamenti determinati da precedenti realtà regionali; è così possibile un approfondimento del tema delle civitates indigene, tribù e popolazioni non urbanizzate, nomadi, seminomadi e sedentarie, raccolte intorno a re e principi indigeni, in un rapporto di collaborazione o di conflitto con l’autorità romana. La persistenza di istituzioni, abitudini, usi e costumi arcaici all’interno dell’impero romano è una delle ragioni della convivenza tra diritto romano classico e diritti locali, anche se spesso improvvise innovazioni sono entrate in contrasto con antiche consuetudini. Solo così si spiega come, accanto all’affermarsi di nuove forme di produzione, di organizzazione sociale, di scambio, in alcune aree siano sopravvissute le istituzioni locali, il nomadismo, la transumanza, l’organizzazione gentilizia, mentre la vita religiosa e l’onomastica testimoniano spesso la persistenza di una cultura tradizionale e di una lingua indigena. Altre problematiche di estremo interesse riguardano il paesaggio agrario, le dimensioni della proprietà, la pastorizia nomade, le produzioni, i commerci di minerali e di marmi come a Chemtou-Simittus, i dazi, i mercati, l’attività dei negotiatores italici o africani come a Sullectum, la dinamica di classe, l’evergetismo, la condizione dei lavoratori salariati, degli schiavi e dei liberti: temi che ora possono essere affrontati con metodi e strumenti rinnovati, grazie anche alle nuove tecniche di indagine, come l’archeologia sottomarina, da noi praticata a Nabeul; gli scavi stratigrafici come a Zama, alla ricerca del campo della battaglia tra Annibale e Scipione; le indagini territoriali come a Numuli, ad Agbia, a Thignica, a Uthina, dove opera un’équipe dell’Università di Cagliari, le prospezioni territoriali anche satellitari, l’ampio utilizzo dei droni, le catalogazioni dei materiali e dei dati su base stratigrafica, le più sofisticate applicazioni informatiche, i modelli virtuali in 3D come a Cartagine e nel Museo del Bardo.
I nuovi studi sulle province romane, intese come ambiti territoriali di incontro tra culture e civiltà, tendono a definire i contorni di quella cultura unitaria mediterranea, che non appiattì le specificità locali ma che si ancorò profondamente alla realtà geografica, al paesaggio, all’ambiente, ma anche ai popoli ed agli uomini: esplorare il confine tra romanizzazione e continuità culturale, tra change e continuity, è compito che deve essere ancora affrontato, al di là della facile tentazione di impossibili soluzioni unitarie, fondate su modelli ideologici precostituiti. Rimaniamo convinti che dovremmo sempre diffidare di alcune categorie astratte oggi molto di moda (“politicamente corrette” per usare l’espressione di G.A. Cecconi) e che sarebbe necessario usare la massima prudenza nell’interpretare il mondo antico: appare evidente la necessità di evitare semplificazioni che non tengano conto della complessità delle situazioni nel tempo e nello spazio. Dobbiamo avere più rispetto per la complessità della storia senza rinunciare a stabilire connessioni, a mettere ordine, a proporre linee di riorganizzazione del passato, per comprendere e spiegare: del resto chi conosce le nostre pubblicazioni, sa bene come l’approccio di fondo portato avanti dai nostri ricercatori associati sia decisamente anticolonialista.
4. Colonizzazione, nazionalismo, panarabismo
Nella visione coloniale europea dell’Ottocento e dei primi decenni del Novecento la civiltà classica in Nord Africa non morì di morte naturale, ma fu assassinata: l’assedio di Ippona da parte dei Vandali nel 430 pochi mesi dopo la morte di Agostino, rende solo in parte l’idea di una cittadella della cultura travolta dalla montante marea barbarica, mentre i superstiti cercavano rifugio nelle terre transmarine. Più ancora, nel 698 la conquista ummayyade di Cartagine bizantina da parte degli Arabi di Damasco insediati a Kairouan è stata considerata simbolicamente la data finale della cultura classica, per quanto noi possediamo iscrizioni latine con l’era della provincia che si estendono in Marocco ancora per alcuni secoli e per quanto siano sopravvissuti a lungo nel Nord Africa islamico dei principati berberi cristiani. Il trasferimento delle reliquie di Agostino da Hippo Regius a Karales e poi nel 721 d.C. a Pavia effettuato a quanto pare di fronte all’avanzata araba è stato interpretato simbolicamente come il punto conclusivo del momento più maturo della classicità e insieme come l’annunzio di tempi nuovi, con l’apertura (futuhat) del Nord Africa all’Islam, quando si manifesta l’aspirazione verso un nuovo universalismo. Nel contrasto tra mondi tanto diversi, la cultura araba fortemente motivata sul piano religioso finì per diventare egemone ed espansiva, a danno di quella romana e di quella giudaico-cristiana, che pure hanno lasciato tracce evidenti anche nel Maghreb di oggi. La riscoperta delle rovine archeologiche, delle iscrizioni, dei monumenti è avvenuta innanzi tutto in Algeria nell’Ottocento al seguito dell’esercito coloniale francese, con l’obiettivo romantico di ripercorrere le strade di una civiltà perduta, di ritrovare le radici dell’anima europea del Nord Africa travolto dagli Arabi: paradossalmente i Berberi dell’antica Numidia avrebbero mantenuto con le loro croci tatuate come ad Haidra una sbiadita memoria del cristianesimo originario. Cinquanta anni più tardi anche in Tunisia le scoperte archeologiche furono effettuate inizialmente dagli ufficiali dell’esercito di occupazione francese. Con la colonizzazione si affermava una nuova cultura egemone e restò ormai fissata nell’immaginario collettivo dei popoli del Maghreb l’idea di una forzatura, di una strumentalizzazione del mondo classico al servizio della prospettiva coloniale francese in Algeria e Tunisia, ma anche italiana in Libia e spagnola in Marocco.
Nel momento in cui i paesi del Maghreb ritrovavano, dopo la seconda guerra mondiale, una loro sovranità nazionale, la conseguenza inevitabile fu una reazione contraria, una sostanziale sottovalutazione delle radici classiche e una enfatizzazione, in realtà purtroppo spesso solo teorica, delle fasi islamiche della storia del Nord Africa. Teorica perché se è vero che sullo sfondo c’è il convinto apprezzamento per la grande cultura araba arrivata anche ad influenzare l’Europa cristiana; di fatto però le fasi medievali del primo insediamento arabo in Ifriqya non sono mai state studiate davvero scientificamente e la cultura materiale islamica delle origini non ha fin qui avuto una presentazione adeguata. Nel quadro della progressiva indifferenza per il patrimonio pre-islamico, indubbiamente la Tunisia a partire dal 1956 con Bourghiba ha rappresentato un’eccezione nel panorama dei paesi del Maghreb, grazie all’impegno dell’Institut National d’Archéologie et d’art, da vent’anni anni trasformato in Institut National du Patrimoine al quale si affianca l’azione dell’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle della Tunisia che ha la specifica missione di gestire monumenti e musei archeologici. Enti che hanno sostenuto molte grandi imprese internazionali in particolare europee, che spesso però furono costrette a cambiare decisamente i loro obiettivi.
Con la “primavera araba”, con la fuga di Ben Ali il 14 gennaio 2011, si era evitato che i lunghi e brillanti periodi preislamici del Maghreb potessero rappresentare una minaccia per il progetto di panarabismo dominante. Dopo la crisi del 2012-13, oggi si rende sempre più necessario riprendere un cammino che sarà possibile solo partendo dalla consapevolezza che il patrimonio rappresenta una ricchezza anche per l’identità della Tunisia di oggi, superando nel rispetto dovuto la strumentalizzazione del passato per scopi politici o religiosi.
Nel mondo di oggi, in un Mediterraneo che rischia di disgregarsi, dovremmo tutti contribuire a superare il concetto di “culture egemoniche” e “culture subalterne” per costruire una strada da percorrere insieme, per capire i valori positivi della globalizzazione, per alimentare un dialogo tra culture diverse che non rinuncino ad essere se stesse. Il ruolo delle Università, delle istituzioni, dei Comuni, delle Regioni può essere davvero importante.
4. La nostra esperienza.
Anche nelle condizioni difficili e terribili di questi anni, in particolare tra l’abbattimento delle torri gemelle l’11 settembre 2001 e il fallimento delle primavere arabe, non è cessato l’impegno di costruire ponti tra le due rive del Mediterraneo, con il senso di un’attenzione e di un rispetto che vogliamo affermare, di un incontro e di una speranza. A Roma (il 12 maggio 2016) Isabel Rodà, Sergio Ribichini e Mario Mazza hanno presentato all’Istituto Nazionale di Studi Romani il XX volume de “L’Africa Romana”, dedicato in memoria delle vittime innocenti del tragico attentato al Musée National du Bardo con la solidarietà di tutti gli studiosi al popolo della Tunisia libera e democratica. Abbiamo in programma il XXI congresso internazionale de L’Africa Romana a Gafsa in Tunisia nel dicembre 2018, sul tema delle nuove scoperte epigrafiche.
L’Università di Sassari ha costantemente continuato a lavorare in Tunisia senza interruzione, con i finanziamenti ottenuti dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.
A Uchi Maius un pagus romano nel territorio di Cartagine, con Mustapha Khanoussi, Cinzia Vismara, Marco Milanese, Paola Ruggeri, Antonio Ibba, Giampiero Pianu, Alessandro Teatini A Zama con Piero Bartoloni, Michele Guirguis, Ahmed Ferjaoui. A Neapolis oggi Nabeul negli scavi di archeologia subacquea della Scuola di specializzazione di Oristano diretta da Raimondo Zucca, con Piergiorgio Spanu e Mounir Fantar. Ora anche a Thignica nel territorio della colonia augustea di Cartagine con un’équipe composta da me, Antonio Ibba, Paola Ruggeri, Raimondo Zucca, Salvatore Ganga, Samir Aounallah, Mustapha Khanoussi, Lamia Abid, Hamden Ben Romdhane, Ali Cherif. Per l’iconografia delle stele di Saturno: Lamia Abid, Arij Limam, Bruno D’Andrea. Da ultimo a Cartagine nelle terme di Antonino e al Museo del Bardo a Tunisi con Samir Aounallah. A Uthina con Giovanna Sotgiu, Antonio M. Corda, Habib Ben Hassen.
Sono proprio i colleghi italiani, penso a Marco Milanese, che hanno allargato le loro ricerche sul piano della cultura materiale islamica e tentato per la prima volta una seriazione delle produzioni. I nostri scavi sono stati portati avanti insieme dai nostri studenti italiani, circa 500, e dai loro colleghi magrebini, in particolare gli allievi dell’Institut supérieur des metiers du patrimoine dell’Università di Tunis. Siamo davvero convinti che dobbiamo contribuire ad avviare una nuova stagione della conoscenza scientifica e pluriculturale della storia e dell’archeologia del Mediterraneo fondata sul contributo congiunto e dialogante di tutte le sponde del Mare comune.
Del resto non mancano notizie straordinarie come il premio Nobel assegnato per la pace al “quartetto” tunisino, espressione dell’’ Unione Generale Tunisina del Lavoro (in francese “Union Générale Tunisienne du Travail”, UGTT); dalla Confederazione Tunisina dell’Industria (in francese “Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat”, UTICA), della Lega Tunisina per la Difesa dei Diritti dell’Uomo (in francese “Ligue Tunisienne pour la Défense des Droits de l’Homme”, LTDH), dell’Ordine Nazionale degli Avvocati di Tunisia (in francese “Ordre National des Avocats de Tunisie”, ONAT).
6. Il progetto della Fondazione di Sardegna.
Il 25 giugno 2014 si è svolto a Cagliari l’incontro Unimed “Sardegna terra di Mezzo” promosso dalla Fondazione di Sardegna. Nel frattempo le primavere arabe si sono rivelate “inverni” terrificanti, l’insicurezza ha travolto alcuni paesi, il 18 marzo 2015 l’attentato al Museo Nazionale del Bardo è stato un colpo terribile inferto all’economia della paese, ai beni culturali, al patrimonio, soprattutto alle relazioni tra studiosi. Il 26 marzo, pochi giorni dopo l’attentato, abbiamo organizzato a Sassari il convegno “Il canto del Bardo, Il Museo mediterraneo di Tunisi tra ricordi e speranze” voluto da Paola Ruggeri. Il 9 aprile successivo si è svolto il convegno sulla preistoria nei musei del Bardo di Tunisi e Algeri (Henri Lhote e l’arte africana prima dei mosaici) voluto da Anna Depalmas.
Trovo però straordinario il risultato conseguito dal progetto ForMed della Fondazione di Sardegna e di Unimed che ha consentito la permanenza biennale a partire dal dal I ottobre 2015 di 100 studenti magrebini che studiano presso le due Università. Altri studenti partecipano ai dottorati e agli scavi archeologici, così come in passato. Io stesso con Paola Ruggeri ho seguito le prime tre laureate magistrali in archeologia che hanno concluso a luglio 2017.
Abbiamo pubblicato il libro “Je suis Bardo” e presentato a Tunisi per iniziativa del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e dell’Ambasciata d’Italia il 18 marzo 2016 il XX volume degli Atti de L’Africa Romana e gli scavi archelogici tuniso-italiani.
7. La Scuola archeologica italiana di Cartagine.
A Sassari il 22 febbraio 2016 è stata costituita la Scuola Archeologica Italiana di Cartagine, oggi arrivata a 160 associati, interessata ad operare in campo internazionale. Dal 10 maggio 2016 la SAIC è iscritta al n° 31 nel “Registro delle Persone Giuridiche” presso la Prefettura di Sassari.
Il lungo percorso che ha portato alla nascita della Scuola è stato recentemente ricostruito da Sergio Ribichini che ha ricordato il programma, lo stato dell’arte, la specificità della futura Scuola, il suo partneraiato, la sua struttura, i suoi obiettivi, le tappe, le risorse finanziarie. Questo documento di base è stato oggetto dell’ «Atelier de recherche» che si svolse a Roma il 18 dicembre 2014 presso il CNR e che ha visto la partecipazione di numerose autorità, di parecchi responsabili di missioni finanziate dal MAECI e dei membri delle équipes italiane che lavoravano ad Althiburos e ad Uchi Maius.
L’iniziativa ha visto convergere soggetti diversi in una lunga fase di preparazione, specialmente Università italiane (con i due Dipartimenti di Storia scienze dell’uomo e della formazione dell’Università di Sassari e di Storia, Beni culturali e territorio dell’Università di Cagliari in prima fila), altre Università straniere, Istituzioni, in particolare l’Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico del Consiglio Nazionale delle Ricerche, con l’Agence National de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle di Tunisi, l’Institut National du Patrimoine di Tunisi, la Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese, Settore «Archeologia», del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’Istituto italiano di cultura di Tunisi, l’Istituto di studi e programmi per il Mediterraneo. Il Consiglio del Dipartimento dell’Università di Sassari l’8 luglio 2015 aveva deliberato di ospitare a Sassari a Palazzo Segni in Viale Umberto 52 la SAIC, che ha siglato un accordo di collaborazione col Rettore dell’Università di Sassari nel luglio 2016. In base a tale accordo, il dottorato di ricerca “Archeologia, storia scienze dell’uomo” dell’Università di Sassari ha bandito una borsa di dottorato riservata a studenti magrebini (XXXII ciclo). Nel corso dell’assemblea 12 maggio 2016 a Roma presso l’Istituto Nazionale di Studi Romani, grazie alla cortesia di Paolo Sommella, alla presenza dell’ambasciatore della Tunisia S.E. Naceur Mestiri, è stato presentato il XX volume per il trentennale de L’Africa Romano; nell’occasione è stata firmata la convenzione della Scuola Archeologica Italiana di Cartagine con con l’Agence Nationale de Mise en Valeur et d’Exploitation du Patrimoine Culturel della Tunisia, rappresentata da Samir Aounallah. La convenzione prevede l’assenso del prof. Ridha Kaabia direttore dell’Agence per l’assegnazione in comodato d’uso di aule e locali di segreteria per la SAIC, con attività comuni, in particolare la pubblicazione di una Guida di Cartagine plurilingue. La SAIC si propone di favorire con le sue attività forme di coordinamento tra iniziative che caratterizzino la cooperazione italiana in Tunisia (e più in generale nei Paesi del Maghreb) in ambito scientifico-culturale. Si propone altresì di configurare un intervento organico, collegiale e articolato, capace di favorire opportunità di ricerca, formazione e diffusione delle conoscenze sul patrimonio relativo alle civiltà preistoriche e protostoriche, preclassiche, classiche, tardo-antiche, islamiche, moderne e contribuire attivamente al dialogo interculturale e alle politiche di sviluppo della Tunisia (e più in generale dei Paesi del Maghreb). In questi mesi siamo riusciti a creare una biblioteca specializzata in Archeologia, Scienze dell’Antichità e Tecnologie applicate ai Beni Culturali, Storia dell’Arte intitolata ad un grande Maestro, Sabatino Moscati, presso i locali della Scuola nell’Agence di fronte all’Istituto Italiano di cultura.
Sono stati aperti il sito web http://www.scuolacartagine.it/ (info@scuolacartagine.it) e la pagina Facebook: https://www.facebook.com/SAIC-Scuola-Archeologica-Italiana-di-Cartagine-268443213487415/, che viaggia attorno ai mille like ed ai 4000 contatti settimanali.
E’ nata una rivista elettronica (“Caster”) diretta da Antonio Corda e una collana di Monografie diretta da Paola Ruggeri. La Scuola è presente su altri principali Social, anche allo scopo di coordinare le attività archeologiche italiane in Tunisia.
Presso l’Istituto Italiano di Cultura abbiamo svolto il 18 marzo 2016 e il 17 marzo 2017 due incontri dedicati al tema “Archeologia e tutela del patrimonio di Cartagine: lo stato dell’arte e le prospettive della collaborazione tuniso-italiana”; gli atti sono stati pubblicati nella Monografia n. 1 e nel secondo numero della rivista “Caster”.
Sono Soci Ordinari della SAIC coloro che hanno la titolarità di progetti di cooperazione con la Tunisia. Taluni di tali progetti, più precisamente, usufruiscono di un cofinanziamento della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del MAECI (Settore Archeologia), impegnata in favore delle Missioni archeologiche, antropologiche ed etnologiche italiane all’estero e all’attribuzione di borse di studio a ricercatori di paesi stranieri.
La Sede legale in Italia è presso il Palazzo Segni, Università degli Studi di Sassari, Dipartimento di Storia, scienze dell’uomo e della formazione, Viale Umberto, 52 – 07100 Sassari. La Sede operativa a Tunisi è presso l’Istituto Italiano di Cultura – Ambasciata d’Italia, Avenue Mohamed V, 80.
Il 12 maggio 2016 è stato siglato l’accordo di collaborazione tra SAIC e l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle, che ha messo a disposizione della SAIC i locali di Tunisi Belvedere per la Biblioteca Sabatino Moscati e per gli uffici della Scuola. E’ in corso la stipula dell’accordo con l’Institut Supérieur des Sciences Humaines de Tunis / Université de Tunis El Manar ISSHT (26, Avenue Darghouth Pacha – Tunis) diretto dal prof. Taoufik Aloui. Il 17 marzo 2017 abbiamo inaugurato la nuova sede a Tunisi presso l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle a Tunisi-Belvedere (Rue 8000 Angle Ibn Nadime -Montplaisir, Tunis 1002), con la Biblioteca Sabatino Moscati offerta dalla famiglia alla SAIC che è stata aperta al pubblico il 6 ottobre 2017.
Il 31 dicembre 2016 è stato pubblicato il primo numero della Rivista Cartagine. Studi e Ricerche (abbreviazione CaSTeR) con sottotitolo Rivista della Società scientifica “Scuola Archeologica Italiana di Cartagine” diretta da Antonio Corda (http://ojs.unica.it/index.php/caster/issue/view/72/showToc).
Abbiamo presentato il primo volume della serie delle monografie, con gli atti dell’incontro di Tunisi del 18 marzo 2016, svoltosi in occasione del primo anniversario dell’attentato al Museo Nazionale del Bardo di Tunisi presso l’Istituto Italiano di Cultura.
Erano presenti tra gli altri l’ambasciatore d’Italia Raimondo De Cardona, la Direttrice dell’IICTunisi Maria Vittoria Longhi, per il MAECI Manuela Ruosi ed Ettore Janulardo, il direttore generale dell’INP Fathi Bahri, il responsabile delll’Agence Nationale de Mise en Valeur du patrimoine et de promotion culturelle Show Dauda per il Directeur Général Ridha Kacem, il Vice Direttore dell’Isprom Giovanni Lobrano, la Vice Presidente della Fondazione di Sardegna Angela Mameli, la Presidente del Consiglio Comunale di Sassari Esmeralda Ughi. Nel pomeriggio la SAIC era rappresentata alla cerimonia per ricordare i caduti al Museo del Bardo (erano presenti il Rettore dell’Università di Sassari Massimo Carpinelli e il Presidente della Regione Sarda Francesco Pigliaru). E’ stato presentato il volume di grande formato curato da Samir Aounallah Je suis Bardo.
A Roma il 6 ottobre 2016 presso l’Istituto Nazionale di Studi Romani sono stati presentati da Attilio Mastino e Giorgio Rocco i due volumi di Studi Africani di Antonino Di Vita, curati da Maria Antonietta Rizzo Di Vita e Ginette Di Vita Evrard.
Il 17 marzo 2017 per iniziativa della Scuola archeologica italiana di Cartagine, d’intesa con l’Istituto Italiano di Cultura, la Fondazione di Sardegna, l’Istituto di Studi e Programmi per il Mediterraneo, l’Institut National du Patrimoine e l’l’Agence National de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle di Tunis si è svolta la seconda edizione degli incontri bilaterali sul tema “Archeologia e tutela del patrimonio di Cartagine: lo stato dell’arte e le prospettive della collaborazione tuniso-italiana”, con un programma quanto mai significativo sul piano scientifico, aperto dall’Ambasciatore Raimondo De Cardona. L’iniziativa è stata promossa con la partecipazione dei nostri studenti della Scuola di specializzazione di archeologia di Oristano: Annalucia Corona, Ernesto Insinna, Davide Fiori, Donatella Bilardi, Alessandro Madau.
Il 6 ottobre 2017 dopo la Assemblea della Saic presso l’Istituto Italiano di Cultura è stata inaugurata la Biblioteca Sabatino Moscati alla presenza di Paola e Laura Moscati e di un vasto pubblico italiano e tunisino.
Breve bibliografia
F. Cassola, Cartagine, in Enciclopedia Virgiliana, pp. 680 ss.
F. Della Corte, La mappa dell’Eneide, La Nuova Italia editrice, Firenze 1985
A. Ibba, La Cooperazione degli atenei sardi con i paesi del Maghreb: motivazioni, risultati, prospettive negli studi classici. Sassari, Università degli studi di Sassari, 2007
A. Mastino, Le Sirti negli scrittori di età augustea, in L’Afrique dans l’Occident romain (Ier siècle av.J.-C.-IVe siècle ap. J.-C.). Actes du colloque organisé par l’École Française de Rome sous le patronage de l’Institut National d’Archéologie et d’Art de Tunis (Rome, 3-5 décembre 1987), Roma 1990, pp. 15-48
A. Mastino, Cornus e il Bellum Sardum di Hampsicora e Hostus, storia o mito ? Processo a Tito Livio, in Il processo di romanizzazione della provincia Sardinia et Corsica, Atti del convegno internazionale di studi, Cuglieri, 26-28 marzo 2015, a cura di S. De Vincenzo, Ch. Blasetti Fntauzzi (Analysis Archaeologica. An international Journal of western mediterranean Archaeoogy), Monograph Series n. 1), Quasar, pp. 15-67
A. Mastino, L’attività della Scuola Archeologica Italiana di Cartagine (SAIC) nel 2016, in Archeologia e tutela del patrimonio di Cartagine: lo stato dell’arte e le prospettive della collaborazione tuniso-italiana, Atti del seminario di studi raccolti da P. Ruggeri (Le Monografie della SAIC, 1), Saic Editore 2017, pp. 9-19
P. Ruggeri (cur.), L’Africa Romana XX, Momenti di continuità e rottura: bilancio di trent’anni di convegni L’Africa Romana, I, II, III, Carocci editore, Centro studi interdisciplinari sulle province romane, Sassari 2015
Presentazione del volume di Giovanni Soro, Camineras
Presentazione del volume di Giovanni Soro, Camineras
Attilio Mastino
Chiaramonti, 29 ottobre 2017
 Ho visto all’opera il prof. Giovanni Soro e il Coro Matteo Peru di Perfugas in tanti luoghi della Sardegna, in particolare nell’aula magna dell’Università di Sassari in occasione delle ripetute visite dei suoi amici dell’Università di Surin nella Tainlandia del Nord-Est. Così il 13 agosto 2013, quando ricevette assieme a Paolo Puddinu l’elefante d’oro dal presidente della fondazione tailandese “Surindra International Folklore Festival” Achara Phanurat, già Rettore dell’Università tailandese di Surin, il più alto premio della fondazione tailandese.
Ho visto all’opera il prof. Giovanni Soro e il Coro Matteo Peru di Perfugas in tanti luoghi della Sardegna, in particolare nell’aula magna dell’Università di Sassari in occasione delle ripetute visite dei suoi amici dell’Università di Surin nella Tainlandia del Nord-Est. Così il 13 agosto 2013, quando ricevette assieme a Paolo Puddinu l’elefante d’oro dal presidente della fondazione tailandese “Surindra International Folklore Festival” Achara Phanurat, già Rettore dell’Università tailandese di Surin, il più alto premio della fondazione tailandese.
Il riconoscimento intendeva mettere in evidenza l’efficace attività relazionale dei due professori con la prestigiosa istituzione tailandese. In particolare Giovanni Soro, già preside e dirigente scolastico nelle scuole secondarie italiane, ha il merito di avere stretto i primi rapporti con l’Università di Surin, dove ha insegnato per alcuni anni Cultura italiana e latina ma anche tradizioni popolari della Sardegna, giovandosi del costante rapporto scientifico con Mario Atzori e Maria Margherita Satta.
Questo volume Camineras, tradotto in italiano con Orme e in francese dans les chemins, fortemente voluto da Maria Silvia Soro, da Vittorio Pinna, da Antonio Murziani, da Angelino Tedde, con la traduzione francese curata prima da Mariella Fiori e poi da Pietruccia Bulla, racconta una vita intera, che inizia con le poesie perdute dei primi anni 60 ritrovate da Antonio Canalis negli archivi del Premio Città di Ozieri, Notte incantada, Orgosolo e Cantigu de fozas: come non pensare, fatte le debite proporzioni, al recente volume di Annico Pau dedicato ai Canti Perduti di Sebastiano Satta? Un dono alla città di Chiaramonti e alla Sardegna tutta, con i paesaggi amati che riemergono nella solitudine delle campagne, delle pianure e delle alture, i montijos, della nostra Isola.
C’è sullo sfondo di queste poesie la fatica del vivere, sa mattana de istare die pro die in cuiles e cussorzas inue sos pastores, sos massaios, sos linnajolos e i sos carvonajos che colaian bastante de su tempus insoro. Siamo nella Sardegna dell’immediato secondo dopoguerra, sembra di rinnovare la pena delle pagine di Joyce Lussu su L’olivastro e l’innesto, con una specie di bestemmia contro l’ingiustizia, il dolore, la fame, le malattie, ma anche con la forza data in Sardegna dai legami familiari, dai sentimenti e dalle speranze di un tempo nuovo.
La traduzione letterale di camineras, che del resto troviamo nei testi delle poesie, sarebbe sentieri; la traduzione del titolo con orme non è fedele, eppure rimanda a Sos Arrastus, all’affannata ricerca delle orme, delle tracce, delle testimonianze lasciate dagli uomini e dagli animali in una cultura pastorale ferita dall’abigeato che continua a vivere nel profondo. In un libro recente Mario Medde racconta la primavera insanguinata del 1922, l’immagine dei mozziconi delle orecchie delle pecore rubate e mutilate, recisi e abbandonati lungo Sa Bia de Cotzula a Norbello verso Domus. Segni della proprietà del bestiame recisi con la mutilazione delle pecore. Segni che proiettano nella memoria quasi in un film la corsa disperata della nonna incinta di 7 mesi verso la chiesa della Madonna delle Grazie ad Orracu, per ritrovare alla fine sconvolta il corpo insanguinato del compagno ucciso su questo caminu de sa fura che conduceva ad Otzana e ai monti della Barbagia dove transitava il bestiame rubato nella valle. Un’ingiustizia, l’uccisione di un testimone scomodo, che i pastori specialisti de s’arrastu, alla ricerca delle orme degli abigeatari, non avrebbero saputo vendicare.
S’Arrastu, ancora su un altro sentiero, quello che da Pranu ‘e lampadas portava a Sa Serra, e che riporta alla mente il tragico ricordo della morte, nel 1953, dell’altro nonno, quello paterno, colpito da una roncolata inferta da un altro pastore: Mario Medde scrive commosso che per anni le pietre insanguinate sul punto dove cadde il nonno restarono così disposte e macchiate, mute testimoni di un delitto orrendo, di una violenza gratuita, di un abuso non più comprensibile.
Come nelle mostre di un artista che amo Antonio Ledda, in queste poesie c’è una campagna spesso violata, la voglia di capire il passato più doloroso, la violenza, frutto dell’ingiustizia e della prevaricazione in una Sardegna arcaica, in una società agropastorale ormai al tramonto, in un territorio di frontiera battuto da un vento maledetto che avanza sui campi di asfodelo e di cisto, subra roccas antigas de granitu. Il vento salmastro / del mare /che inaridisce i germogli / delicati / e uccide le attese nel cuore. Ma anche il vento forte che soffia da ponente, capace di portar via le pene, prosighi forte, lèache sas penas!
Seguendo questo filo rosso, è ora possibile scorrere il telaio della vita, su telarzu de sa vida, les châssis de la vie, osservare le stelle e constatare che anche la luna / a falce / ha lacrime / che muoiono / nel canto lento / del tempo. Quella luna gloriosa col suo lieve solco d’argento che continua a baciare i voli stanchi del mondo. Così il sole coi suoi raggi nascosti dalle nuvole e le stelle che si affacciano a mari tempestosi. Stelle che sembrano accompagnare mestamente i brividi nascosti della campana dell’anima che tristemente rintocca e rinnova il tormento, mentre nell’autunno che si affaccia inesorabile i desideri, sos disizos, vanos ingannos, / mudos e tristos / sun’ diventados /e malzidu an’ogni / frua noella, e hanno consumato / ogni germoglio / novello.
Ci sono soprattutto questi versi straordinari dedicati al padre, pro te apo disizadu, che raccontano di tanche sconfinate a lungo desiderate, di campi seminati, di pecore e bianchi agnelli, e grassi buoi e solchi neri e praterie in fiore rugiadose, cieli chiari, ruscelletti e albori senza fine. Ma il fuoco ha sterminato il gregge, prima dell’alba morivano i sogni e so restadu a piangher, / a piangher sos disios / de sa vida tribulada / chi promittit avreschidas seguras, qui inutilmement promet / des aubes sûres.
Il filo dei ricordi, s’ispau de sos ammentos, è raccolto da mani prive di speranza, un po’ come con Giovanni Nurchi osservando il trascorrere del tempo, Ajò, lassademi istare / pensamentos chi mi ‘occhides ! / e ad ite mi cherides / su passadu ravvivare ? Giovanni Soro racconta di cantos ammentos feridos / che s’acceran’ intro su coro, suscitando una poesia che finisce per essere attrivida, tra ruscelli di lacrime e di sangue, rizolos de lagrimas e de sanben (Cantigu de fozas).
Mentre tutto attorno dilaga la solitudine, gli amici si perdono, non sezis torrados o amigos, a cantare sos àlidos de su coro. Eppure ancora vi aspetto all’imbrunire, amici, fratelli, figli, persone care che tornano lungo i leggeri sentieri dello spirito, perché alla fine sa vida est isperea / chi non moridt, / es’promissa / chi non finit, / es’gherra / chi faghet omnines, est allegria / de riu mannu / chi cantat pasadu / sa felizidade / de un’iscuta, di un istante luminoso e indimenticabile.
Eppure basta il suono solitario di un organetto alla cantonata nella notte incantata (Chiaramonti 1961) per ricordare un amore ismentigadu; e gli occhi vividi dei vecchi che rammentano la giovinezza sanno di eternità; at torrare maju / e-i su sole / at a imperare pro infonder sos ammentos, resti di fanciullezza di quell’alba lontana; Mai revendra / et le soleil / aigusera / le retour des souvenirs / les reste de l’enfance / de cette aube-là lointaine. Oggi è possibile ritrovare stupiti l’incanto e la bellezza de sa pitzinnia, riuscire a cogliere sensazioni perdute, sa ‘oghe ch’addulchit sa tristura ‘e sos anneos, la mestizia o la melanconia degli affanni.
Il benessere, la gioia, la felicità di un tempo lontano, le speranze, i desideri, che riscopriamo osservando il paese disteso sulla collina come un vecchio addormentato, il paese di pietra bianca, triulada, chena alimentu, tribolato senza cibo, che attende nella roccia del cuore spossato e stanco stagioni di acque fresche capaci di trascinare giù fino al mare turmentos mannos. Perché dopo il lungo percorso sconsolato, che ha provocato tante piaghe alluttas chi ochin su coraggiu, ora il sole del mattino ti stringerà la mano con occhi di gioia, le mani di rugiada abbracceranno felici le ansiose vie della speranza, per quanto l’amore sia simile alle foglie d’autunno che volano e cadono sull’uomo dentro il cuore. Eppure, lasciatemi questa notte, ca devo saludare calicuna / ch’isettat pro mi poder abbratzare. Tanti sentimenti, tanti affetti, tante presenze, come quella sempre presente di questa figlia incantevole, charmante, bijou précieux, amour convoité, ruisseau de caresses, ciel fatigué, maison de merveille.
C’è in queste piccole e deliziose poesie la capacità di stupire, di emozionare, di incantare con una passione che non si spegne, con le carezze che si rinnovano, con la voglia forte di smettere finalmente di piangere con lo scopo di vivere pienamente per i giorni futuri – lo scriveva a Badesi vent’anni fa – solo col sole di oggi.
Messaggio di Attilio Mastino alla 58° edizione del Premio città di Ozieri.
Messaggio di Attilio Mastino alla 58° edizione del Premio città di Ozieri
Ozieri, 2 ottobre 2017
impegnato in Tunisia negli scavi della Scuola archeologica italiana di Cartagine, mi è impossibile essere presente oggi a questa splendida 58° edizione del Premio Ozieri, che ho seguito attraverso le opere di tanti appassionati poeti che abbiamo valutato in una giuria composta da studiosi e specialisti di grandissimo livello. Li ho osservato lavorare in questi mesi con passione ma anche con una conoscenza della cultura della Sardegna che non ha eguali. Lasciatemi dire grazie a tutte le autorità, al Presidente e soprattutto al segretario del Premio Antonio Canalis e alla sua famiglia.
Voglio soltanto raccontare l’impressione che ho tratto nel corso dell’ultima riunione del 2 settembre, quando abbiamo selezionato le opere da premiare: la discussione all’interno della giuria è stata per me davvero interessante, salutare, piena di informazioni e di indicazioni di metodo. Ho soprattutto ascoltato con rispetto e con emozione, facendo tesoro delle osservazioni sul metro, sulla sintassi, sulle immagini letterarie, perfino sulle zoppie volute oppure casuali di una lingua che deve trovare una sua progressiva convergenza. Il quadro che mi sto facendo dei tanti poeti che partecipano al Premio Ozieri si radica ancora di più, coinvolge le nuove generazioni, attraversa tutta l’isola e allarga il suo sguardo verso orizzonti lontani, in un Mediterraneo globalizzato che vorremmo in pace.
Voglio però manifestare ancora una volta la gratitudine e il rimpianto per il nostro Presidente onorario Nicola Tanda, che prima di me ha presieduto la nostra Giuria per oltre vent’anni e che mi aveva chiamato a sostituirlo, con una generosità che mi aveva lasciato senza parole. Una delle ultime volte che lo avevamo incontrato era stata al freddo, sulla terrazza delle terme di Palazzo di Re Barbaro a Porto Torres in occasione della straordinaria performance di Clara Farina sulla Vestale Massima Flavia Publicia: uno spettacolo bellissimo e poetico che ci aveva incantato, anche se Nicola aveva tentato di portarmi via la giacca per difendersi dal freddo. Lo abbiamo ricordato con gli amici una settimana fa in occasione dei Vinalia Turritana, che si sono svolti sulla stessa terrazza e con lo stesso freddo.
Il nostro Nicola è scomparso il 4 giugno 2016 a 88 anni di età a Londra, assistito dal figlio Ugo. Il luogo stesso della sua scomparsa la dice lunga sulla sua dimensione non provinciale ma aperta al mondo, fortemente radicata a Sorso dove era nato il 22 dicembre 1928. Proprio negli ultimi giorni progettava il rilancio in Sardegna del PEN Club, l’Associazione internazionale di poeti (poets), saggisti (essayists) e romanzieri (novelists), fondata a Londra nel 1922 dagli scrittori Catharine Amy Dawson Scott e John Galsworthy allo scopo di sviluppare la collaborazione fra gli intellettuali di tutti i paesi. Ma se anche restiamo all’orizzonte isolano, sullo sfondo c‘era una scelta non scontata, la progressiva codificazione e circolazione letteraria plurilingue che è alla base anche dell’edizione del Premio Ozieri negli ultimi anni.
Nicola considerava Ozieri (la sua città di adozione che gli aveva conferito la cittadinanza onoraria), la culla della lingua sarda, per usare l’ espressione del giornalista franco-corso Xavier Perlovisi, Ozieri “ville historique, parraine de la protection de la langue sarde”. E ciò anche nei tempi dell’accertato mancato assolvimento da parte dell’Italia degli obblighi imposti dalla Convenzione quadro delle minoranze nazionali in vigore da vent’anni. Proprio ad Ozieri ci aveva chiamato a confrontarci alcuni anni fa sullo straordinario carattere plurilingue (in logudorese, italiano, castigliano) dell’opera Rimas diversas Spirituales di Gerolamo Araolla, vissuto nella seconda metà del 500. E poi a Ozieri è nato Matteo Madao che ha scritto in italiano il Saggio di un’opera intitolata Il ripulimento della lingua sarda lavorato sopra le sue analogie colle due matrici lingue la Greca e la Latina (Cagliari 1782), con il proposito di far acquistare prestigio alla lingua sarda. Altro personaggio ozierese importante è Francesco Ignazio Mannu (Ozieri 1758 – Cagliari 1839), che ha esercitato l’avvocatura a Cagliari e durante il triennio rivoluzionario sardo (1793-96), è stato avvocato dello Stamento militare, particolarmente attivo nel rivendicare l’autonomia del Regno sardo e l’abolizione dell’anacronistico sistema feudale. Tra la fine del 1795 e gli inizi del 1796, ha composto, l’inno “Su patriota sardu a sos feudatarios”, che esprime il sentimento di ribellione contro le ingiustizie (custos tirannos minores / est precisu umiliare). Francesco Ignazio Mannu si è rivolto al popolo sardo in lingua sarda. E Tanda osservava: <<non più di sessanta anni dopo la sua morte, un poeta come Sebastiano Satta, si rivolgerà al popolo sardo in italiano>>.
Nel mio intervento di un anno fa ho ricostruito il percorso tracciato da Nicola Tanda quando raccontava la storia del Premio Ozieri attraverso i verbali delle diverse Giurie, utilizzando il Fondo manoscritti in lingua sarda, partendo dalla prima edizione con 50 partecipanti in occasione della festa di N.S. del Rimedio del Settembre 1956, grazie al maestro Tonino Ledda, ma sulla scia della lezione del poeta Antonio Cubeddu. Rileggendo i giudizi delle giurie del primo decennio, Nicola affermava con ottimismo: <<quando esiste un ascolto, cioè un orecchio linguisticamente e letterariamente competente, anche la produzione poetica e letteraria migliora>>. La poesia sarda non è una poesia dialettale, e già <<compaiono concetti e categorie che denotano una maggiore competenza linguistica nuova, che già prelude a quella delle “lingue tagliate” delle minoranze e a una sensibilità diversa circa il ruolo svolto sinora dalla poesia sarda rispetto alle lingue nazionali>>. Per Nicola Tanda con l’Ozieri si rinnova ogni anno il canone della comunicazione letteraria in Sardegna poiché proprio con l’immissione nel sistema linguistico e letterario sardo delle sue poesie si rafforza l’automodello sardo e si raggiunge il traguardo di un vero e proprio bilinguismo letterario sardo–italiano: <<questa produzione letteraria segna l’avvio di quella ripresa della cultura artistica sarda nel suo insieme che non solo ha guadagnato continuamente consensi ma ha posto le premesse di quel ribaltamento della rappresentazione dell’Isola che la ha inserita nell’immaginario collettivo europeo e nel circuito mediatico internazionale>>. Nominato presidente del Premio nel 1990, Nicola avrebbe lasciato la sua impronta profonda, al fianco di Tonino Ledda e poi di Antonio Canalis.
Egli ormai presiedeva il Centro di studi filologici sardi nato nel 1980 e ne dirigeva la collana, che continua ancora oggi a pubblicare (con la casa editrice Cuec) le edizioni critiche delle opere degli scrittori sardi. Proprio per il mio intervento al Premio Ozieri di un anno fa avevo ricostruito attraverso l’Archivio storico dell’Ateneo Turritano il suo straordinario stato di servizio all’Università tra il 1972 (primo incarico di Storia della grammatica della lingua italiana presso la Facoltà di Magistero) al 2001 come professore di Letteratura e Filologia Sarda, con la chiusura del suo mandato di Vice Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia. Nicola Tanda è stato battagliero membro dell’Osservatorio della lingua e della cultura sarda – istituito in applicazione della legge della Regione Sardegna n. 26 del 1997 e della legge dello Stato italiano 482 del 1999 – che tutela, difende, promuove la cultura, la lingua e la letteratura della Sardegna. Tra le sue opere, quelle che più amava: Dal mito dell’isola all’isola del mito. Deledda e dintorni, Roma, Bulzoni, 1992; Un’odissea de rimas nobas: Verso la letteratura degli italiani, Cagliari, Cuec 2003. Nel 2007 aveva pubblicato con Dino Manca l’Introduzione alla letteratura, questioni e strumenti, Cagliari, Centro di studi Filologici Sardi, Edizioni Cuec.
Ci mancheranno le sue frequenti visite a Palazzo Segni, la sua pazienza e un poco anche le sue sgridate; soprattutto il suo affetto che non sempre meritavo fino in fondo.
In questi giorni, nel numero di settembre de “La Revue Sarde” uno scrittore che apprezzo, Claude Schmitt, ha pubblicato le traduzioni in francese di tante poesie di Rafael Sari, Alessandra Cardia, Antonio Cossu, Pietro Mura, Franco Carlini, Benvenuto Lobina, Giovanni Corona, tutti autori che Nicola amava davvero. Tra tutte citerò l’Adieu di Orlando Biddau, il poeta di Modolo che Nicola aveva scoperto e seguito per anni, riuscendo a cogliere al di là della piaga sanguinante della malattia la spiegazione di quell’inadeguatezza a vivere che tormentava il poeta, l’inadéquation au vivre. Nicola sapeva trovare le parole per consolarlo, per dipanare i fili della memoria, per sciogliere i sortilegi dei giorni entrati in fumo di nebbia e d’acque negli occhi. Trovo che questa capacità di “compatire”, di asciugare le lacrime, di lenire le piaghe, sia la cosa più straordinaria che Nicola ci voleva insegnare, guardando ad una Sardegna diversa e più felice.
Tunisi, 2 ottobre 2017
Attilio Mastino
Il ruolo della ricerca scientifica per lo sviluppo della Sardegna e del Paese.
Il ruolo della ricerca scientifica per lo sviluppo della Sardegna e del Paese
Attilio Mastino
 Nell’ambito delle iniziative preparatorie della 48° Settimana sociale dei cattolici italiani che si svolgerà a Cagliari tra il 26 e il 29 ottobre, il 15 settembre ho partecipato con emozione al Convegno promosso a Sassari nell’aula magna dell’Università dal Rettore, dall’Arcivescovo Mons. Padre Paolo Atzei, dal Vescovo di Alghero-Bosa prof. Mauro Maria Morfino e da Mons. Giulio Madeddu sul tema “Il lavoro che vogliamo.
Nell’ambito delle iniziative preparatorie della 48° Settimana sociale dei cattolici italiani che si svolgerà a Cagliari tra il 26 e il 29 ottobre, il 15 settembre ho partecipato con emozione al Convegno promosso a Sassari nell’aula magna dell’Università dal Rettore, dall’Arcivescovo Mons. Padre Paolo Atzei, dal Vescovo di Alghero-Bosa prof. Mauro Maria Morfino e da Mons. Giulio Madeddu sul tema “Il lavoro che vogliamo.
Libero, creativo, partecipativo e solidale”, con specifico riferimento a “Il contributo della ricerca come lavoro e per il lavoro”. L’iniziativa ha avuto un grande successo e l’attenzione si è concentrata sul lavoro della ricerca scientifica dell’Università degli Studi di Sassari e per essa di ogni altro Ateneo italiano, con attenzione per le prospettive professionali dei giovani più qualificati. Il prof. Massimo Carpinelli, Rettore Magnifico dell’Università degli Studi di Sassari, ha presieduto l’incontro ed ha potuto mettere a disposizione un gruppo di Ricercatori, sotto la guida del prof. Francesco Cucca, Professore Ordinario di Genetica Medica e delegato rettorale alla ricerca.
Tra gli altri si sono segnalati gli interventi del Direttore del Dipartimento di scienze biomediche Andrea Montella, di Sergio Uzzau di Porto Conte Ricerche, di Luigi Fiori, di Matteo Floris, di Diego Zucca, di Pier Andrea Serra dell’Università di Sassari. Era presente il Rettore emerito Alessandro Maida e la prof. Eugenia Tognotti, il cui contributo nel campo della Storia della Medicina è stato più volte evocato nel corso dell’incontro.
Nel programma del convegno si riprendeva la Costituzione Pastorale Gaudium et spes per la quale “la Chiesa, presente dalla vita e dalle attività delle Chiese locali, ha sempre avuto il gusto per le scienze e per la rigorosa fedeltà al vero nell’indagine scientifica, per la necessità di collaborare con gli altri nei gruppi tecnici specializzati, il senso della solidarietà internazionale, la coscienza sempre più viva della responsabilità degli esperti nell’aiutare e proteggere gli uomini, la volontà di rendere più felici le condizioni di vita per tutti, specialmente per coloro che soffrono per la privazione della responsabilità personale e per la povertà culturale”, precisando che l’intento degli organizzatori era “solo quello di promuovere la ricerca scientifica e farla interagire con ogni altro mondo del lavoro, cercando di elevarla e inserirla nei circuiti occupazionali, a beneficio della dignità, della libertà e del benessere globale della persona e della comunità”.
Non è la prima volta che l’Università promuove Conferenze di Ateneo sulla ricerca presentando problematiche di tipo scientifico ed etico, risultati e prospettive; ma ora siamo a vent’anni di distanza dalla Magna Charta universitatum, la solenne dichiarazione dei Rettori europei riuniti a Bologna nell’ottobre 1988, che indicava tra i principia ac fundamenta come pilastro dell’Universitas l’insegnamento, con linguaggio ciceroniano la docendi ratio oppure la discipulorum institutio, posta accanto e strettamente congiunta alla scientiae pervestigatio, alla ricerca scientifica: in universitatibus docendi rationem necesse est cum scientiae pervestigationem coniunctam esse ut usus moresque mutantes et procedentes sequatur. Didattica e ricerca sono dunque i principia, gli elementi che giustificano l’esistenza dell’Universitas resa vitale dal fecondo apporto della capacità di investigare dei propri professori: siamo consapevoli che le forme dell’insegnamento sono espressione di una tradizione di studi secolare, ma debbono anche tendere ad un profondo rinnovamento, per inserirsi sempre più in un più vasto circuito europeo e internazionale. In Sardegna la ricerca scientifica è insieme espressione di una tradizione di studi secolare, di reti di rapporti stabiliti nel tempo, in grado di inserirsi sempre di più in una grande comunità europea internazionale, costituendo le fondamenta per quella che è ormai la terza missione dell’Università: il servizio a favore del territorio sul piano assistenziale sanitario, ma anche sul piano ambientale, sul piano economico, sul piano sociale, sul piano industriale, ma anche sul piano del trasferimento tecnologico a favore delle aziende.
È facile allora ritornare indietro nel tempo e ripensare ad alcuni grandi momenti della nostra storia: in occasione della sua visita nell’Università di Sassari il 28 maggio 1985, Giovanni Paolo Magno volle esortare la comunità universitaria ad operare sempre a favore dei grandi valori dell’uomo, affinché, alla luce della scienza e della fede, il suo cammino possa essere illuminato da profonda e vera sapienza. Papa Wojtyla affermò che la ricerca scientifica (nella dichiarazione di Bologna la scientiae pervestigatio) deve essere il primo e fondamentale compito dell’Università, che può ampliare sempre di più gli orizzonti della conoscenza nei vari ambiti del sapere, con un approccio interdisciplinare in rapporto anche ad altri centri culturali. Il ruolo dell’Università, riconosceva Giovanni Paolo II, può essere essenziale per l’edificazione dell’uomo, saggio e addestrato nel retto uso della volontà. Gli studenti debbono concludere il loro percorso formativo dall’Università non solo con l’intelletto ricco di nozioni, ma con la volontà guidata da salde convinzioni morali e da ferme e operanti buone intenzioni. Di conseguenza solo l’impegno didattico dei docenti (la docendi ratio) consente che le acquisizioni scientifiche vengano partecipate alle nuove generazioni, avide di sapere, ma con vivo senso di responsabilità, rispettando la scala di valori morali, spirituali e religiosi, tutti incentrati nell’uomo, che nel mondo costituisce il valore supremo. Tutto il resto, concludeva Giovanni Paolo II, – scienza, tecnica, cultura e società – deve essere al servizio della persona e l’Università non può esimersi da questa finalità altamente pedagogica di rendere l’uomo capace di volere e di amare.
Ci pare che quel messaggio possa essere declinato oggi anche laicamente e possa rappresentare la vocazione alla formazione e alla ricerca propria dell’università pubblica, entrambe libere da condizionamenti, rispettose del pluralismo, attente al futuro dell’umanità, impegnate per la pace.
A distanza di quasi trent’anni da quell’evento, papa Francesco nell’omelia della Messa per l’inizio del suo pontificato, invitava tutti gli uomini di buona volontà ad essere “custodi della creazione, del disegno di Dio iscritto nella natura, dell’altro e dell’ambiente”. Proprio Papa Bergoglio nella sua visita alla Facoltà Teologica della Sardegna e nell’incontro con il mondo accademico isolano a Cagliari il 22 settembre 2013 (preceduto dagli interventi del Preside e dei due Rettori) ci ha raccontato la crisi di oggi come assenza di istruzione e di conoscenza, interpretandola anche come possibile opportunità verso un mondo nuovo: “Penso non solo che ci sia una strada da percorrere, ma che proprio il momento storico che viviamo ci spinga a cercare e trovare vie di speranza, che aprano orizzonti nuovi alla nostra società. E qui è prezioso il ruolo dell’Università, come luogo di elaborazione e trasmissione del sapere, di formazione alla “sapienza” nel senso più profondo del termine, di educazione integrale della persona, per alimentare la speranza”. L’Università come luogo del discernimento, l’Università come luogo in cui si elabora la cultura della prossimità, la cultura della vicinanza, l’Università come luogo di formazione alla solidarietà. “L’Università è luogo privilegiato in cui si promuove, si insegna, si vive questa cultura del dialogo, che non livella indiscriminatamente differenze e pluralismi – uno dei rischi della globalizzazione è questo -, e neppure li estremizza facendoli diventare motivo di scontro, ma apre al confronto costruttivo. Questo significa comprendere e valorizzare le ricchezze dell’altro, considerandolo non con indifferenza o con timore, ma come fattore di crescita. Non c’è futuro per nessun Paese, per nessuna società, per il nostro mondo, se non sapremo essere tutti più solidali. Solidarietà quindi come modo di fare la storia, come ambito vitale in cui i conflitti, le tensioni, anche gli opposti raggiungono un’armonia che genera vita”.
Quelle parole ancora ci emozionano. In conclusione i temi che abbiamo di fronte per definire le caratteristiche della Scienza come professione sono numerosi: l’attuale gravissimo sottofinanziamento della ricerca causato dalle scelte politiche di fondo nel nostro Paese e nel Mezzogiorno, la precarietà dei giovani ricercatori, il ridursi degli sbocchi lavorativi per i laureati (che sono troppo pochi rispetto agli standard europei), i livelli incredibilmente alti della disoccupazione giovanile, l’altissimo numero di giovani che non studiano e non cercano lavoro, il conflitto di interessi tra aziende private e servizio pubblico, la rabbiosa competitività che distrugge la libera creatività, la riflessione pacata, la voglia di creare reti e collaborare insieme. E ancora l’intermittenza dei canali di finanziamento, l’appesantimento burocratico, le incertezze per chi desidera mettere su famiglia ma non può se non a costo di veri e propri atti di eroismo individuale, a causa dei rischi provocati dall’attuale riduzione di risorse, di possibilità occupazionali, di sbocchi professionali.
Resta fortissima l’esigenza di distinguere i fini ed i mezzi, di mettere la ricerca al servizio dello sviluppo, di essere capaci di valutare in profondità le conseguenze etiche, di garantire la fedeltà al vero che deve essere alla base del metodo scientifico, la difesa della ricerca di base, di fronte alla ricerca applicata o sperimentale, ancora il senso e il valore della ricerca umanistica che non ha più necessità di giustificare la propria esistenza e la propria utilità, la cooperazione con i paesi in via di sviluppo, la genetica di alcune popolazioni, la ricerca biomedica.
Nell’incontro di Sassari si è partiti dalle esperienze personali, dalle curiosità, dalle soddisfazioni per i risultati, dal piacere per lo studio, dalle capacità e dai talenti di ciascuno, ma anche dai sacrifici personali e dalle sofferenze legate spesso all’esportazione dei cervelli, alla scarsa attrattività, alle difficoltà dei percorsi di rientro in un’isola che deve trasformare le proprie debolezze storiche legate all’isolamento in una risorsa fondata sulla innovazione e su una più alta competitività. I centri di ricerca, i laboratori, i dipartimenti, le Università e il CNR in Sardegna hanno raggiunto in molti campi livelli di eccellenza. Si possono ricordare, tra le più recenti, le ricerche genetiche sul DNA, la sclerosi multipla, i rischi delle malattie autoimmuni, le neuroscienze, l’energia, l’ambiente, il patrimonio ed i beni culturali. Occorre allora perseguire l’obiettivo di definire ambiti strategici di sviluppo della ricerca che possano essere sostenuti dalle risorse pubbliche e private adeguate, che passino attraverso tirocini formativi e per una selezione morbida dei ricercatori, che siano capaci di consentirci di collocarci in un orizzonte positivo, per poter immaginare un futuro migliore anche senza prevederlo, in una società meno fragile di quella che conosciamo.
Seneca nelle Questioni naturali osservava: Multa venientis aevi populus ignota nobis sciet; multa saeculis tunc futuris, cum memoria nostra exoleverit, reservantur: pusilla res mundus est, nisi in illo quod quaerat omnis mundus habeat. Molte cose che noi ignoriamo saranno conosciute dalla generazione futura; molte cose sono riservate a generazioni ancora più lontane nel tempo, quando di noi anche il ricordo sarà svanito: il mondo sarebbe una ben piccola cosa se l’umanità non vi trovasse materia per fare ricerche.
Il mestiere del ricercatore è forse il più bello del mondo: perché non diventi un inferno è necessario allora affrontarlo con entusiasmo, passione, curiosità; ma occorre innanzi tutto aver chiaro l’orizzonte di impegno, la prospettiva di sviluppo, la voglia di incidere per rendere migliore il mondo che viviamo.
Cartagine, il Mediterraneo centrale e la Sardegna: società, economia e cultura materiale, Giornata di studio in onore di Piero Bartoloni.
Cartagine, il Mediterraneo centrale e la Sardegna:
società, economia e cultura materiale,
Giornata di studio in onore di Piero Bartoloni,
Sant’Antioco, Museo Ferruccio Barreca, sabato 29 luglio 2017
Intervento conclusivo di Attilio Mastino
 Cari amici,
Cari amici,
questa giornata si è aperta con i saluti del nuovo Sindaco del comune di Sant’Antioco, Ignazio Locci, che ha voluto ricordare gli anni in cui ha svolto l’impegnativa funzione di Presidente del Consiglio degli studenti nell’Università di Sassari. Un momento luminoso e felice, che ci ha visto lavorare fianco a fianco in un Ateneo vivo e aperto. Credo che l’Amministrazione comunale avrà una marcia in più con questo Sindaco che ha alle spalle una straordinaria esperienza di relazioni e di rapporti positivi.
Abbiamo poi ascoltato gli interventi dell’Assessore alla cultura Rosalba Cossu e del direttore del Dipartimento di storia, scienze dell’uomo e della formazione dell’Università di Sassari Marco Milanese, impegnato in questi giorni negli scavi di Mesumundu a Siligo, con tante novità che riguardano innanzi tutto la viabilità in età imperiale e tardo-antica.
Stamane, in apertura di questa giornata speciale, con il sindaco ed il direttore Piero Bartoloni (che oggi abbiamo festeggiato), assistiti da Sara Muscuso e da Michele Guirguis, abbiamo firmato il protocollo d’intesa tra il Museo Archeologico “Ferruccio Barreca di Sant’Antioco” e la Scuola archeologica italiana di Cartagine, fondata il 22 febbraio 2016. Porteremo a ratifica il documento nella riunione di Tunisi delle prossime settimane.
La Scuola si propone di favorire con le sue attività forme di coordinamento tra iniziative che caratterizzino la cooperazione italiana in Tunisia (e più in generale nei Paesi del Maghreb) in ambito scientifico-culturale. Essa ha l’obiettivo di configurare un intervento organico, collegiale e articolato, capace di:
• incoraggiare opportunità di ricerca, formazione e diffusione delle conoscenze sul patrimonio relativo alle civiltà preistoriche e protostoriche, preclassiche, classiche, tardo-antiche, islamiche, moderne;
• valorizzare gli apporti di ogni singola iniziativa in questo campo, mantenendo una visione ad ampio spettro e un coordinamento funzionale;
• contribuire attivamente al dialogo interculturale e alle politiche di sviluppo della Tunisia (e più in generale dei Paesi del Maghreb).
La SAIC sottoscrive accordi di cooperazione scientifica con istituzioni locali (tunisine, italiane e di altri Paesi) preposte all’arricchimento, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale, in particolare con l’Institut National du Patrimoine di Tunisi (INP), con l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle di Tunisi (AMVPPC) e le Università tunisine, con analoghi Istituti e Università del Maghreb.
Il Consiglio Scientifico della Scuola è composto oltre che dal Presidente da Piero Bartoloni (Presidente onorario), Sergio Ribichini (Segretario), Michele Guirguis (Tesoriere), Antonio Corda, Pier Giorgio Spanu e Alessandro Teatini. Presto provvederemo all’integrazione del Comitato Scientifico con altri due componenti. Il numero dei soci si sta avvicinando a 200.
Questo protocollo d’intesa che oggi abbiamo firmato prevede una collaborazione quinquennale tra SAIC e Museo di Sant’Antioco nei seguenti ambiti:
– Salvaguardia, tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio archeologico;
– Ricerca scientifica e innovazione relativamente alle Scienze Storiche, Archeologiche e dell’Antichità, alla Storia dell’Arte, alla Conservazione, alla Valorizzazione e al Restauro dei Beni culturali;
– Formazione e divulgazione;
– Dialogo interculturale e collaborazioni transfrontaliere.
In occasione di questa lunga giornata di studio, che si colloca in una lunga serie di iniziative (penso al primo volume degli “Incontri Insulari” del 2007 sull’Epigrafia romana in Sardegna curati da Francesca Cenerini e Paola Ruggeri), sono state svolte oltre venti relazioni affidate ad alcuni nostri maestri provenienti dalla Spagna, dalla Tunisia, dall’Olanda (ora dagli Stati Uniti), dall’Italia, ma anche a nostri colleghi e a tanti giovani e promettenti studiosi. Hanno presieduto i lavori Pier Giorgio Spanu e Lorenzo Nigro. Il nostro Maestro M’hamed Hassine Fantar, impossibilitato ad essere presente, ci ha inviato un lungo affettuoso messaggio, che lascia trasparire un costante impegno per la ricerca, una sensibilità e un’amicizia davvero sorprendenti. Nel volume degli Atti pubblicherà un articolo su Carthage et les cités puniques de Byzacène.
Arrivando stamane da Sassari, raggiunto il ponte romano e osservando i paesaggi antichi, il mare, la laguna, la collocazione della città di Sulky sul versante orientale dell’insula Plumbaria, perfino il clima e il caldo africano, per un attimo ci siamo sentiti proiettati in una dimensione lontana, quella dei naviganti arrivati da Cartagine; poi l’ambientazione del tavolo della Presidenza di quest’incontro e la collocazione dei nostri relatori tra i due monumentali leoni in pietra di Sulci in questo Museo (fortemente voluto da Piero Bartoloni e curato dalla Cooperativa Archeotour) ci introduce ad un mondo che in qualche modo conserva il senso profondo di una storia mediterranea lunga e ricca di relazioni. Grazie a Michele Guirguis e alla curatrice del Museo Sara Muscuso per l’idea, il progetto, la realizzazione di questa intensa giornata che rende onore ad un maestro e a un amico, al quale ci legano rapporti di affetto, di riconoscenza, di amicizia. Grazie agli organizzatori, ai relatori, ai nostri carissimi allievi della Scuola di specializzazione Nesiotikà, alcuni appena rientrati dalla Tunisia, ai nostri meravigliosi studenti. Grazie ad Alberto Moravetti per la sua presenza.
Questa “Maratona Bartoloni”, come l’ha definita Lorenzo Nigro, ci ha restituito un quadro sempre più ricco e complesso, con novità davvero rilevanti; abbiamo imparato tante nuove cose e voglio esprimere l’ammirazione per le attività di ricerca portate avanti simultaneamente da tanti gruppi di ricerca collegati tra loro in rete, in quelle che sono vere e proprie imprese scientifiche alcune a carattere internazionale. Quello che sarà pubblicato nella collana delle “Monografie della Scuola archeologica italiana di Cartagine” sarà un volume splendido, ricco di cose nuove. Da un punto di vista geografico ci siamo mossi da Cartagine (con Rosana Pla Orquín) al museo di Kerkouane in Tunisia (con il nostro carissimo Mounir Fantar); da Ibiza in epoca arcaica nelle Baleari (Juan Ramón Torres); dall’area sacra fenicia di Pyrgi in Etruria scavata nel 2016 (Laura Michetti) al tofet e dalle necropoli di Mozia in Sicilia nel rapporto della piccola isola con il retroterra siculo indigeno (Lorenzo Nigro). Infine in Sardegna, da Olbia e Posada (Giuseppe Pisano, Rubens D’Oriano), con una straordinaria conferma della fase greca di VI secolo, documentata a San Simplicio in contesti chiusi, ora con le patere baccellate e le anfore chiote che conservano le scritture antiche, che si aggiungono ai dati ben noti; e poi la sintesi di Giovanna Pietra sul’urbanistica di Karalis tra fase punica e occupazione romana, con il ruolo di una grande capitale mediterranea aperta ai culti testimoniati da tanti santuari collocati attorno a Piazza Yenne, Via Malta, Via Manno, Via Angioy, Largo Carlo Felice nel II secolo a.C.; senza dimenticare le “piccole cose”, tanto vivaci e espressive capaci di emozionarci, dalla necropoli di Tuvixeddu (Donatella Salvi); e poi la sintesi delle ultime ricerche a Cuccureddus di Villasimius con Michele Guirguis, che inizia a ripercorrere antiche strade tracciate da Piero Bartoloni e Luisa Anna Marras, il santuario fenicio, le cretule in argilla che ci riportano ancora a Cartagine e al tempio di età augustea; Elisa Pompianu ha allargato l’orizzonte fino alla necropoli punica di Villamar; ancora Sara Muscuso, Antonella Unali, Rosana Pla Orquín hanno affrontato in modo unitario il tema di Sulky, con i dati relativi alle nuove indagini territoriali, i pozzi, i ruscelli, gli approdi per le tante merci importate; e i nuovi scavi, come quelli del Cronicario, verso la ricostruzione di una società complessa, con una aristocrazia attiva e dinamica e un mondo colorato e vivace fatto di magistrati, sacerdoti e di sacerdotesse riconosciuti dalla comunità per il loro prestigio e la loro influenza sociale.
Da un punto di vista cronologico abbiamo spaziato dai modelli levantini per le statue degli eroi di Mont’e Prama alla fine dell’età nuragica (con Raimondo Zucca) fino alla basilica del martire africano Speratus a Sulci, documentata nella fase giudicale (Sabina Cisci), sempre seguendo il filo rosso della cultura materiale, delle diverse forme ceramiche, come nella bella relazione di Carlo Tronchetti sulla ceramica attica di IV secolo a.C. A parte l’archeologia, abbiamo trattato di epigrafia, di filologia berbera e semitica e di topografia (Intassar Sfaxi), di Archeozoologia (Gabriele Carenti), di Archeologia pubblica con il progetto di riabilitazione di pazienti psichiatrici a Tuvixeddu (Francesco Arca). E poi la museografia, la necessità di costruire dentro i musei veri e propri centri di ricerca, per riuscire a farne luoghi vivi di confronto e di progettazione del futuro, di difesa delle identità, di formazione, di progettazione europea.
Del resto chi ha progettato questo nostro incontro non poteva farlo meglio.
Vorrei dire che abbiamo messo a confronto anche modelli interpretativi, categorie, grandi contenitori che hanno indirizzato in questi anni la ricerca, con risultati straordinari come quelli presentati da Peter Van Dommelen che ha aperto una nuova finestra sui paesaggi rurali (fin qui assolutamente trascurati) della Sardegna punica.
Allora mi sembra salutare una riflessione su tanti temi sui quali spesso passiamo troppo leggeri: intanto il tema dell’”originalità” dell’arte sarda e dell’identità della Sardegna tardo-nuragica, con la scoperta di influssi culturali differenti, suggestioni, stimoli e modelli dall’oriente nei bronzetti e nella statuaria tardo-nuragica; il tema della “resistenza”, delle “sopravvivenze puniche” e delle “persistenze indigene” che già Marcel Benabou aveva contestato nella presentazione al VII volume de L’Africa Romana (Sassari 1989), perché si tratta di “un sujet qui n’était peut-etre pas sans risques”, con il dovere di andare progressivamente verso “l’élargissement et l’approfondissement”, sul piano geografico, cronologico, tematico e metodologico. Ce lo ha ricordato Alfonso Stiglitz che, con una piccola palinodia, ha parlato di “perdita dell’innocenza” e della necessità di superare la “critica postcoloniale” con categorie diverse, quelle della “subalternità” e, gramscianamente, dell’”egemonia”.
Per chi come me ha studiato da ragazzo Antropologia Culturale per la Scuola di Studi Sardi sul volume di Alberto Mario Cirese su Cultura egemonica e culture subalterne : rassegna di studi sul mondo popolare tradizionale (Palumbo 1976), questi concetti appaiono scontati, anche se forse andrebbero ripensati, in un mondo, quello di oggi, che ormai ha assunto una dimensione globale, dove avvertiamo sempre di più la necessità di manifestare concretamente il più grande rispetto per le tradizioni culturali e religiose, per la profondità delle diverse storie e delle diverse culture, per il patrimonio culturale, con la consapevolezza che esistono variabili geografiche e cronologiche nel momento in cui culture diverse entrano in contatto, sempre evitando di perdere la concretezza e di piegare il dato scientifico a schemi ideologici; lasciando da parte la voglia di creare gerarchie che forse non sono mai esistite se non all’interno delle singole società: come non pensare già all’oraziano Graecia capta ferum victorem cepit, Epistole, II, 1, 156 ? Ne abbiamo parlato qualche anno fa in un dibattito che ci aveva davvero coinvolto all’Università di Herat in Afganistan con Giovanni Cocco, Cristiano Galli, Chiara Rosnati, Manlio Scopigno, Roberto Scotti, Sergio Vacca (I maggio 2014). Rimango persuaso dell’attualità del pensiero di Gramsci oggi e del resto le due categorie “cultura egemone” e “culture subalterne” sono state usate con grande finezza da Peter Van Dommelen, con questa sua concentrazione sul mondo contadino nelle società precapitalistiche che è stata definita anche metodologicamente in tanti suoi noti lavori, ultimi tra i quali citerei almeno nel 2011 Postcolonial archaeologies between discourse and practice, “World Archaeology”, 43.1, pp. 1-6 e nel 2014 Subaltern archaeologies, in N. Ferris, R. Harrison and M. Wilcox (eds.), Rethinking Colonial Pasts through Archaeology, Oxford University Press, pp. 469-475.
Eppure rimango convinto che dovremmo sempre diffidare di alcune categorie astratte oggi molto di moda (“politicamente corrette” per usare l’espressione di G.A. Cecconi) e che sarebbe necessario usare la massima prudenza per interpretare il mondo antico: appare evidente la necessità di evitare semplificazioni che non tengano conto della complessità delle situazioni nel tempo e nello spazio. Per usare le parole di Marco Tangheroni (nel volume postumo Della Storia. In margine ad aforismi di Nicolàs Gomez Davila, edito da Sugarco Edizioni di Milano), occorre <<tener conto della complessità della storia>>; <<una storia che metta l’uomo al centro del dibattito, che superi interpretazioni schematiche e superficiali, dominate dalle forze materialistiche>> (è il concetto anglosassone di human agency, che Peter Van Dommelen ha evocato per noi); del resto non ci si può <<concentrare su una sola causa, mentre la storia è frutto di più cause concomitanti e diverse>>. Perché – questo è il fulminante aforisma di Gomez Davila – <<quello che non è complicato è falso>>, se vogliamo quello che è semplice, semplicemente non è mai esistito. Gli storici rischiano di trasformare la storia in una disputa teologica, dimenticando l’oggetto stesso della ricerca, proponendo generalizzazioni che ci appaiono di <<un’ingenuità che intenerisce, come a proposito dei rapporti tra struttura e sovrastruttura>>.
Marco Tangheroni chiedeva più rispetto per la complessità della storia senza rinunciare a stabilire connessioni, a mettere ordine, a proporre linee di riorganizzazione del passato, per comprendere e spiegare: fondamentale è il concetto che l’inquietudine sul proprio mestiere debba accompagnare sempre gli storici che non vogliono travisare quella realtà che è oggetto dei loro studi. Dunque cosa conosciamo, come conosciamo, quali sono i limiti della nostra conoscenza, quali ne sono le fonti, elementi tutti che danno al mestiere dello storico un carattere artigianale e addirittura artistico e che rendono fondamentale la fase di apprendistato nella quale i maestri debbono seguire i loro allievi. Occorre ancorarsi fortemente ad un periodo storico, ad una realtà geografica, come Tangheroni ha fatto con il volume La città dell’argento del 1985, per restare sul versante sardo. Per capire occorre cercare strade nuove e i tempi appaiono maturi per considerare ora l’archeologia come strumento fondamentale per comprendere l’antico: Marco Tagheronni suggeriva allora un metodo, quello dei suoi minatori medioevali di Iglesias, quando un filone perdeva un po’ d’interesse, apriva un nuovo scavo.
Al di là dei risultati scientifici e degli orizzonti nuovi che si aprono, questa è stata soprattutto una festa in onore di un nostro amico, Piero Bartoloni. A me personalmente mancano le “prolusioni” che abitualmente Piero mi obbligava a subire nei miei corsi di storia romana a Sassari, tra il serio e il faceto, che davano comunque ai nostri studenti di Scienze dei beni culturali un incredibile entusiasmo e il sapore vero di interessi e di passioni coltivate per una vita, come ha scritto Tito Siddu su “L’Unione Sarda” del 26 luglio. Abbiamo ricevuto in questi giorni sul sito facebook Sardinia Antiqua (che per tre settimane ha superato i 100 mila contatti) i messaggi di auguri più affettuosi e più disparati (voglio citare almeno Daniele Castori, Clara Gebbia, Anna Pasqualini, Fiorenzo Toso), compreso quello di una nostra amica romana, che nell’occasione si è ricordata di aver avuto in prestito cinquanta anni fa un libro di Tacito da Piero Bartoloni e ci ha assicurato che sta entrando nell’ordine di idee di restituirlo prima o poi al proprietario.
Al di là degli scherzi, ho sempre ammirato in Piero Bartoloni questo suo straordinario riconoscimento verso i maestri, verso M’hamed Fantar (al quale l’Università di Sassari ha conferito la laurea ad honorem il 22 febbraio 2008 su proposta di Piero Bartoloni), ma anche Ferruccio Barreca (al quale è dedicato il Museo Archeologico di Sant’Antioco) e soprattutto Sabatino Moscati, ricordato sulla targa della strada che conduce al Museo e soprattutto prima nell’Istituto per la Civiltà fenicia e punica del CNR (del quale Bartoloni è stato Direttore dal 1997 al 2002), poi nel Centro di ricerca di Palazzo Segni nell’Università di Sassari e ora nella Biblioteca che inaugureremo il 6 ottobre a Tunisi nella splendida nuova sede dell’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle, di fronte all’Istituto Italiano di Cultura, grazie alla generosità della famiglia e all’impegno personale del suo allievo di sempre.
Ma considero Piero Bartoloni davvero fortunato, se è stato capace di creare una sua “Scuola”, grazie a questa sua generosità, a questa sua capacità di occuparsi con pienezza dei suoi magnifici allievi, anche se alcuni come Michele Guirguis, Antonella Unali ed Elisa Pompianu hanno perfino rischiato la vita sull’elicottero della Guardia di Finanza per aiutarlo a costruire il volume Fenici al volo, che ci ha consentito poi di scoprire il paesaggio antico dell’Isola dalle vene d’argento, visto in rapporto con l’ambiente naturale, i monti, i mari, i fiumi, i monumenti, le aree trasformate dall’uomo, per capire nel profondo le vicende di una terra – Ichnussa, Sandaliotis, Sardinia, Sardò – che conserva una bellezza che spesso ci lascia senza fiato.
Lorenzo Nigro ci ha mostrato una foto nella quale scherzosamente Piero Bartoloni compare come “combattente”: del resto l’abbiamo visto anche stasera difendere con le unghie e con i denti una sua allieva che temeva minacciata. Eppure se c’è una costante nella vita di Piero Bartoloni è stato il suo stile, il distacco dalle polemiche, la capacità di ridimensionare anche con il silenzio ipotesi poco solide o addirittura infondate, soprattutto la consapevolezza che esiste una dimensione alta per la ricerca scientifica ed esiste uno spazio che va lasciato alla libera creatività, alla fantasia, al mistero, un territorio nel quale sarebbe ingiusto ingerirsi ogni giorno sprecando il proprio tempo ad inseguire fantasmi. Ma questo è un modo nobile di ragionare.
Del resto non è secondario nella sua carriera il fatto che abbia ricevuto una formazione militare alla Scuola “Nunziatella” di Napoli così come il fatto che si sia laureato in Filologia Semitica a Roma, relatore Sabatino Moscati, con una tesi sull’insediamento di Monte Sirai (Carbonia-Cagliari), che sarebbe stata presentata già nel 1965 nel XV volume di “Studi Semitici”. Questo indirizzo “filologico” nella formazione che precede o si accompagna alla scelta di “archeologo militante” riemerge in alcuni dei suoi allievi ed oggi è apparso evidente nella bella relazione di Intissar Sfaxi dell’Ireman di Aix-en-Provence, dedicata allo studio dei numerosi omonimi rilevati nelle due distinte aree linguistiche libico-berbera e fenicio-punica. Dirigente di Ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dal 1990, Piero Bartoloni è stato professore di Archeologia del Vicino Oriente e poi fino al 2000 di Archeologia fenicio-punica nell’Università di Urbino. A Sassari ha partecipato ai nostri convegni de “L’Africa Romana” fin dalla terza edizione del 1985; nel 1987 ha presentato una relazione sugli Aspetti protostorici di età tardo punica e romana nel Nord Africa e in Sardegna, per poi tornare all’impianto urbanistico di Monte Sirai in età repubblicana in occasione del decimo Convegno, svoltosi ad Oristano nel dicembre 1992. Dieci anni dopo, il 15 marzo 2001, prendeva servizio presso la nostra Facoltà di Lettere e Filosofia a Sassari, dove è stato poi Coordinatore della Scuola di Dottorato di Ricerca “Storia letterature e culture del Mediterraneo” e Presidente della Scuola di Specializzazione in Archeologia subacquea e dei paesaggi costieri dell’Università di Sassari (sede di Oristano). Nel frattempo effettuava missioni archeologiche, prospezioni terrestri e subacquee e viaggi di studio in Italia, in Africa, in molti altri paesi. Dal 2000, per concessione ministeriale, ha diretto gli scavi archeologici a Monte Sirai e a Sant’Antioco e, con il contributo del Ministero per gli Affari Esteri, ha diretto le indagini a Zama Regia (Siliana), i cui risultati sono stati preziosi per noi per localizzare il campo della battaglia vinta da Scipione su Annibale (scherzavamo a lezione sulla sconfitta cartaginese di fronte alla strategia dell’Africano). Autore di oltre duecentocinquanta pubblicazioni a carattere scientifico, tra le quali oltre venti libri, Piero Bartoloni ha fatto parte di Accademie, Società, Comitati scientifici, ha diretto e dirige riviste e collane di pubblicazioni in Italia e in Spagna. Attualmente è il direttore scientifico delle Riviste “Folia Phoenicia” e “Sardinia, Corsica et Baleares Antiquae”. Dal 22 febbraio 2016 è Presidente Onorario della Scuola Archeologica Italiana a Cartagine e in tale veste si è occupato della nascita della Biblioteca Sabatino Moscati a Tunisi.
Presentando a Sassari nel dicembre 2000 gli Atti del XIV volume de L’Africa Romana dedicato a “Lo spazio marittimo del Mediterraneo occidentale: geografia storica ed economia”, Piero Bartoloni ricordava il celebre Civiltà del mare del suo Maestro e richiamava l’immagine a lui tanto cara del Mediterraneo quale azzurro e mobile trait d’union tra i diversi popoli delle differenti sponde, che suscitano curiosità interessi per gli studiosi che guardano globalmente a tutti coloro che parteciparono alla storia del nostro mare, con al centro la Sardegna.
A nome di tutti i partecipanti a questo incontro, auguro di cuore ancora lunghi anni di attività, con le passioni e l’entusiasmo di sempre.
Magia e inquisizione nella Sardegna del Cinquecento secondo Tomasino Pinna.
Magia e inquisizione nella Sardegna del Cinquecento secondo Tomasino Pinna
Attilio Mastino
Ozieri, 20 luglio 2017, Istituzione San Michele
 Il volume di Tomasino Pinna pubblicato quasi vent’anni fa per la EDES in occasione degli scavi nel castello aragonese di Sassari è intitolato Storia di una strega. L’inquisizione in Sardegna. Il processo di Julia Carta, Sassari 2000, e ci porta nel cuore della Sardegna spagnola, dopo il Concilio di Trento: è la prima pietra di un’opera più vasta sulla storia della stregoneria vista nella prospettiva della storia elle donne oltraggiate e offese. Julia Casu Masia Porcu detta Julia Carta compare negli atti del primo processo recuperato nell’Archivio dell’inquisizione presso l’Archivo storico nazionale di Madrid, documenti poi ripresi per il volume su Siligo da me curato nel 2003.
Il volume di Tomasino Pinna pubblicato quasi vent’anni fa per la EDES in occasione degli scavi nel castello aragonese di Sassari è intitolato Storia di una strega. L’inquisizione in Sardegna. Il processo di Julia Carta, Sassari 2000, e ci porta nel cuore della Sardegna spagnola, dopo il Concilio di Trento: è la prima pietra di un’opera più vasta sulla storia della stregoneria vista nella prospettiva della storia elle donne oltraggiate e offese. Julia Casu Masia Porcu detta Julia Carta compare negli atti del primo processo recuperato nell’Archivio dell’inquisizione presso l’Archivo storico nazionale di Madrid, documenti poi ripresi per il volume su Siligo da me curato nel 2003.
Al momento della sua scomparsa, un anno fa, Tomasino lavorava per pubblicare il secondo processo, intentato con spietato accanimento nei confronti di una donna povera dal punto di vista economico e assolutamente priva di strumenti culturali: la sua famiglia d’origine è costituita dal padre muratore (Salvador Casu), dalla madre (Giorgia de Ruda Porcu Sini), da quattro fratelli di cui tre scapoli (due dei quali vivono presso il canonico di Ales, Pedro Desini, fratello della madre, mentre Francesco, l’unico sposato e con un figlio viveva a Codrongianus) e due sorelle (una sposata a Mores ed una ancora ragazzina ai tempi del processo, di 12 anni di età). Julia afferma durante l’interrogatorio di avere più o meno 35 anni, secondo i conti fatti dalla madre e di impegnarsi nelle attività tipiche femminili che riguardano la gestione quotidiana della casa, la tessitura; aggiunge che frequenta regolarmente la chiesa. Sposatasi, all’età di 25 anni, con un vedovo, il contadino (labrador) Costantino Nuvole, già con un figlio di primo letto, ha avuto con lui in dieci anni di matrimonio, sette figli, tutti morti in tenera età, tranne l’ultimo Juan Antonio, di appena quattro mesi.
La sua estrema povertà prosegue anche dopo il matrimonio, all’epoca del processo non possiede altro che i logori abiti che indossa quando viene arrestata e durante la carcerazione nel castello di Sassari è costretta a dormire a terra, in mancanza di un letto che del resto non possiede neppure nella propria abitazione di Siligo. Dagli atti del processo traspare però molta tenerezza per l’unico figlio, l’ultimo di pochi mesi, rimastole in vita: chiede che lo conducano a Sassari, condivide con il piccolo la carcerazione, si espone ripetutamente fino a chiedere di essere ascoltata dall’inquisitore e giunge addirittura a fare ammissioni in totale disarmonia con il poco o nulla ammesso in precedenza, forse proprio per quel bambino che sta allattando in carcere e che rischia di fare la brutta fine degli altri sei. «Julia richiesta e ottenuta udienza, chiede all’inquisitore di chiudere la sua causa e lamenta le sue sofferenze: soffre molto ed è povera, non possiede letto e dorme per terra, per giunta allattando la sua creatura».
Una donna sarda, intelligente e complessa, pur in mancanza di una pur minima formazione culturale; Tomasino Pinna, lo sottolinea laddove scrive a proposito del cambiamento nell’atteggiamento processuale di Julia dapprima di fermo diniego rispetto alle accuse e in un secondo momento di ammissione totale: «Abbiamo modo di osservare l’aprirsi, repentino e inaspettato (data la sostanziale tenuta, fino ad allora, degli argini psicologici e della lucidità della rea), di un varco, di uno squarcio lacerante nella strategia difensiva di Julia, che, abbandonata ogni prudenza, decide di “confessare” tutto (o anche più di tutto, más de lo que es, per usare le sue stesse parole), lasciandosi andare ad un rigoglioso fiorire di ammissioni, che danno come l’impressione di assistere ad uno sdoppiamento di Julia. Sembra di avere a che fare con una persona del tutto diversa da quella che conoscevamo: sempre pronta a ribattere con lucidità alle accuse, attenta a non cadere in errore ma flessibile quando ciò accada, e d’una flessibilità finalizzata ad un rinvigorimento della difesa; debole quando serve ma entro limiti precisi e pronta a controbattere, seppur coi suoi poveri mezzi, ai tentativi di farla cadere in contraddizione; capace anche di star dietro alle razionalizzazioni dell’inquisitore…».
Ci chiediamo la ragione per la quale Julia arrivi ad essere processata. Le accuse mosse contro di lei nascono da vaghe voci di paese; una vicina di casa di Julia, Barbara de Sogos, riferisce al parroco di Siligo, Baltassar Serra, di averla sentita esprimere affermazioni eretiche circa il sacramento della confessione: essa andava resa non obbligatoriamente al sacerdote ma entro un buco scavato davanti all’altare, poi ricoperto di terra o sotto il lenzuolo superiore del letto. Spiegava Tomasino Pinna: «Nel loro complesso, tali pratiche, molto diffuse, costituivano, nel quadro delle precarietà economiche ed esistenziali allora vigenti, un sistema di tutela, dal momento che contribuivano ad instaurare un regime psicologicamente protetto di esistenza. Dove non era possibile tutelarsi realisticamente, si ricorreva al rituale, all’ordine simbolico come mezzo di superamento delle crisi indotte da un negativo variamente configurato nei suoi aspetti naturali (malattie) o sociali (nemici, oppressioni del potere). Tutte queste prassi magiche erano frutto di tradizioni molto radicate, rispondevano a bisogni insiti in quell’ambiente e costituivano una piattaforma sulla quale organizzare e svolgere secondo ordine e misura il proprio vivere quotidiano».
Del resto la vox populi era che Julia fosse una fattucchiera, hechizera, esperta nella confezione di amuleti (nóminas, in sardo “punga”) per proteggere dall’invidia e dalla malevolenza delle persone nemiche. Questa sua attività in realtà si spiega con la configurazione sociale di un villaggio di forse 500 anime, Siligo, in cui la protagonista desiderava rendersi utile alla comunità che l’aveva accolta. Il parroco di Siligo in qualità di commissario del Santo Officio presso la propria parrocchia, agiva, secondo prassi, per conto degli inquisitori e poteva indagare, interrogare ed arrestare, senza tuttavia emettere sentenze che spettavano al livello inquisitoriale superiore.
Il primo processo, compresa la fase preliminare dell’interrogatorio dura oltre un anno dal settembre 1596 sino alla fine di ottobre del 1597. Per 10 giorni dal 25 settembre al 5 ottobre si svolgono, ad opera del parroco di Siligo, gli interrogatori delle sei donne, tra cui la vicina Barbara de Sogos, che accusano Julia di fattucchieria (hechizería) soprattutto in merito ad alcuni preparati consigliati per la guarigione di familiari malati; per i suffumigi; per le nóminas e per la pratica di lanciare maledizioni. Il 14 ottobre viene emesso il mandato di cattura per Julia, nascosta a Mores in casa del padre; il 18 ottobre, arrestata, viene condotta nelle carceri del Santo Officio al Castello di Sassari dall’alcalde (Matheo Maza) con indosso solo i suoi abiti poiché non possiede alcun bene di quelli che vengono indicati in maniera stereotipata dai formulari processuali dell’Inquisizione come denaro, vestiti, biancheria e il letto: tutto il necessario per il suo sostentamento dovrà essere fornito dal tribunale; il 19 ottobre si svolge la prima udienza che si conclude con un primo ammonimento, seguita il 23 ed il 26 ottobre dal secondo e dal terzo ammonimento (con le moniciones si invitava l’accusato-detenuto a liberarsi la coscienza dicendo la verità in modo da concludere la causa nel più breve tempo possibile senza passare alle fasi successive). Il 19 ottobre le viene portato in carcere il piccolissimo Juan Antonio perché stia con la mamma che mostra una salute precaria (le sembra che le scoppi il petto). Julia viene così trasferita dalla cella nella casa dell’alcalde sempre all’interno del Castello. Dopo le tre ammonizioni Giulia non confessa e il processo segue il suo corso. Il 26 ottobre, dopo la terza ammonizione il fiscale (Pedro Folargio) formula le sue accuse contro l’imputata: per aver fatto amuleti (nóminas, pungas) ed aver provocato con malefici la morte di una persona, deve essere considerata una strega (sortílega supersticiosa, supersticiosa magarcha, maléfica hechizera) ed eretica luterana per le sue affermazioni circa la confessione. Il fiscale chiede per la donna la scomunica e le più gravi pene sino alla morte. A questo punto la donna, che fino a quel momento aveva negato tutto, attribuendo le accuse a inimicizia nei suoi confronti ed al diniego di fornire medicamenti di erbe che le erano stati richiesti e che lei sapeva confezionare, inizia a fare qualche ammissione ma di poco conto. Dopo il 26 ottobre viene nominato l’avvocato difensore di Julia il dottor Antonio Angel Sanatello; il ruolo degli avvocati del Santo Officio era assai ambiguo e inefficace nella difesa: essi erano funzionari che dipendevano dagli inquisitori e che lavoravano al loro servizio, si limitavano a pressare l’accusato perché confessasse subito in modo da ricevere un alleggerimento della propria posizione, non esisteva un contro interrogatorio della difesa, le accuse si contrastavano citando i testimoni a discarico o dimostrando l’atteggiamento malevolo degli accusatori ma tutto questo per la Carta non avverrà.
Intanto il parroco di Siligo prosegue le indagini con l’interrogatorio di altri nove testimoni. Il 21 novembre il fiscale (Thomás Pittigado) accusa Julia di patto con il demonio e chiede che in caso di mancata confessione da parte dell’accusata si ricorra alla tortura; la Carta nega le accuse.
Il mese successivo tra il 9 e poi il 10 dicembre Julia, dietro sua richiesta, viene ricevuta dall’inquisitore (de la Peña), al quale chiede di esser rimandata a casa perché soffre molto e sta allattando il bambino; le viene risposto di dire allora la “verità” ma la povera donna non ha niente da aggiungere, per cercare di spiegare il proprio operato dice che esso non risulta da alcuna predizione ispirata dal demonio ma solo dall’osservazione di fatti oggettivi come il rendersi conto del peggioramento delle condizioni di salute di un proprio compaesano (Sebastiano Corda) che lo avrebbero condotto ineluttabilmente alla morte nella stessa notte alla quale risaliva la visita della donna a casa del malato.
L’11 dicembre viene “pubblicata” la lista dei nuovi 12 testimoni a carico, in realtà si tratta di una procedura che niente ha a che fare con la pubblicizzazione, poiché tutto ciò che concerne i testimoni e le testimonianze viene tenuto segreto; una delle poche novità riguarda l’accusa di eresia relativa alla confessione: per l’imputata quel modo di confessarsi senza l’intervento del sacerdote sarebbe stata una cosa scherzosa raccontata dalla nonna, Juanna Porcu, quando era bambina
Nel mese di aprile dell’anno successivo, Julia, ricevuto il permesso dall’inquisitore (de la Peña), trascorre la Settimana Santa e la Pasqua a Siligo, subito dopo alla metà del mese, la consulta del tribunale del Santo Officio (di cui fa parte anche l’arcivescovo di Sassari, Alonço de Lorca) decide all’unanimità di condannare Julia alla tortura e in particolare alla carrucola (garrucha: la vittima veniva appesa per i polsi ad una carrucola fissata al soffitto e lasciata cadere di colpo con strappi di fune, il cui numero veniva deciso di volta in volta dal torturatore e provocava lo slogamento di braccia e gambe). Julia, già con i panni de la vergüenza (los vestidos del tormento), ossia nuda con un panno sulle parti intime, spaventata se non terrorizzata decide a quel punto di confessare “più di quel che sa” e il procedimento di tortura viene interrotto; per quanto riguarda la confessione, Giulia “confessa” di aver appreso quella modalità di autoconfessione dalla nonna e non si trattava di uno scherzo e di averla consigliata ad un’altra donna.
Il mese successivo con il subentrare nel tribunale sardo di due nuovi inquisitori (Pedro de Gamarra e Pedro de Axpe), il processo a Julia riceve nuovo impulso sia per il riesame delle precedenti indagini da parte degli attuali giudici sia soprattutto per la svolta intrapresa da Julia che dichiara di aver avuto numerose visioni da parte del Señor Domán, il diavolo, il quale le si era rivelato come istigatore, maestro e tentatore: dunque da lui derivavano le indicazioni per la preparazione degli amuleti, le terapie a base di erbe, i suffumigi; il diavolo avrebbe indicato a Julia quella particolare autoconfessione, le avrebbe chiesto l’anima e ordinato l’abiura di Dio e della fede in cambio di potere e ricchezza ed infine avrebbe tentato più volte di abusare di lei sessualmente. Dopo questa confessione Julia implora il perdono chiedendo di essere reintegrata nel grembo della chiesa e si dichiara pentita tanto da volersi sottoporre alle pene che le verranno inflitte
Il 26 ottobre del 1597 avviene per Julia la pubblica riconciliazione nella Chiesa di Santa Caterina nell’attuale piazza Azuni, poco distante dal Castello dell’Inquisizione: la cerimonia prevedeva l’abiura della donna vestita con l’abito penitenziale, il sambenito, di lino (o panno) giallo con sul petto e sulle spalle disegnata la croce di Sant’Andrea. Fatta inginocchiare, Julia avrebbe dovuto leggere l’abiura ad alta voce, in presenza del testo dei Vangeli, ma poiché era analfabeta il notaio leggeva frase per frase e la donna, in sardo, ripeteva. Per i tre anni della pena inflittale, la Carta doveva risiedere a Siligo, recitare il sabato il rosario in un luogo di culto e presentarsi la domenica e tutti gli altri giorni di festa con il sambenito, davanti al celebrante: ciò costituiva una pubblica umiliazione coram populo e in ciò del resto acquistava senso la pena che doveva servire da esempio e da deterrente. In realtà la pena standard infliggeva anche pesanti pene pecuniarie al condannato e il divieto di indossare abiti preziosi e gioielli, per quanto, nel caso di Julia, tutto ciò non fosse possibile a causa dello stato di estrema indigenza della donna.
Le pratiche di medicina popolare riferite da Julia nelle prime ammissioni erano le terapie a base di erbe in cui era esperta, suffumigi che avrebbe praticato ad alcune persone di Siligo a base di cera (non era certa fosse o meno benedetta), incenso, palma e acqua benedetta, buttati sulle braci accese pronunciando solo “Jesús María”
Le pratiche riferite da alcuni dei nove testimoni interrogati dal parroco di Siligo anche dopo l’arresto di Julia erano più imbarazzanti. La Famiglia Virde raccontava di una cura con suffumigi, affumentos per guarire da un maleficio che impediva al paziente di lavorare, fatti con una serie di ingredienti deposti all’interno di un recipiente di terracotta e portati ad ebollizione: tre pezzi di tegola di chiesa, tre pezzi di pietra pomice, polvere, palma benedetta, rosmarino, ruta e cùscuta uniti ad acqua benedetta, vino e orina; monete da disporre su striscie di lino poggiate a forma di croce dentro una tegola colma di braci da cui si levavano tante fiamme quante erano le monete, la fiamma nera indicava la malattia di Elias: un giunco sul quale si facevano tanti nodi quante erano le articolazioni di Elias, posto poi tra i seni di Julia, ciò produceva e indicava la guarigione del malato
Famiglia Virde sosteneva di aver fatto ricorso all’opera della strega per conoscere la sorte del figlio in carcere: Julia avrebbe fatto “scendere la luna”, sortilegio tipico della stregoneria utilizzato per le predizioni, che sarebbe consistito nello spostare dalla sua orbita fissa la luna e farla scendere sulla terra, turbando il corso originale, predestinato dalla natura; altro metodo di predizione per l’ammalata Angela Solinas Virde: mettere braci dentro una tegola e gettare sopra un liquido in grado istantaneamente di spegnerle così come nella nottata si sarebbe realmente spenta la vita dell’ammalata.
La bambina piccola dei Virde che non stava bene venne mandata, accompagnata dalla sorellastra, da Julia perché la abervasse, le recitasse le parole; la Carta dopo averla portata per strada le avrebbe fatto vedere una figura nera con il petto nudo e i pantaloni rossi che scendeva dall’aria e che successivamente si sarebbe librata in volo per scomparire, apparentemente il diavolo.
Un composto di Ossa di morto polverizzate racchiuse in un fazzoletto era stato consegnato a Pedro Virde perché lo spargesse sulla soglia di casa del governatore di Sassari in modo che questi non potesse nuocere al figliastro incarcerato. Una pietra fu data da Julia a Pietro Virde incarcerato perché la tenesse in tasca per essere riconosciuto innocente e venire scarcerato.
Sullo sfondo rimane il tema della trasmissione dei saperi popolari, delle conoscenze tradizionali e di una vera e propria sapienza profonda che rimandano ad un passato lontano, addirittura pagano: Julia afferma nel processo di aver imparato a fare le pungas da un’altra donna Tomayna Sanna, la stessa che le avrebbe anche insegnato a fare un unguento a base di erbe, vino e strutto per curare il dolor de costado. Julia afferma di aver appreso le tecniche di predizione relative all’esito di vita o morte per l’ammalato da una zingara, gitana. Infine, nell’ultima fase, afferma di aver appreso quanto sa dal “diavolo”.
La lingua utilizzata è prevalentemente Sardo e non il castigliano L’accusa viene letta in sardo per l’accusata come pure le deposizioni rese dai testimoni che non conoscevano il castigliano, al momento della ratifica.
Secondo Tomasino Pinna gli atti del primo processo a Julia Carta trovano una caratteristica di eccezionalità anzitutto nel fatto che si tratta di un resoconto lungo e completo del procedimento, probabilmente un unicum nel periodo a cavallo tra XVI e XVII secolo in Sardegna, da inserirsi all’interno dei processi per stregoneria che hanno come protagoniste, donne di estrazione sociale umilissima, analfabete, ossia quelle che secondo l’autore qualificano: «il tipo classico della strega, che meglio rappresenta le vittime predilette di quel fenomeno che si qualifica comunemente come “caccia alle streghe” (…). Per queste caratteristiche, tali atti rappresentano un punto di riferimento di assoluto valore per chi intenda studiare la persecuzione della stregoneria nel tribunale sardo dell’Inquisizione».
La storia processuale di Julia Carta, in realtà prosegue ulteriormente per un decennio: dopo una pausa di 7 anni, si svolge il secondo processo: i documenti sono datati 1604-1606 (riportati da Tomasino Pinna trascritti e tradotti, come quelli del I processo, nella seconda parte del volume).
Nel dicembre 1604 Julia viene sentita insieme ad altri prigionieri in merito alla fuga di due presos (prigionieri: fra’ Nicolás Sanna e Antonio Deledda) dalle carceri del Santo Officio di Sassari; nell’udienza del 5 dicembre ella dice di trovarsi imprigionata da sei mesi, dunque da giugno. Quindi Julia in questo anno si trova nelle carceri del Santo Officio presso il Castello di Sassari. Il motivo dell’imprigionamento viene esplicitato in due documenti: una relazione di cause che afferma che la donna è stata imprigionata in quanto sortílega hechizera, dunque a causa di una nuova accusa di stregoneria, a seguito della quale Julia nuovamente “confessa” di aver adorato il demonio e di aver abbandonato la fede in Dio; un memoriale inviato dal fiscale (Bañolas) al Consiglio della Suprema (sede a Madrid, presieduto dall’Inquisitore generale, in stretto contatto con il re, provvedeva ad eleggere gli inquisitori nei territori sotto il dominio della Spagna) contro l’inquisitore (Oçio) accusato di aver tralasciato di rinchiudere le donne, come Julia, accusate di stregoneria, nelle carceri segrete e di averle lasciate nella casa dell’alcalde che altresì sfruttava il loro lavoro: in tale memoriale Julia è definita recidiva, relapsa que se a de relaxar, che deve essere affidata al tribunale secolare perché sia condannata al rogo. Per fortuna ciò non avvenne come si ricava da un documento non datato ma riferibile al 1606 che riferisce di contrasti, circa una possibile condanna a morte di Julia, tra i giudici del tribunale di Sassari, tanto che l’inquisitore (de Argüello) chiede un giudizio definitivo alla Suprema di Madrid sul caso della Carta. Per l’inquisitore sarebbe stato bene «imporre una pena esemplare, tanto più utile quanto più la Sardegna gli appare come terra particolarmente dedita a pratiche di tipo magico-stregonesco». Dunque nel 1606, a due anni dall’arresto Julia si trovava ancora nelle carceri segrete del Castello perché la sua causa non era ultimata. Dopo otto anni nel febbraio del 1614, il nome di Julia ricompare in un documento riguardante la visita fatta dal visitador (Rincón de Ribadeneyra) all’Inquisizione di Sassari che chiede conto delle incurie degli inquisitori relative ai sambenitos dei relaxados e dei riconciliati. Il sambenito costituiva parte essenziale della pena: esso dopo essere stato indossato dai condannati a seguito delle Istruzioni (1561) della Suprema e dello stesso Filippo II (1595) doveva essere appeso nella parrocchia del luogo di residenza dell’ex condannato, una sorta di “Lettera scarlatta”, che marchiava il “reo” e tutta la sua famiglia e discendenza, tanto che molti ad esempio nella Toledo del Cinquecento cambiarono cognome per sfuggire alla pubblica infamia. Scrive Tomasino Pinna: «Se l’intervento correttivo del visitador Rincón de Ribadeneyra fu davvero efficace, non c’è dubbio che il sambenito di Julia – con sopra impressi il suo nome, il suo lignaggio, il suo reato e la sua condanna – campeggiò per un tempo indefinito nelle pareti della chiesa di Siligo, ad perpetuam rei memoriam. Così ha fine la vicenda di Julia. Una vita vissuta per buona parte a dar ragione – e a scontarne le conseguenze- delle sue parole, delle sue idee, dei suoi comportamenti e delle sue competenze al tribunale del Santo Officio. Un caso esemplare, nella sua semplicità, di rapporto fra culture eterogenee: diverse per matrice, qualità e potere».
Questo è il giudizio di Tomasino Pinna su una vicenda controversa che finì per riaprirsi qualche anno fa quando la Prefettura di Sassari aveva impedito al Comune di Siligo di intestare una strada a Julia Carta, la strega. In fondo cosa c’era da intitolarle, così disse la prefettura, era pur sempre una strega, un pessimo esempio e non certo una martire, piuttosto una appartenente a un “giro oscuro”. Un suo allievo ha scritto su “Il Manifesto”, che «consultato in quel frangente, il prof. Pinna si limitò a ribadire il contenuto delle ricerche da lui effettuate sotto il profilo della ricostruzione storico-scientifica, un lavoro di anni basato su documenti raccolti a Madrid. Insomma, la via poteva esserle intitolata di certo, ma non era questo il punto della vicenda. Era invece, come è anche adesso, raccontare la storia di chi non ha avuto voce per poi constatare amaramente che, una volta compiuta l’impresa, c’è sempre qualche cortocircuito che riporta al punto di partenza».
Ora che Tomasino ci ha lasciato, il 25 giugno di un anno fa, in silenzio, dopo mesi di sofferenze iniziate con l’incidente in Ogliastra, a 66 anni di età, lo vogliamo ricordare con il suo sorriso, la sua severità, la sua alta figura morale. Siamo vicini al dolore della sua famiglia, ma anche di tanti amici di una vita che, come me, lo conoscevano da quasi cinquanta anni, partendo dai luminosi anni della Facoltà di Lettere di Cagliari, dove era cresciuto alla scuola di Alberto Mario Cirese e della sua Clara Gallini.
Abbiamo consultato in questi giorni lo stato matricolare di Servizio conservato nell’Università di Sassari, dove era arrivato da Cagliari il 20 aprile 1988 come ricercatore confermato, assegnato all’Istituto di Antichità, Arte e discipline etnodemologiche della Facoltà di Magistero. Dal 1992 era passato all’Istituto di studi etnoantropologici della Facoltà di Lettere e poi dal I gennaio 1999 ci aveva seguito al nostro Dipartimento di Storia. Nel 2004 aveva superato il difficile concorso di professore associato di storia delle religioni e il 23 dicembre 2006 diventava professore associato a tempo pieno. In questi giorni lo abbiamo ricordato con il suo collega del CNR Sergio Ribichini, che conserva uno splendido ricordo delle sue opere. Una malattia lo aveva obbligato a mettersi in congedo straordinario per motivi di salute per tutto il 2010. Con decorrenza I gennaio 2012 aderiva con tutti noi al nuovo Dipartimento di storia, scienze dell’uomo e della formazione, ancora come professore associato di storia delle religioni in Sardegna e di Storia delle religioni.
Al momento della scomparsa, ha lasciato tra i colleghi, gli studenti, i laureandi il ricordo di un uomo buono e generoso, coerente con se stesso, severo anche con gli amici, rigoroso nel suo lavoro di ricercatore pieno di curiosità, di passioni, di interessi, che partivano dal mondo antico con il Satyricon di Petronio (l’arbiter elegantiarum) per arrivare a Gregorio Magno e poi all’inquisizione spagnola e giungevano addirittura ai nostri giorni. Sempre con l’impegno di ritrovare in tutte le società complesse i sistemi mitico-rituali inquadrabili entro la categoria della “magia”, delle “superstizioni” e del “sacro” nelle tradizioni popolari della Sardegna.
Con quel suo linguaggio criptico scriveva per me: «La diversità dei referenti sacri non nasconde le somiglianze dei bisogni e dei meccanismi ierogenetici sottesi alla regolazione rituale di rapporti conflittuali».
Eravamo molti diversi come formazione, lui così laico e razionale (una delle sue ultime lezioni all’Università della terza età il giorno di martedì grasso del 2014 era stata sul tema “Cos’è la religione! Qualche teoria e qualche risposta”). Eppure proprio questa nostra diversità aveva consentito di scrivere insieme l’articolo sul governatore della Sardegna Massimino, amico nel IV secolo d.C. di un mago sardo capace di evocare le anime dannate e trarre presagi dagli spiriti: avevamo studiato ancora le terribili bithiae, dalla doppia pupilla, i violatori delle tombe, i sistemi di divinazione oracolare riconosciuti ai massimi livelli ufficiali nell’ecumene romana (che dimostrano come la Sardegna comunicasse con la cultura diffusa nell’impero), gli altri metodi divinatori, come il rito ordalico-giudiziario legato alle acque prodigiose, che presenta, come spesso avviene in ambito rituale, una valenza polisemica, in quanto svolge una doppia funzione: divinatoria e terapeutica insieme. Le sorgenti calde e salutari (le Aquae Lesitanae di Benetutti-Bultei, le Aquae Ypsitanae di Forum Traiani, con il santuario delle Ninfe e di Esculapio, le Aquae calidae Neapolitanorum, le acque di Oddini-Orani, quelle bollenti di Casteldoria) servivano per guarire le fratture delle ossa, per neutralizzare l’effetto del veleno del ragno detto “solifuga” e per guarire le malattie degli occhi; ma servivano anche come mezzo per scoprire i ladri, i fures: costretti al giuramento sull’accusa di furto, se essi giuravano in modo falso dichiarandosi innocenti, al contatto con quelle acque diventavano ciechi, mentre la vista diventava più acuta se avevano giurato il vero. Insomma, era tornato alle tematiche che più l’avevano appassionato da ragazzo, sotto l’influenza della Gallini, sulle religioni del mondo classico.
Dopo la pace religiosa e l’affermazione del cristianesimo, “i riti magici e divinatori persisteranno in Sardegna, in un contesto sincretistico, nei secoli successivi, e così i malefici, le evocazioni dei morti e le formule cristianizzate di maledizioni, con una impressionante stratificazione culturale. Ci troviamo di fronte a quella che è stata definita una “mobilitazione magica del pantheon cattolico”, in cui l’orizzonte religioso cristiano viene recepito e reinterpretato in base alle esigenze dei gruppi che vi ricorrono (i banditi, i ladri, i maléfici), che filtrano sulla base dei loro interessi la percezione e l’utilizzazione dei santi e dei simboli cristiani, piegati alle esigenze connesse ai loro specifici problemi e ai loro vissuti esistenziali”. Alcuni santi gli sembravano “invocati e ritualmente coinvolti (in un rapporto definito nei termini della costrizione magica) ad agire come potenza di morte contro i nemici: lontani eredi del Marsuas dell’óstrakon di Neapolis, delle divinità infere delle tabellae defixionum e delle anime noxiae dell’amico sardo di Massimino”.
E il nostro contrasto dialettico sul tema “Culture egemoni e culture subalterne” del vecchio lavoro di Cirese, come a proposito del suo articolo sui linguaggi simbolici subalterni o sul diavolo nell’orizzonte magico subalterno. In un mondo attraversato dal terrorismo islamista (che osservavo da Herat in Afganistan), capivamo entrambi che queste categorie risultavano ormai da superare, la realtà finiva per essere più complessa delle formule tropo esemplificative. E poi San Nilo di Rossano (Edizioni Parallelo, 2011), la sorprendente amicizia con Ileana Chirassi Colombo, che considerava la più grande storica delle religioni italiana; i nostri amici comuni. Con Raimondo Turtas si scambiavano recensioni più o meno affettuose, come a proposito di Gregorio Magno o sulla storia della chiesa in Sardegna (2008), lui sempre attento alle reinterpretazioni popolari e alla repressione inquistoriale, come a proposito del culto dei morti e dei santi. Tra le mie carte ho ritrovato i suoi estratti su Il diavolo di Sorigueddo con documenti scovati presso nel 1998 l’Archivo Histórico Nacional di Madrid e Un auto de fe in Sardegna del 2000.
Tre anni fa mi aveva regalato il libro che più amava, scritto da Ernesto De Martino, dedicato alla crisi causata dalla morte, che esplodeva nel pianto rituale nel mondo antico e che riproponeva il tema della riduzione antropologica del sacro (nell’edizione del 2008): ne avevamo discusso a lungo, riflettendo sul tema della presenza e dell’assenza, che finisce per essere una delle categorie sulle quali costruire un’idea diversa di Sardegna, partendo dagli “eroi” del rito incubatorio della Fisica di Aristotele e dai Giganti di Mont’e Prama, per i quali secondo Tomasino doveva presupporsi un apparato ideologico-celebrativo, che si concentrava a partire dal prestigio sociale riconosciuto dalla comunità dell’estrema età nuragica ai giovani rappresentati sulle statue, cme esponenti di un’aristocrazia vincente.
Tra i suoi lavori più recenti: Il viaggio del signor inquisitore (Bollettino di Studi Sardi), 2014; la monografia Il sacro, il diavolo e la magia popolare. Religiosità, riti e superstizioni nella storia millenaria della Sardegna pubblicata nel 2012 da EDES; nel 2007 aveva pubblicato lo straordinario capitolo Magic in The Blackwell Encyclopedia of Sociology. Aveva concluso il secondo volume sul processo ad Julia Carta, che speriamo possa essere presto pubblicato.
Oggi vorremmo asciugare le lacrime di Luciana ed di Adriano, immaginando laicamente Tomasino arrivato in un modo felice e tutto suo, con le parole che Omero nel IV libro dell’Odissea riferisce a Menelao di Giove alunno, il principe originario di Argo città nutrice di bei cavalli: Nei campi elisi, al confine del mondo, presso le isole dei beati, ti hanno mandato gli dei, là dove regna il biondo Radamanto, il saggio figlio di Zeus, e dove per i mortali è più bella la vita, che scorre senza cura o pensiero: neve non c’è, né freddo acuto, né pioggia mai, spira sempre il soffio sonoro di Zefiro, il vento Favonio che Oceano manda per il sollievo degli uomini più fortunati.
La visita di Theodor Mommsen a Cagliari in una rara vignetta del 1877.
La visita di Theodor Mommsen a Cagliari in una rara vignetta del 1877: la difesa delle Carte di Arborea e della giudicessa Eleonora d’Arborea (cortesia Raimondo Zucca)
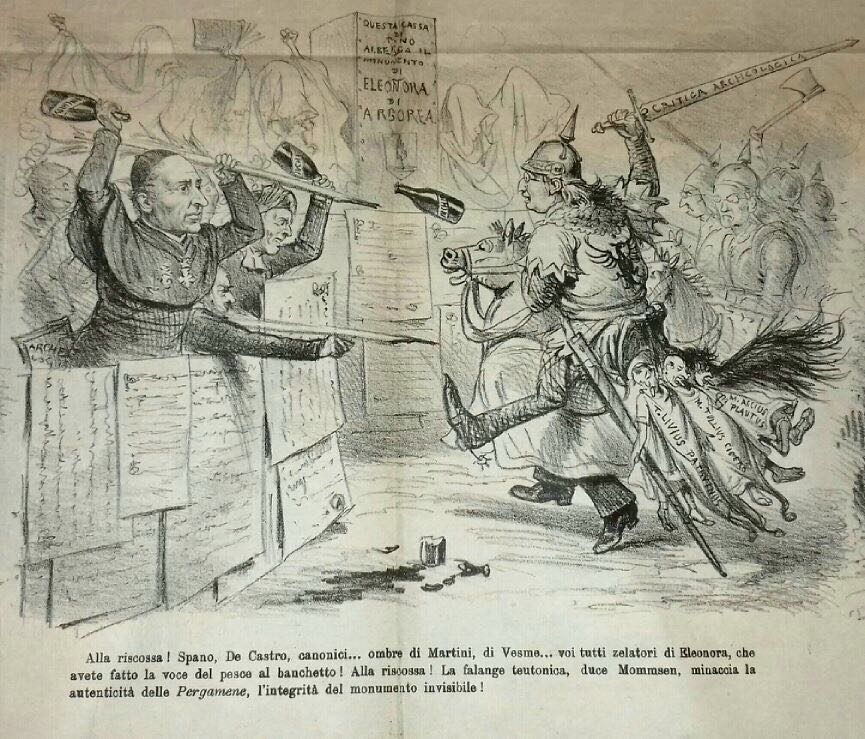 Theodor Mommsen rimase a Cagliari quattordici giorni, fino al 27 ottobre 1877, per visitare l’Università, la collezione di antichità nel vicino Museo, l’archivio arcivescovile, la Grotta della Vipera. Alloggiato presso l’Hotel Scala di Ferro in Via Regina Elena (sotto Piazza Martiri), fu accolto inizialmente con simpatia: su L’avvenire di Sardegna, il giornale politico internazionale organo della colonia italiana nella Tunisia che si stampava a Cagliari, il 15 ottobre in cronaca si annunciava l’arrivo due giorni prima dell’illustre studioso, si forniva una serie di particolari biografici, dalla nascita in Danimarca, ai suoi studi, ai suoi viaggi, ricordando in particolare il viaggio in Italia nel quale si era occupato «indefessamente delle iscrizioni romane» .
Theodor Mommsen rimase a Cagliari quattordici giorni, fino al 27 ottobre 1877, per visitare l’Università, la collezione di antichità nel vicino Museo, l’archivio arcivescovile, la Grotta della Vipera. Alloggiato presso l’Hotel Scala di Ferro in Via Regina Elena (sotto Piazza Martiri), fu accolto inizialmente con simpatia: su L’avvenire di Sardegna, il giornale politico internazionale organo della colonia italiana nella Tunisia che si stampava a Cagliari, il 15 ottobre in cronaca si annunciava l’arrivo due giorni prima dell’illustre studioso, si forniva una serie di particolari biografici, dalla nascita in Danimarca, ai suoi studi, ai suoi viaggi, ricordando in particolare il viaggio in Italia nel quale si era occupato «indefessamente delle iscrizioni romane» .
E poi la cattedra di diritto a Lipsia, «carica che poco dopo lasciò per essersi mischiato nei ben noti sconvolgimenti politici»; poi Zurigo, Breslavia e Berlino . Dopo una sintesi delle sue principali pubblicazioni, il cronista passava ad un breve ritratto: «Il Mommsen ha i capelli bianchi; è alto, snello; veste abito bleu ed ha occhiali d’oro; parla correttamente l’italiano». E infine: «Stamane egli ha cominciato la visita della città in ordine allo scopo del suo viaggio, recandosi al museo archelogico per esaminarne le iscrizioni».
Sullo stesso giornale, il 17 ottobre si annunciava che il prefetto Minghelli Valni aveva organizzato per il pomeriggio un pranzo ufficiale evidentemente a palazzo viceregio, al quale erano stati invitati «insieme all’illustre Teodoro Mommsen» il prof. Pietro Tacchini dell’Università di Palermo, i senatori conte Franco Maria Serra e can. Giovanni Spano, il consigliere delegato cav. Alessandro Magno, il preside dell’Università prof. Gaetano Loi, i proff. Patrizio Gennari e Filippo Vivanet (quest’ultimo Commissario alle antichità) . In un brindisi il Mommsen arrivò ad esprimere incauti giudizi che negavano la storicità di Eleonora d’Arborea; confermò di voler «smascherare l’erudita camorra» isolana; scherzò poi un po’ troppo pesantemente sui suoi propositi di voler condannare prossimamente la quasi totalità della documentazione epigrafica isolana, ed in particolare le «iscrizioni di fabbrica fratesca».
Qualche giorno dopo su “L’Avvenire di Sardegna” (in prima pagina domenica 21 ottobre) compariva una polemica lettera «d’oltretomba» firmata da una desolata Eleonora d’Arborea ed indirizzata all’«avvenente prof. Filippo Vivanet»: lo studioso veniva aspramente contestato per aver «tollerato che il germano passasse il Reno», per non aver difeso la storicità di Eleonora, di fronte all’«invidioso tedesco» ed all’«incalzante orda germanica» e per aver, con il pranzo prefettizio, digerito «l’insulto fatto alla [sua] memoria»; forse aspettava «che il tedesco abbia ripassato il Reno ed abbia frapposto … qualche migliaio di leghe». Anche il senatore Spano veniva strapazzato alquanto, tanto da essere considerato un traditore, per il quale si suggeriva una punizione esemplare: egli doveva diventare la «zavorra» utilizzata per il «globo aerostatico» sul quale il Vivanet avrebbe dovuto errare per sempre, lontano dalla terra sarda; eppure, «se al canonico Spano avessero toccato i suoi Nuraghi, quante proteste non si sarebbero fatte !».
—-
L’archeologo can. Govanni Spano invitato a difendere Eleonora d’Arborea dall’assalto di Theodor Mommmsen (a. 1877).
—–
A. Mastino, Il viaggio di Theodor Mommsen e dei suoi collaboratori in Sardegna per il Corpus Inscriptionum Latinarum, in Theodor Mommsen e l’Italia, Atti dei Convegni Lincei, 207, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma 2004, pp. 227-344