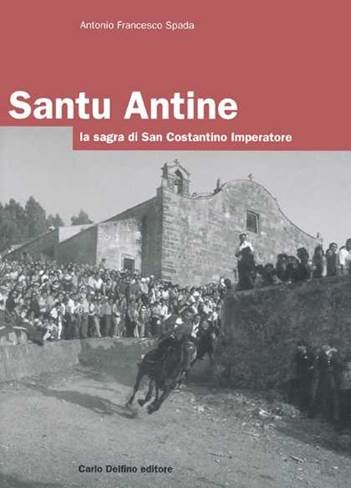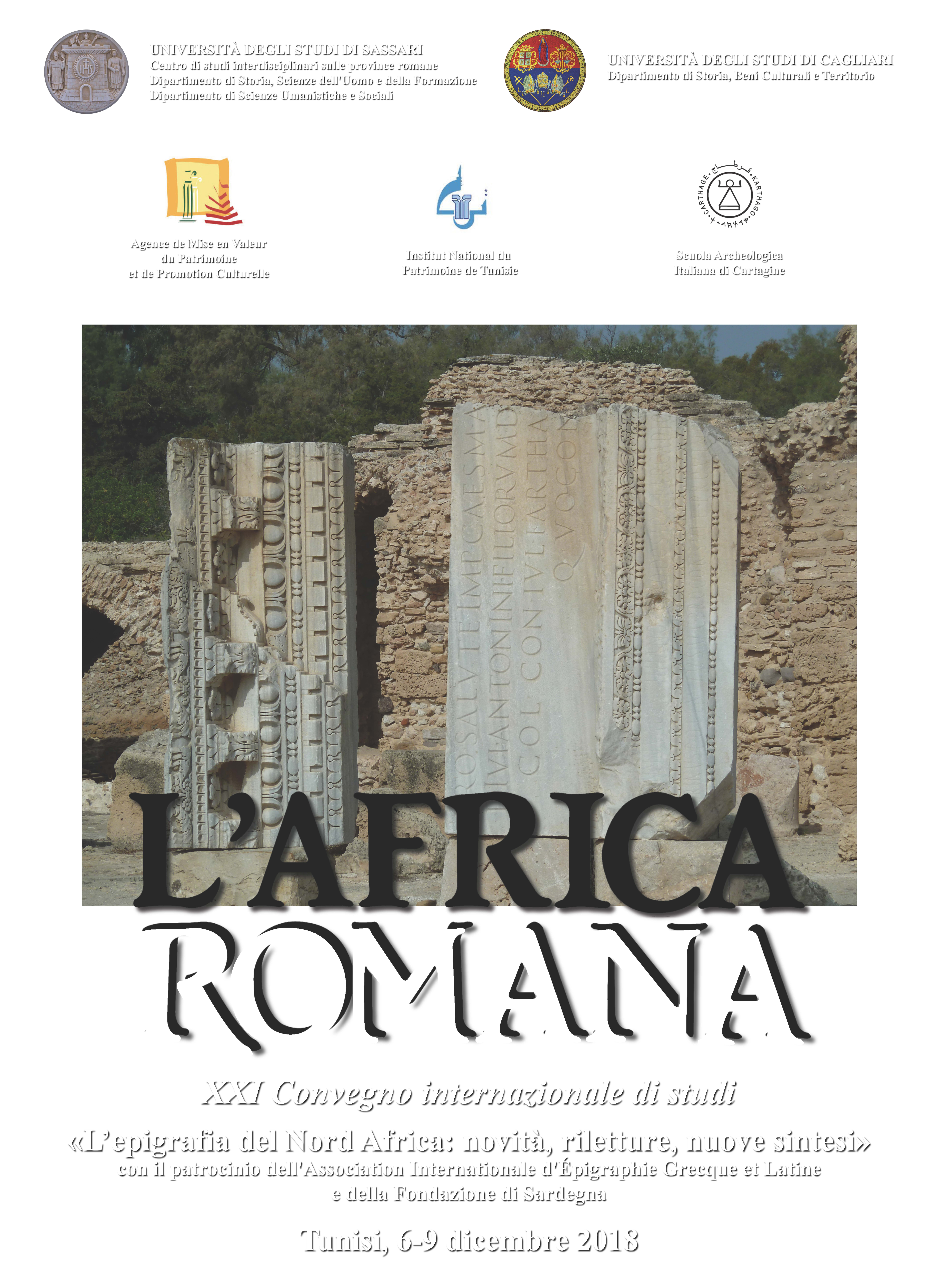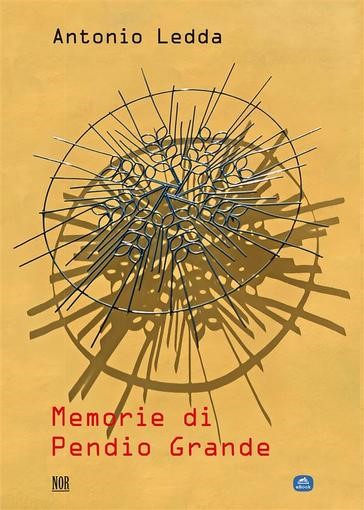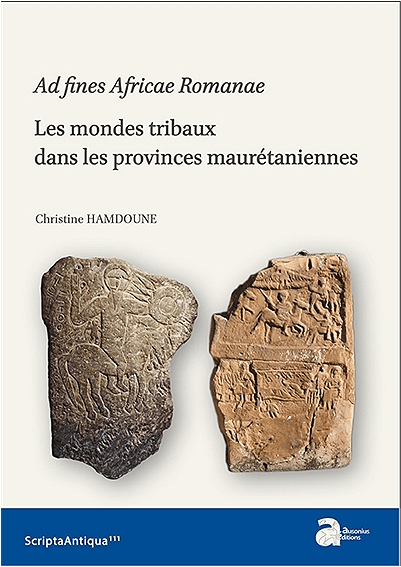Presentazione del volume Caro professore, Le ho portato un uovo, Chirurghi e chirurgia col cuore nella Sassari dal 1967 al 2012, di Giuseppe Dettori e Salvatore Gullotta Di Mauro, Carlo Delfino Editore, Sassari 2017
 Sassari, 8 giugno 2019
Sassari, 8 giugno 2019
Ho sfogliato con emozione e sorpresa queste pagine delicate, scritte con dolcezza da Pinotto Dettori, nelle quali però si apprezzano i puntualissimi interventi di Salvatore Gullotta di Mauro, che corregge, addolcisce, taglia e cuce, sempre con un tocco di signorilità e distacco. Eppure anche con la capacità di lasciare all’opera uno straordinario sapore di autenticità e di vita vera, impastata con la partecipazione profonda al dolore dei pazienti e con la gioia per le relazioni con la famiglia, gli allievi, gli studenti, gli amici. Un’opera solare e piena di ricordi positivi, di aneddoti, di storie sulle vicende della chirurgia generale sassarese nel momento del suo massimo successo: ne deriva l’ammirazione del lettore per una vita professionale unica e per una inconsueta capacità di narrazione che fa emergere una passione vera, tante qualità e tanti successi.
Anche tanti rimpianti, sempre con ironia, con il sorriso sulle labbra, con la capacità di non prendersi troppo sul serio, con la comprensione per gli errori degli altri, con tanta intelligenza, con umiltà. Io oggi sento molto la responsabilità che mi è stata assegnata, quella di riassumere brevemente una storia lunga, che inizia oltre 50 anni fa a Sassari e che prosegue ben oltre i limiti di questo libro.
All’uno e all’altro autore, così come all’editore Carlo Delfino mi lega una amicizia da vecchia data, l’ammirazione per quanto hanno saputo fare per Sassari e per la Sardegna. Ho conosciuto Salvatore Gullotta, nato a Giardini Naxos in Sicilia ma sardo dal 1966, soprattutto come prefetto di Sassari per quattro anni dal 2003, poi di Cagliari fino al 2009; soprattutto come autore di tanti volumi, alcuni dei quali mi sono davvero cari:
– “Monti di pietra” nel 2001(un prefetto dal cognome siciliano, Basile, viene inviato in Sardegna …);
– Terre e genti di Sardegna nella letteratura geografico-politica dell’Ottocento, nel 2005, con riferimento al paesaggio agrario, ai diritti collettivi di pascolo prima dell’editto delle chiudende;
– “Caratteri istituzionali della Sardegna arcaica” nel 2014;
– da ultimo “Il mistero dei primi Sardi (tra mito, storia e scienza)”, dove l’isola eudaimon diviene dimora di dei e di uomini fortunati, collocata nell’estremo occidente, patria di una lontana civiltà perduta, la cultura nuragica, che Gullotta vorrebbe studiata meglio e oggetto di attenzione anche nelle Scuole. Sempre con uno sguardo profondo e originale, con una conoscenza della bibliografia più recente, anche col coraggio di confrontarsi con tanti luoghi comuni.
La mia amicizia con Pinotto Dettori è ancora più antica, ma mi rimane sempre nel cuore con gratitudine l’episodio quasi tragico del Prorettore Giulio Rosati, colpito da un aneurisma aortico che sarebbe potuto essergli fatale nel 2011: Pinotto lo aveva operato d’urgenza e mi aveva colpito il fatto che subito dopo l’operazione aveva voluto informare concitatamente il Rettore del rischio corso e del successo per l’assenza di danni cerebrali da ischemia, quando già disperava di salvarlo. Arrivai in rianimazione poche ore dopo, ma non osai entrare nella stanza di degenza, poi seppi tutti i particolari da Giovanna e da Irma, che mi raccontarono come Giulio dovesse la sua sopravvivenza al tempestivo intervento del chirurgo. Il Prorettore Rosati riprese mesi dopo il suo lavoro con l’impegno di sempre, fino a quel ferragosto 2016, quado subì un attacco cardiaco a Fertilia. Personalmente lo ricordo con gratitudine e affetto, ma lasciatemi citare alcuni altri nomi di comuni amici oggi scomparsi, che hanno contato davvero tanto nella mia vita, e nella vita di tanti sardi, col ricordo e il rimpianto affettuoso per Cesare Canalis, Francesco Ginesu, Maurizio Longinotti, Giommaria Marongiu, che giganteggiano in queste pagine, assieme a tanti altri protagonisti della sanità in Sardegna.
Ma questo libro non è un libro dei morti ma dei vivi, a differenza del disperato Il giorno de giudizio di Salvatore Satta, è un libro capace di ricostruire un mondo colorato che rischiava di inabissarsi nell’oblìo, perché attraverso mille storie, mille dettagli, mille racconti curiosi l’autore riesce nell’impresa di farci condividere il senso positivo dell’esistenza, il valore dell’impegno e del sacrificio personale, la dimensione del tempo libero, la gioia del ritrovarsi. Con una memoria davvero strabiliante e con la capacità di cogliere emozioni, passioni, piccole storie di uomini, che vanno ben al di là della routine della sala operatoria.
C’è un capitolo inconsueto in questo volume ed è quello dedicato ai due mesi trascorsi ad Hanoi in Vietnam nel 1994, a vent’anni dalla fine della guerra, con lo scopo di approfondire il tema della manualità nella chirurgia epatica. Il titolo di chirurgo spettava nel mondo greco a quei medici che utilizzavano le mani per operare, da cheir – cheiròs: del resto manu consilioque è il motto della prestigiosa Academie Royale de Chirurgie di Parigi, fondata nel 1731 alle origini della medicina moderna. Ma è in oriente che l’arte chirurgica è veramente fondata sulla manualità, con una indubbia efficacia, come quella che si praticava al Duc Hospital di Hanoi, tra agopuntura, digitoclasìa e resezioni epatiche ottenute con la sola pressione delle dita secondo il metodo di un maestro come Thon That Tung. Pinotto Dettori si è confrontato con gli allievi del grande maestro in un ospedale stracarico di pazienti e di bisogni. In generale la casistica relativa a patologie gastroenteriche ed epato-biliari-pancreatiche era imponente, legata soprattutto agli effetti della guerra, ai bombardamenti, ai diserbanti. Accompagnato da Ninni Dessanti e dall’anestesista Giampiero Silvietti, Pinotto scopre e riesce ad osservare con uno sguardo davvero profondo un mondo di povertà, di sofferenza, di dolore che emerge lentamente da una lunga guerra che è stata combattuta soprattutto con le bombe americane che hanno causato in migliaia di casi un carcinoma epatico: più in generale rimane sorpreso per l’assenza di benzina, la rigida divisione sociale tra i quartieri della capitale, il senso assillante della proprietà da difendere con saldissimi lucchetti, in un mondo che aveva concepito l’utopia dell’abolizione della proprietà privata; sulle strade il frenetico vagabondare della gente verso una meta sconosciuta, la successione di misere botteghe, le povere case di abitazione, il numero impressionale delle biciclette e delle motociclette Honda costruite con l’acciaio dei carri armati americani. Le tradizioni culinarie, il sapore unico del caffè vietnamita quasi un condensato, gli involtini di erbe e terra, le bellezze struggenti dell’ambiente naturale nella vallata del fiume rosso (Sông Hồng) fino alla foce di Halong con le sue mille isole.
Con una descrizione incredibilmente ricca di dettagli gli autori ci portano lontano: la leggenda vuole che <<la baia di Halong si salvò dall’invasione cinese per l’intervento di un gruppo di draghi inviati dagli Dei. Questi draghi, oltre al proprio fuoco, sputarono in mare migliaia di preziosi gioielli, da ciascuno dei quali nacque un’isola. Unendo fra loro queste isole, si creò d’incanto una barriera invalicabile, che respinse definitivamente i cinesi, e permise agli abitanti di far propria quella loro grande terra, che si sarebbe in seguito chiamata Vietnam>>.
Ci sono perfino pagine che hanno un valore letterario, legate al viaggio: <<ai nostri occhi comparve uno spettacolo da sogno: dalla superficie del mare, calmo e di un colore variabile, a seconda dell’incidenza della luce e l’altezza del sole, dal verde smeraldo al verde petrolio, sbucava, con una bellezza quasi irreale e con un effetto mai visto in precedenza, un numero incalcolabile di isole ed isolotti, di forma e dimensioni variabili, delicatamente poggiate su quel mare piatto da cui emergevano, tutte ricoperte pressoché interamente dalla stessa varia vegetazione della costa. Il quadro, stupendo, dava quasi allo spettatore la fallace impressione che il mare avesse poco prima parzialmente inondato la costa, della quale erano rimaste visibili le alture più sporgenti, nella nuova magnifica veste di miriadi di isole. Oppure che il mare, specialista in erosioni, avesse nel corso dei millenni, man mano staccato dalla costa miriadi di pezzi, trasformandoli in altrettanti isolotti ricoperti del loro vecchio manto vegetale, dalle dimensioni più varie e dalle forme più strane e irregolari, come appunto possono essere quelle disegnate dall’erosione del mare>>.
Se c’è una cosa che mi ha colpito in queste pagine, è la capacità di distinguere tra le eredità del comunismo e quelle del colonialismo francese, tra le tradizioni culturali millenarie, le forme religiose, le relazioni sociali che non rimandano alla storia recente ma che si capiscono solo partendo dalle radici profonde della cultura dell’estremo oriente, in questa stretta lingua di terra, lunga più di mille km, che unisce la vallata del fiume rosso a Nord e quella del Mekong a Sud. Questo è il Vietnam di oggi, che ho visitato qualche anno fa fermandomi ad Hué, per i 40 anni della Facoltà poi Università di Medicina, dove Piero Cappuccinelli e Bruno Masala hanno inaugurato un laboratorio dell’Università di Sassari: dietro la facciata di un’organizzazione di massa voluta dal comunismo trionfante è possibile scorgere la grazia dei balli orientali, la musica, il carattere pacifico delle persone, la bellezza incredibile di ragazzi e ragazze, la cucina tradizionale, il senso di sopportazione per la povertà estrema, ma anche i monumenti, le ferite della guerra, come a My Son nei templi restaurati da un’università Italiana, la delicatezza dell’ambiente naturale violato dalle bombe, i pittoreschi laghetti, i mausolei, le pagode come sul fiume dei profumi, il Song Huong River. Una lontana tradizione imperiale della dinastia Nguen è rimasta vitale anche grazie all’eroismo dei monaci buddisti suicidi col fuoco a Saigon, di cui si conservano religiosamente le reliquie, come l’auto Austin di Hué; siamo a qualche chilometro di distanza dalla baracca dove è vissuto Ho Ci Min. Un Vietnam che progressivamente si sviluppa e si afferma.
Ma il cuore di Pinotto Dettori è tutto in Sardegna, nella clinica di viale San Pietro, poi nella sala operatoria dove ha trascorso gran parte della sua esistenza, con gli oltre trentamila interventi, nella rianimazione, nel suo reparto chirurgico generale nuovo di zecca che ha fortemente voluto al quinto piano del Palazzo Clemente per la riabilitazione dei suoi pazienti, nella sua famiglia. Infine tra i suoi monti di Padria nella vallata del Temo o di Dorgali verso il Cedrino o nel mare orientale; prima ancora alla ricerca di tordi negli oliveti di Sennori.
Gli autori hanno saputo concentrare in queste pagine i ricordi dolci e amari di una vita che è stata e continua ad essere felice: <<ci sono momenti nella vita, ci sono sensazioni, profumi, atmosfere, che si vivono una sola volta. Bisognerebbe poterli chiudere in una bottiglia e stapparla ogni tanto per riviverli>>. Sono parole di Gianfranco Azzena. Salvatore Gullotta descrive Pinotto Dettori come un narratore che assomiglia ad fiume in piena, uno straordinario affabulatore, come se queste pagine fossero la prosecuzione degli appassionati racconti fatti agli amici di sempre, sui temi diversi, non solo quelli della sua professione, ma anche del tempo libero; con lo scopo di fermare delle immagini nel tempo, di condividere tante storie, soprattutto proporre una visione positiva della vita, di diffondere un messaggio di civiltà; alla fine scopriamo un uomo dal cuore d’oro, generoso e attento per chi ha bisogno di assistenza, un uomo cortese, riservato, umile, allo stesso tempo però capace di inalberarsi con chi a suo avviso ha tradito i valori etici della professione, soprattutto con qualche collega. In appendice sono raccolte le parole dei pazienti, alcune preziose testimonianze di un legame che non si spezza, di una gratitudine e di un’ammirazione profondi, come testimonia l’episodio – recente – dell’uovo portato in dono in clinica dalla vecchina di campagna che dà il titolo al libro.
Gullotta racconta le radici di una vera e propria vocazione, capace di far superare l’ansia, l’iniziale paura del sangue, il terrore di non riuscire a rispondere alle attese dei pazienti e dei loro cari; credo abbia effettivamente pesato sulla scelta della professione la vicenda del padre Giacomo, salvato in extremis dopo un infarto intestinale non riconosciuto dai primi soccorritori, ma poi operato d’urgenza in Clinica Chirurgica dal prof. Leonardo Lojacono. Questo tema della tempestività dell’intervento chirurgico resterà una costante dell’azione del prof. Dettori, che oggi – osservando la caduta della vocazione chirurgica tra i giovani medici – ritiene con una qualche dose di pessimismo che la medicina italiana si sia andata progressivamente appesantendo con quegli esami laboratoristici e strumentali (Tac, Ecografia, Risonanza Magnetica, Angiografia, ecc.) che spesso sono ingiustificati ed eccessivi e, se creano uno scudo a difesa del chirurgo contro le implicazioni legali in caso di insuccesso, rallentano comunque i tempi dell’intervento e dunque paradossalmente finiscono per ridurre le possibilità di sopravvivenza del paziente.
Un secondo stimolo verso la chirurgia è legato agli anni dell’internato e in particolare alle tante vicende terribili vissute in clinica, soprattutto per le malattie in età pediatrica, come la commovente vicenda di Roberto, un bellissimo bimbo biondo al quale il giovane Dettori si era davvero affezionato, operato due volte dal primario Luciano Lorenzini perché affetto dalla malattia di Hirschprng, il megacolon congenito; poi improvvisamente crollato di fronte ad una peritonite implacabile. Oppure la vicenda di Mauro, un bimbo di 6 anni, soffocato dalle orribili masse tumorali. Inizia qui una storia lunga, che questo libro descrive con moltissimi dettagli tecnici, con informazioni di prima mano, direi dalla prima linea del fronte di guerra, col tentativo di cogliere il progredire delle conoscenze e delle tecniche operatorie, le delusioni e le nuove speranze di successo. L’allora Istituto di Patologia Speciale Chirurgica in viale San Pietro ormai era diventato il suo mondo, l’unica strada che poteva seguire, la sua seconda casa: in nessun’altra struttura diversa dalla clinica chirurgica – scrive Pinotto – avrei potuto trovare la stessa accoglienza, lo stesso spazio, la stessa disponibilità all’insegnamento, gli stessi colleghi, le stesse amicizie, gli stessi infermieri, lo stesso personale. È questo il nodo, la ragione per la quale tutta la carriera si è svolta a Sassari in chirurgia generale, lasciando cadere le tante offerte ricevute da Brescia, da Milano, da Ancona, da Siena: per usare le parole di Riccardo Rossi <<hai avuto il merito di riuscire in una impresa senza precedenti: quella di diventare, per la prima volta, da sassarese, direttore della clinica chirurgica della tua università, senza averla mai lasciata prima». Un merito fondato soprattutto sul lavoro duro, sulla ricerca, oggi su oltre 400 pubblicazioni scientifiche, sull’aggiornamento in sede internazionale, sulla partecipazione a un centinaio di congressi. Una fatica, un impegno, un risultato che noi oggi vogliamo onorare davvero.
Gli anni dell’internato del giovane Dettori naturalmente si svolgono nel momento trionfale di ascesa della Chirurgia sassarese (cenerentola fino all’Ottocento), con Luciano Lorenzini, Francesco Saverio Rucci, Aldo Campodonico, maestri coi quali si è consolidato un rapporto inizialmente pieno di imbarazzi e di silenzi (e ciò a causa della timidezza congenita, marchio profondo di sardità), ma poi fondato sulla stima e l’affetto.
Come risulta dai nostri registri, in questa Aula Magna Dettori Giuseppe Lorenzo Giovanni Antonio (nato nel 1942) si è laureato il 3 marzo 1967 con una tesi sulla chirurgia della via biliare e della papilla di Vater, ottenendo la dignità di stampa e l’abbraccio accademico, relatore Lorenzini. Seguiva la laurea dell’amico di sempre Michele La Rocca, gli anni della specializzazione, con una deliziosa descrizione della timidezza del giovane Pinotto di fronte ad esempio alla moglie di Lorenzini, una sorta di Principessa sdegnosetta con gli allievi di primo pelo del marito, che mi hanno fatto ricordare tante storie lontane che mi riguardano. Sullo sfondo rimane la pazienza, il senso di sopportazione, la voglia di farsi conoscere per quel che si vale, anche la consapevolezza che alcuni passaggi sgradevoli sono obbligati. Pinotto si leva tanti sassolini dalle scarpe, come a proposito del primario di oculistica gioviale ed espansivo con i colleghi, freddo e supponente con gli allievi più giovani. Più in generale si colgono in queste pagine le mille difficoltà iniziali, le fatiche dello stabulario, il rapporto con gli animali da esperimento, gli orari impossibili, il sacrificio quotidiano.
E però tante soddisfazioni incredibili, il contatto diretto con i Maestri. A buon diritto Dettori rivendica il collegamento suo e dei propri allievi con la grandissima Scuola di Edmondo Malan, torinese, scomparso a Houston nel 1978; a sua volta allievo del Achille Dogliotti (scomparso nel 1966) e sempre a Torino di quel mitico Giuseppe Levi, anatomico, maestro di tre Premi Nobel, che insegnò anche a Sassari dal 1909 al 1913, ebreo, privato della cattedra dalle leggi razziali nel 1938, padre della scrittrice Natalia Ginzburg che nel romanzo Lessico familiare ricorda il soggiorno in Sardegna.
Malan, tra Genova, Parma e Milano, fu il maestro del siciliano Salvatore Occhipinti a Sassari titolare della cattedra di anatomia chirurgica; poi di Giorgio Tiberio arrivato da Milano nel 1973 fino al nostro Paolo Biglioli, che oggi abbiamo l’onore di ritrovare. Credo siamo ai vertici della chirurgia nazionale.
Ci sono tanti nomi di maestri, alcuni scomparsi, che ricorrono in queste pagine, come Giovanni Tota, Raffaele Palomba, Ugo Satta, Ignazio Fresu. La meteora milanese Riccardo Rossi e il suo aiuto Orlando Ferri, ai quali Pinotto sa di dovere comunque la nomina nel 1969 ad Assistente ordinario. E poi Salvatore Occhipinti, Giorgio Tiberio, Paolo Biglioli, con una crescita progressiva della tecniche operatorie e straordinari successi professionali, fondati su conoscenze che sono state generosamente trasmesse dai Maestri, che hanno saputo mettere a parte i colleghi dei segreti di tanti interventi difficili come quelli sulla chirurgia dell’aorta toracica, i tumori pleuro-polmonari, le grosse cisti da echinococco epatiche e polmonari, le grandi resezioni epatiche, le pancreasectomie, i tumori delle vie biliari, le esofagectomie e i tumori digestivi, ambiti spesso affrontati in Sardegna unicamente dalla clinica chirurgica sassarese, fortemente competitiva a livello nazionale. Una storia difficile, irta di difficoltà ma piena di successi. In parallelo si segue una carriera straordinaria, che passa per il concorso nazionale a professore associato nel 1980, la direzione pro tempore dell’istituto di patologia chirurgica dell’Università e la chiamata come professore ordinario nel 1986, a 44 anni di età. Infine, nel 1987, in coincidenza col rientro di Biglioli a Milano, la nomina a direttore della clinica chirurgica universitaria, con delibera unanime della Facoltà.
Un capitolo del libro è dedicato agli sforzi compiuti per la nascita della cardiochirurgia in Sardegna, soprattutto grazie alle esperienze compiute da Paolo Biglioli a Lovanio in Belgio, alla scuola del prof. C.H. Chalant, così come in Olanda: m’immagino che sarà lui stesso a parlarcene oggi, ma vorrei portarvi per un momento a quell’8 giugno 1979, quando Biglioli eseguì con successo il primo intervento cardiochirurgico in Sardegna. La tradizione prosegue oggi con l’Unità operativa complessa dell’AOU di Sassari diretta da Michele Portoghese a Sassari, in parallelo con la Struttura complessa di Cardiologia–UTIC-Emodinamica dell’AOU di Cagliari, diretta da Luigi Meloni.
Il ruolo di direttore della clinica svolto da Pinotto Dettori fu caratterizzato da un’impronta personale, da uno stile, da un’attenzione che hanno dato un’impostazione positiva a tutto il suo lungo mandato, durato 27 anni, in una clinica dove doveva essere coordinata l’attività di oltre 130 tra chirurghi, specializzandi, studenti interni, personale tecnico-amministrativo, capo-sala, infermieri e ausiliari, per non parlare delle migliaia e migliaia di pazienti operati. Soprattutto l’attenzione per gli allievi, che qui voglio solo citare di corsa, alcuni collocati in altre cliniche a Sassari o in altre sedi, il compianto Pier Paolo Bacciu, Giuseppe Noya, Angelino Gadeddu, Ninni Dessanti alle origini della chirurgia pediatrica, Franco Badessi, Gianfranco Porcu; conosciamo ora molti retroscena, molti episodi, a cavallo tra sala operatoria e campi di caccia, tra lavoro e tempo libero.
Emergono i due allievi prediletti di sempre Pietro Niolu e Alberto Porcu, che Dettori conosce da quasi quaranta anni e che ritiene <<chirurghi di straordinarie capacità tecniche e morali>>. Niolu nel campo della chirurgia digestiva, epato-bilio-pancreatica, endocrina, vascolare e toracica fino al primariato all’Ospedale SS.ma Annunziata. Porcu con questa forte inclinazione per la chirurgia epato-bilio-pancreatica e i trapianti epatici, un tema maturato a contatto con Mauro Salizzoni a Le Molinette di Torino, ma anche a Miami con Andrea Tzakis, a Parigi con Heny Bismuth.
Il rimpianto è quello di non esser riuscito a radicare a Sassari il Centro per i trapianti epatici, ma l’esperienza internazionale fatta da Porcu a questo scopo non è andata perduta: ordinario dal 2006, ha diretto dopo Noya la struttura di chirurgia d’urgenza e poi ha ereditato la direzione della clinica chirurgica a partire dal I novembre 2012. A Niolu e Porcu, Dettori guarda davvero con affetto e stima, per la statura professionale e umana di entrambi. Del resto, per riprendere una frase di Pietro Valdoni, <<Guai a quel maestro che non è in grado di formare almeno un allievo più bravo di lui>>.
Un largo spazio è dato nel volume agli altri allievi e collaboratori, che posso citare solo velocemente. Ad alcuni di loro mi legano rapporti di stima e gratitudine: Maria Antonietta Lamberti, Antonio Scanu che ho apprezzato in CdA tra il 2006 e il 2008, Giannella Chironi, Pierina Cottu, Pietro Marogna, Laura Cossu, Claudio Feo, Annella Carta, Rosa Ermini, Giorgio Ginesu, Alessandro Fancellu, Giuliana Giuliani, Giannino Rizzo, tutti seguiti con affetto nel corso dei loro studi e poi nella loro successiva carriera accademica o ospedaliera. Le capo sala, dalle suore iniziali alle caposala laiche, tra le quali rimane la simpatia per Pasquangela Piga e le sue colleghe fino a Rosa Spanedda, tutte attente osservatrici e protagoniste di una serie incredibile di episodi divertenti, raccontati perché fissati nella memoria con lo scopo di alleggerire la tensione dell’intervento, superare le preoccupazioni per la vita del paziente, creare una valvola di sfogo per una tensione che in nessun modo doveva esplodere in sala operatoria. Gli infermieri di reparto e degli ambulatori, circa 70 unità, distribuite nel complesso operatorio, forte di tre sale chirurgiche, nel reparto di degenza femminile, forte di 30 letti, più tre riservati al day-surgery; nel reparto di degenza maschile, forte di 28 letti, più due di day-surgery; nel complesso ambulatoriale, con due ambulatori per chirurgia generale, due per chirurgia vascolare, due per senologia clinico/diagnostica ed uno per ecografie trans-rettali e controllo degli stomizzati; nel settore diagnostico strumentale, con due locali per la diagnostica vascolare; nel settore endoscopico digestivo, composto da una saletta d’attesa e da due ampi locali contemporaneamente operativi, dotati di gastroscopi, colonscopi e rettosigmoidoscopi. Un capitolo speciale è dedicato agli infermieri professionali strumentisti e agli infermieri generici di sala operatoria: Pinotto Dettori con poche pennellate ha la capacità di far emergere le singole figure, caratterizzate per la serietà, la dedizione, la bravura, l’impegno; non solo nomi ma personaggi, perché il professore conosceva le origini (penso a Gavino Nurchis di Sorso), le qualità, le capacità e le potenzialità di ciascuno. Ancora i portantini, i barellieri, gli ausiliari, gli operatori socio-sanitari OSS.
Infine gli specializzandi, il personale tecnico amministrativo dal segretario storico Mario Derosas a metà degli anni 60 fino a Tino Micelli, che è voluto andare in pensione in contemporanea con il suo direttore. Per non citare anche Daniela Petretto, Fabrizio Cossu, Edoardo Dasara e tanti altri. Solo l’attenzione del personale di segreteria ha consentito al primario di compensare la sua totale impossibilità ad assolvere di persona agli innumerevoli impegni burocratici e alle loro perfide scadenze, recluso com’era – così si esprime -, all’interno di quell’amata prigione che si era scelta, ove, tra sala operatoria, reparti di degenza, ambulatori, visite, attività didattica, attività di ricerca scientifica, discussione quotidiana di casi clinici, attività accademica con i suoi onerosi impegni, politica di Facoltà, partecipazione attiva a congressi locali, isolani, nazionali ed internazionali, urgenze operatorie diurne e notturne, e quant’altro volete aggiungere, non era matematicamente possibile per lui disporre di un solo straccio di minuto da dedicare a qualsiasi altro impegno.
Non manca la gratitudine per una collaborazione con gli anestesisti e i rianimatori, da Paolo Ruju a Gavino Ligios, da Agostino Frassetto a Pietrino Mastroni a tanti altri. Per i colleghi della Facoltà, in particolare il preside Giuseppe Madeddu, il direttore di neurochirurgia Carlo Perria, il neonatologo Angelino Dore, il direttore di anatomia Gianni Massarelli: <<Mentre scrivo – conclude il prof. Dettori – i vostri volti amichevoli e sorridenti mi scorrono uno per uno davanti agli occhi, e ancora oggi mi ispirano simpatia e forti sentimenti di gratitudine. Grazie a voi tutti, infatti, ed alla vostra grande professionalità, ho potuto vantare, al termine della mia faticosa, ma per me come per voi, sempre meravigliosa ed amata vita professionale, una casistica operatoria di assoluto valore numerico e qualitativo, in buona parte costituita da interventi di alta ed altissima chirurgia, con risultati altamente competitivi>>. Senza dimenticare i colleghi di altre Facoltà, tra quali l’amico Paolo Muzzetto, i fecondi rapporti di collaborazioni con i Rettori da Antonio Milella e Vanni Palmieri fino a Massimo Carpinelli, con una gratitudine specialissima per Alessandro Maida, preside e rettore al quale Pinotto sa di dovere moltissimo.
In parallelo questo volume sviluppa i temi legati alla didattica, all’insegnamento, alle tante discipline impartite, anche a tanti episodi curiosi e divertenti; infine la ricerca, le pubblicazioni, l’attività congressuale, i simposi, i corsi di aggiornamento; ancora il rapporto con la politica, la forte amicizia con l’Assessore Giorgio Oppi che oggi è con noi, l’impegno per nuove apparecchiature, nuovi spazi, nuovi investimenti per difendere i risultati raggiunti, per riconoscere le professionalità esistenti, per evitare l’emigrazione dei nostri malati. Per queste ragioni la nascita del Mater Olbia voluto da una strana alleanza internazionale gli sembra ancora oggi un pericolo per la qualità della sanità sassarese ora finalmente riunificata nell’AOU. I rapporti con la sanità cagliaritana.
Quando il 19 ottobre 2012 i suoi allievi organizzarono una giornata in suo onore in questa aula magna, il professore ascoltò le lezioni di alcuni maestri arrivati da Parigi e Londra (Henry Bismuth, Daniel Azulay, Paola Andreani) e ricevette dal suo Ateneo una medaglia ricordo e il sentimento diffuso di stima e rispetto.
In questo libro ci sono anche delle deliziose pagine dedicate alla vita privata, e in Meglio operare che operato, si racconta del debito di gratitudine verso Paolo Tranquilli Leali, verso Carlo Doria, Luca Cavazzuti, Teresanna Zolo per il doppio difficile intervento di artoprotesi d’anca, resosi necessario per questa artrosi bilaterale delle anche, causata credo dalle faticose esperienze di caccia sui monti di Dorgali.
E allora concludiamo proprio con la caccia e il tempo libero, partendo dai questi meravigliosi cani compagni di vita. L’autore si intenerisce e si sente in dovere di ricordare i cani da caccia ai quali è stato più affezionato e che gli hanno dato tante soddisfazioni, protagonisti di tante straordinarie avventure, ricordate con l’animo di un ragazzo curioso e sempre capace di sorprendersi: il pointer bianconero Rudi, soprannominato il professore, Loa delle Vallate, setter femmina bianconera, soprannominata “l’eccelsa”; Naìs delle Vallate, setter femmina bianconera, detta “la beccacciaia”; Rey della Bassana, figlio diretto del mitico campione internazionale Lopez della Bassana, setter maschio bianco-fegato di rara bellezza, detto ”superdog”; Vespa, insuperata setter femmina bianco-albina, nota come “miss caccia” e forse la più straordinaria fra tutte Freccia delle Vallate, setter femmina bianconera, detta “non ce n’è per nessuno”. Ed infine oggi, l’ultima campionessa, la bellissima setter gordon nero-focata, Zama ossia “il folletto”, un soprannome coniato durante la caccia alle beccacce. Come dimenticare il mio epaniel breton Full del Piceno o Teodosio Rusty dell’Alta Nurra ?
Non vengono dimenticati i cani degli amici, come Argo di Lorenzini, il bracco francese bianco nero pezzato di altissima geneaologia. Esilarante è la vicenda di Sancio, il magnifico setter bianco-arancio del professore fiorentino Francesco Saverio Rucci, specialista nella caccia alle quaglie sulla strada dei due mari: <<Sancio, veniva descritto dal padrone come un campione inarrivabile, dotato di un naso iperosmico di portata analoga al radar degli aeroporti, forte ed instancabile, appassionato cacciatore, ma soprattutto munito, come sua massima credenziale di spicco, della più solida e statuaria “ferma”, osservabile solo nei veri campioni>>. Una ferma così statuaria che, dopo una folle corsa, il cane si bloccò del tutto e <<alla fine, di comune accordo, sollevammo in due il povero Sancino e lo trasferimmo nel cassone del fuori strada, ove mantenne, non ci crederete, sempre la stessa identica posizione di ferma!>>.
C’è un’altra storia esilarante che riguarda il cane del prof. Tiberio, Bacone, un cocker bianconero piccolo di taglia e lunghissimo di orecchie, secondo il proprietario gran cacciatore di pernici, in realtà un pigrone totalmente incapace ma opportunista, bravissimo nello sfruttare a tradimento l’abilità della più solerte Loa l’eccelsa: così quel giorno a Chiaramonti, quando Bacone continuò a impadronirsi della selvaggina scovata da altri cani in ferma, sopraggiungendo di corsa e impedendo ai cacciatori di arrivare in tempo per avvicinarsi alla zona-tiro, innervosendo la campionessa che iniziò a tentare di precedere il furbissimo collega, interrompendo nervosamente la ferma quando udiva la corsa sfrenata di Bacone. Dice Pinotto di aver subito allora il massacro delle giornate di caccia, la massima salvaguardia della selvaggina, il cattivo addestramento alla ferma dei suoi cani solo per rispetto per il primario, che finalmente riuscì a capire di dover lasciare a casa il cocker Bacone e il figlio Guidino.
Introdotto dall’amico Ugo Ticca a Dorgali quando aveva 16 anni, Pinotto oggi conosce i migliori luoghi di pesca e di caccia del territorio di Dorgali, tra Osalla, Cartoe, Gonone, Fuili, Nuraghe Mannu, Cala Luna, il Bue Marino: la bellezza della costa calcarea, l’incanto del mare smeraldo, la dolcezza delle dune di sabbia bianchissima fra le quali si annidano boschetti di ginepro, il lentischio come il rosmarino e, soprattutto, l’elicriso, il cui profumo invadeva l’aria. Guardandosi indietro sembrano scomparire gli anni trascorsi che hanno conosciuto anche i sequestri di persona, perché, come ha scritto in questi giorni Franco Mannoni, <<ci si dimenticava, a un’ora da Nuoro e dalle Barbagie, dei banditi e dei manifesti-taglia con le fotografie dei latitanti affissi ai muri. Il bagno aveva un effetto liberatorio, purificatore>>.
Ma è soprattutto all’interno che Pinotto si è concentrato verso luoghi meravigliosi che mi sono cari come oltre la valle di Isalle, Oddoene, Lanaittu, Tiscali, la gola di Gorruppu. E poi all’ingresso del paese le grotte di Ispinigoli, Serra Orrios e le fonti di San Giovanni, lo Spirito Santo e Golloi con i resti della strada romana orientale che collegava Tibula con Carales. Luoghi che hanno un significato anche per noi archeologi che abbiamo studiato la Viniola sul rio Flumineddu a N.S. del Buoncammino, in regione Oddoene, un’area fertile dove dovevano essere impiantati piccoli vigneti che segnavano il paesaggio in età imperiale; da qui la strada si arrampicava prima di Su Gorroppu per Genna Silana per entrare nella misteriosa Ogliastra. Il sole, il mare, il vento, i monti: un ambiente fantastico, ricco di cinghiali e non solo. Un grande onore per l’Università è stato il fatto che Pinotto abbia ricevuto a Dorgali il 5 novembre 2011 la cittadinanza onoraria dal sindaco Angelo Carta.
Voglio ricordare però anche Padria-Gurulis vetus, con la riserva dell’avv. Pietrino Passino ed ora quella di Pier Felice Poddighe ai piedi di Monte Minerva, con la compagnia di caccia di S’Aldiga, che ho avuto modo di conoscere, anche se solo a pranzo, con tanti amici, compreso il veterinario Muzzetto, celebre per ricucire cani e cinghiali.
Guardando le immagini del pranzo di caccia a Berchidda mi viene di pensare a Niccolò Machiavelli nell’osteria di San Casciano: <<Con questi io m’ingaglioffo per tutto dí giuocando a cricca, a trich-trach, e poi dove nascono mille contese e infiniti dispetti…>>.
Ma poi: <<Venuta la sera, mi ritorno a casa ed entro nel mio scrittoio; e in sull’uscio mi spoglio quella veste cotidiana, piena di fango e di loto, e mi metto panni reali e curiali; e rivestito condecentemente, entro nelle antique corti delli antiqui huomini, dove, da loro ricevuto amorevolmente, mi pasco di quel cibo che solum è mio e ch’io nacqui per lui>>.
Sono infine tante le pagine dedicate alla moglie Cicci Gaiani dalla iniziale simpatia in clinica e fino al matrimonio a Saccargia nel 1972, col suo laboratorio di analisi di Via Diaz. Forse mi sbaglio, ma mi è sembrato quasi che qualche pagina di questo libro sia stata scritta a sei mani, perché ogni tanto spuntano i ricordi della Signora, come per l’esame con Occhipinti. Ancora i figli, l’avvocato Giacomo e il microbiologo Marco, i nipotini amati Matilde, Riccardo e Federico. Tanti affetti, tanti amici, tanta simpatia, tanta voglia di amare da parte di un uomo che non ha conosciuto la solitudine.
Credo di dover concludere: tra i motivi dell’amicizia con Angelino Dore ho visto ci sono i cani Lea e Zama, la raccolta di asparagi e funghi, la pesca, il legame con un amico di Castelsardo provetto arrostitore, capace di far gustare deliziose triglie arrosto.
Per un momento lasciatemi tornare ai miei temi su Roma antica. Ho pensato alla lettera scritta nel 52 a.C. da Milone a Cicerone, che non era riuscito a difendere l’amico durante il processo per l’uccisione di Clodio. Condannato, Milone se ne era andato in esilio a Marsiglia e scriveva a Cicerone commentando la famosa orazione in suo favore meravigliosamente scritta ma mai recitata in pubblico per le proteste dei populares: «Per me è stata una fortuna che queste parole non siano state mai pronunciate in tribunale. Altrimenti non starei a gustare triglie arrosto qui a Marsiglia, se fosse stata pronunciata una tale arringa».
Spero che queste mie parole non abbiano rovinato l’appetito di Pinotto e di voi tutti.
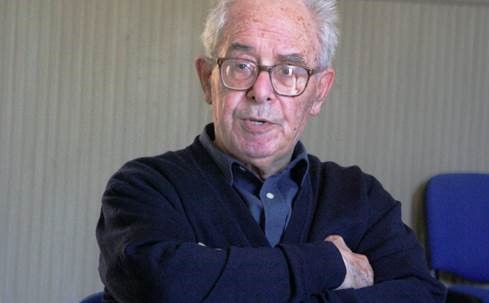 Ho visto per l’ultima volta a Sedilo Mons. Antonio Francesco Spada una settimana fa, nella casa di famiglia, a due passi della Parrocchiale di San Giovanni Battista, alla vigilia della pittoresca Ardia in onore del “suo” San Costantino. Era circondato dall’affetto dei familiari, degli amici, degli infermieri che lo assistevano con amore. Non voleva lasciarmi andar via e voleva continuare a raccontare, a dire quanto era felice per avermi potuto accogliere a casa sua a Sedilo, quanto gli erano cari Bosa e i Bosani, le suore della Sacra Famiglia, la sua Cattedrale. Mi ha detto di farlo sapere a tutti, ma già tutti lo sappiamo attraverso Radio Planargia e le parole di Paolino Fancello, suo amico fedele.
Ho visto per l’ultima volta a Sedilo Mons. Antonio Francesco Spada una settimana fa, nella casa di famiglia, a due passi della Parrocchiale di San Giovanni Battista, alla vigilia della pittoresca Ardia in onore del “suo” San Costantino. Era circondato dall’affetto dei familiari, degli amici, degli infermieri che lo assistevano con amore. Non voleva lasciarmi andar via e voleva continuare a raccontare, a dire quanto era felice per avermi potuto accogliere a casa sua a Sedilo, quanto gli erano cari Bosa e i Bosani, le suore della Sacra Famiglia, la sua Cattedrale. Mi ha detto di farlo sapere a tutti, ma già tutti lo sappiamo attraverso Radio Planargia e le parole di Paolino Fancello, suo amico fedele.