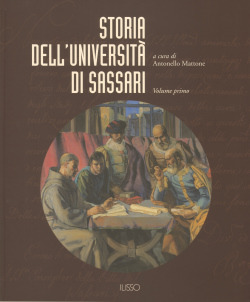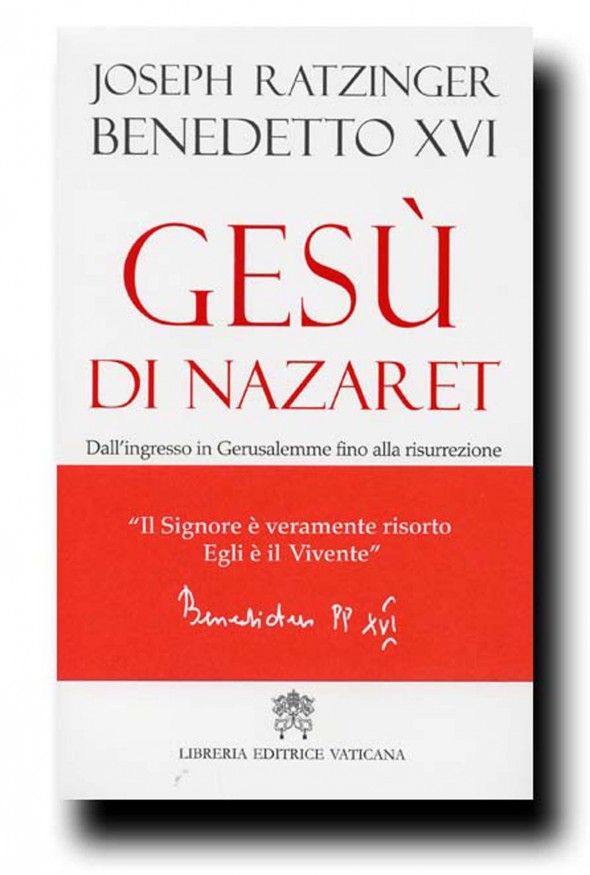Seminario nazionale Quale Futuro per la cultura classica?
Attilio Mastino
Quale futuro per gli studi classici in Europa?
Oristano, 22-23 febbraio 2012
Seminario nazionale “Quale futuro per la cultura classica?”

Cari amici,
debbo all’amicizia con Guido Tendas l’invito a prendere la parola in questo Seminario nazionale “Quale futuro per la cultura classica?”, promosso dal Liceo Classico Salvator Angelo Decastro di Oristano, che nel nome ricorda il grande latinista, un protagonista della vita culturale della Sardegna dell’Ottocento a fianco di Giovanni Spano e Gavino Nino: personaggi in qualche modo coinvolti nella vicenda delle Carte d’Arborea alla quale guardiamo oggi con una qualche maggiore indulgenza, se non altro perché espressione di un profondo amor di patria e di una straordinaria conoscenza delle fonti sulla Sardegna.
Nel recente passato abbiamo conosciuto in Italia un vero e proprio dilagare delle articolazioni del sistema dei Licei suddiviso in 396 indirizzi e 52 progetti assistiti. Dopo la Riforma Gelmini della Scuola secondaria di II grado la giungla è stata sfoltita. Noi oggi sappiamo che il percorso del liceo classico può essere ancora una strada nuova, indirizzata allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica, perché favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Il Liceo Classico favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie.
Prima della riforma, la secondaria superiore era ancora quella disegnata da Gentile del 1923. L’interrogativo è dunque: quale senso dare agli studi classici oggi? Come coinvolgere gli studenti? Come motivarli? Come emozionarli? Il rischio è il non percepire il senso ed il valore di una tale formazione. Si tratta da un lato di rinnovare le metodologie didattiche dando spazio alla ricerca, all’apprendimento cooperativo, al confronto, alla scoperta. E in questo il compito dei docenti è particolarmente difficile perché richiede una forte capacità di rinnovarsi, di cambiare, di essere alternativi e creativi. Si tratta d’altra parte riavvicinare la cultura, quella vera, alla vita, farne cogliere il senso, il valore, l’utilità. Dare significato ai saperi della cultura classica.
Non è più il tempo di esercizi di passiva e sterile traduzione o quant’altro. I testi classici vanno letti, tradotti, conosciuti soprattutto per coglierne i significati, i valori che sottendono e che mantengono ancor oggi tutta la loro validità. Se non si riesce a cogliere e a far cogliere la sostanza delle culture latina e greca è tempo perso. E’ la ricchezza dei contenuti, è la grandezza e la profondità culturale che danno senso, valore e attualità a queste lingue millenarie.
Chi le acquisisce attraverso quell’esercizio complesso di scomposizione, analisi, sintesi, interpretazione che la traduzione dei testi antichi richiede, non solo sviluppa, attraverso l’attivazione di nuove sinapsi neuronali, eccezionali capacità logiche, ma soprattutto sui avvicina ad un mondo fantastico, straordinario per profondità, per vissuti, per orizzonti. Roma e Atene hanno un fascino, una capacità di sedurre, di avvincere. Lo hanno avuto in passato e lo debbono avere ancor più oggi perché l’uomo di oggi, che vive in una società complessa, difficile, seducente, ha ancor più bisogno di strumenti per capire.
Questo seminario allarga e precisa il tema del Convegno internazionale promosso dieci anni fa a Sassari dal Dipartimento di scienze umanistiche e dell’Antichità, dalla Facoltà di Lettere e dall’IRRE e per loro dal prof. Luciano Cicu: Quale futuro per gli studi classici in Europa ? Mi è stato chiesto di presentare oggi gli atti di quell’incontro pubblicati nel 2008 col patrocinio della Fédération Internationale des Etudes Classiques,: un’opera che rappresenta uno straordinario punto di partenza per i discorsi di oggi, che vogliono incentrarsi sulle ragioni di coloro che difendono l’esistenza del liceo classico, sostengono l’insegnamento del greco, del latino, della storia antica, dell’archeologia, proprio di fronte alla Riforma Gelmini, che ha causato certamente una riduzione di organico e di risorse. La legge 240 del 30 dicembre 2010 ha invece colpito più pesantemente le Università. Una bomba che è stata gettata dentro gli Atenei e che sta provocando non solo il caos ma addirittura lo scardinamento della struttura universitaria, la scomparsa delle Facoltà e dei Dipartimenti. Sono certo che la riforma scolastica non avrà analoghi effetti nei Licei.
Il Liceo De Castro, così come l’Azuni a Sassari e il Dettori a Cagliari hanno rappresentato e ancor più possono rappresentare una punta di eccellenza per l’istruzione in una Sardegna che ha sempre di più necessità di porre al centro delle politiche sociali la conoscenza come bene comune e che deve realizzare infrastrutture della cultura in tutto il territorio regionale.
Intanto, vorrei subito dire che è falso che gli autori classici guardino sempre al passato e non al futuro: nel mio programma elettorale come Rettore ho adottato un motto preso dalle Questioni Naturali di Seneca:
Multa venientis aevi populus ignota nobis sciet;
multa saeculis tunc futuris,
cum memoria nostra exoleverit, reservantur:
pusilla res mundus est, nisi in illo quod quaerat omnis mundus habeat.
Molte cose che noi ignoriamo saranno conosciute dalla generazione futura;
molte cose sono riservate a generazioni ancora più lontane nel tempo,
quando di noi anche il ricordo sarà svanito:
il mondo sarebbe una ben piccola cosa se l’umanità non vi trovasse materia per fare ricerche.
Seneca, Questioni naturali, VII,30,5
Oggi queste frasi illuminanti, tutte proiettate verso il futuro, compaiono nell’Atrio della nostra Università di Sassari che compie i suoi 450 anni, ma che vuole guardare davanti a sé verso un orizzonte più largo di impegni e non verso il passato, scoprendo la vitalità della cultura classica e l’importanza della ricerca scientifica fatta di curiosità, interessi, passioni che debbono motivare ed animare la vita di tutti i giorni dei nostri studiosi, dei nostri insegnanti, dei nostri studenti.
Forse una delle cause dell’attuale senso di depressione e di sconfitta che si può respirare in molti ambienti, spero non in questa sede, è legata appunto all’affievolirsi di una passione e di un intesse innanzi tutto da parte dei docenti.
Scrive Tuomo Pekkanen dell’Università di Helsinki che la colpa è spesso dei latinisti stessi (e dei grecisti) che non si apprezzano: un insegnante di latino con cui attacchiamo discorso in genere inizia a lamentarsi delle proprie condizioni: gli allievi sono pochi, non hanno voglia di studiare ecc.
E’ anche lui il primo a propagare l’idea che il latino appartiene al passato, non alla vita moderna, e che le classi di latino stanno diventando sempre più rare. Così parlano alcuni nostri professori, anche se insegnano la lingua madre della cultura occidentale di cui dovrebbero essere fieri. Sono i latinisti stessi che, parlando male del proprio mestiere, sostengono il mito della lingua morta per quella che nel medioevo era la regina linguarum.
Certo, i fatti sono fatti e il nostro Paese ha conosciuto un progressivo smantellamento della cultura classica, partendo dal 1962 e della cancellazione del latino dalla scuola media unificata, lungo il faticoso passaggio da una scuola elitaria come era con la riforma Gentile verso una scuola democratica, che mirasse alla costruzione di una democrazia reale nel nostro paese. Se le intenzioni erano quelle di evitare discriminazioni, poiché il latino appariva come una materia “difficile” che richiedeva il ricorso a lezioni private accessibili solo per i più ricchi, il risultato fu quello di concentrare al ginnasio l’apprendimento in contemporanea di due lingue ardue come il Latino e soprattutto il Greco.
Un’altra tappa è segnata nel 1986 dal tentativo di cancellare la storia antica dai licei. Ricordo che al IV Convegno internazionale di studi su L’Africa Romana svoltosi a Sassari noi partecipanti inviammo al Ministro della Pubblica Istruzione un telegramma con l’espressione dell’unanime preoccupazione di fronte alle notizie di eliminazione dello studio approfondito della storia greca e romana dalle prime classi della scuola media superiore, un provvedimento che pensavamo potesse abbassare la qualità dell’insegnamento. In quella occasione avevamo sottolineato come la storia romana sia principium della nostra storia e della nostra cultura e base di un’apertura universalistica sempre più attuale. Chiudendo quell’incontro, il collega Sandro Schipani aveva ricordato che in Italia opera una facoltà umanistica nella quale la storia antica non esiste, la facoltà di Scienze politiche, e aveva sollecitato la solidarietà dei colleghi stranieri di fronte alla cancellazione della storia antica dai programmi ministeriali delle IV e V ginnasio: un episodio grave, marginale se si vuole, ma grave, e che certamente si ripropone negli anni successivi con i nuovi programmi fino ai nostri giorni.
Voglio ricordare le parole di Gaio, fatte proprie da Giustiniano nel Digesto: facturus legum vetustarum interpretationem necessario populi romani ius ab urbis initiis repetendum existimavi, non quia velim verbosos commentarios facere, sed quod in omnibus rebus animadverto id pefectum esse quod ex omiunbus suis partibus constaret et certe cuiusque rei potissima pars principium est.
Occorre richiamare fortissimamente i giovani di tutti i Paesi europei a non trascurare il proprio principium, un principium che non è nazionale ma che immerge in particolare il nostro paese in una prospettiva universale e globale, che tiene conto degli intrecci della storia e che ci orienta verso un’apertura sempre più ampia e solidale.
Sono seguite tante riforme, dalla Moratti alla Gelmini, fino ad arrivare al governo tecnico ed a Francesco Profumo: a partire dall’attuazione della riforma degli ordinamenti didattici, sono stati inferti danni irreparabili alla cultura ed alla scuola, come all’economia, alla giustizia, alla sanità. Abbiamo vissuto anche nell’università una vera e propria frammentazione disciplinare, una parcellizzazione dell’insegnamento, che ci vede ancora, come antichisti, sulla difensiva a tentare di contenere il danno, di mantenere le posizioni, costantemente erose e insidiate da discipline scientifico sperimentali divenute sempre più aggressive.
In questi due giorni noi non faremo verbosos commentarios, ma entreremo con il nostro entusiasmo e con le nostre storie sul tema del futuro del liceo classico che un ministro del passato sosteneva aver corrotto i giovani italiani. Discuteremo insieme la situazione delle formazione superiore e dell’alta formazione, la formazione di eccellenza, in particolare in Italia. Senza dimenticare che però ormai ci collochiamo in un’Europa che deve armonizzare i sistemi scolastici e confrontare gli impianti educativi, che discute sul valore legale del titolo di studio, che affronta il tema dell’integrazione degli immigrati, del multiculturalismo in rapporto con le identità locali.
Credo che la forza dell’antica Roma risiedesse nella prospettiva sovrannazionale, nell’universalismo, nel superamento delle divisioni nazionali. Roma ha potuto interessare e coinvolgere le élites di molte nazioni al suo ideale. Analogo giudizio deve esser dato al mondo ellenistico erede di Alessandro il Grande. La grande chance per l’attuale élite intellettuale e quindi anche per gli studiosi che si dedicano alle eredità dei Romani e dei Greci, per gli insegnanti di Latino e Greco, consiste in questo: nel fatto che attraverso i loro comuni ideali – ideali scientifici innanzi tutto – si contribuisca all’accordo tra le nazioni.
Per Kurt Smolak dell’università di Vienna la vocazione degli studi classici del futuro sarà quella di contribuire ad un processo di acculturazione globale, di favorire il desiderio di ciascuno di noi di integrarsi in una realtà culturale complessa di rango mondiale, respingendo l’idea di appartenere ad una certa razza o di disprezzare culture di conio diverso: occorre lavorare per formare questa coscienza e mettere a disposizione le premesse necessarie per poter realizzare un tale atteggiamento.
Vittorio Citti riconosce che ci siamo finalmente liberati dal pregiudizio imperialista del primato della nostra cultura ma sostiene che è necessario un fondamento su cui dialogare con intellettuali di altre tradizioni europee; e ciò soprattutto in un momento in cui la diffusione dei mass media e le esigenze della produzione e della distribuzione dei beni tendono alla massificazione dei modi di pensare e di comunicare, in una parola rischiano di mettere in crisi la nostra stessa identità culturale.
Gli studi sull’antichità greca e romana stanno indubbiamente attraversando oggi in Italia un momento di estremo interesse e di importanza sul piano scientifico, se si considera sia la qualità dei risultati ottenuti sia anche il credito di cui la nostra ricerca gode all’estero: per fare solo una lista nei nostri maestri, miei e credo di Guido Tendas, ad esempio, penso a Bruno Luiselli, Enzo Degani, Mario Torelli, Fausto Zevi, oltre che Piero Meloni, Giovanni Lilliu, ecc.
Eppure gli studi antichistici si trovano proprio oggi in un momento di altissimo rischio sul piano didattico nell’Università come nella scuola media superiore. Come ben si comprende ricerca scientifica e attività didattica non sono per nulla entità indipendenti: la possibilità tutt’altro che remota che la seconda entri in crisi totale in tempi molto brevi implica la conseguenza, certamente possibile e allo stato delle cose forse anche probabile, che il nostro paese perda altrettanto rapidamente la posizione di primato che si è indubbiamente guadagnata sul piano della ricerca, e si riduca nella depressione in cui si trovano altre nazioni europee, che pure vantano grandi tradizioni scientifiche nelle scienze dell’antichità.
Gli studi classici hanno reali ragioni per continuare ad essere praticati nella moderna civiltà tecnologica e di mercato, a condizione che si guardi al mondo classico come radice costitutiva della civiltà del mondo di oggi e di domani, si riconoscano i principi di democrazia, religione, solidarietà e tolleranza che sono espressione del mondo antico ma sopratutto alla base del processo costitutivo di quelle nazioni che hanno dato vita all’Europa.
Senza gli studi classici il mondo sarebbe peggiore: noi esaltiamo costantemente la civiltà moderna tecnologica, ma non ci accorgiamo che lo facciamo solo in rapporto con il mondo antico. Perché, scrive Paolo Mastandrea, non si intende nessuna di queste tre parole senza la cultura classica. Non si intende moderna senza un rapporto con l’antico; non si intende civiltà, poiché civiltà viene da civis e da civitas e quindi rinvia proprio a quella dimensione urbana nella quale cultura classica, ateniese o romana ha dato il meglio di sé. Non si intende tecnologica senza la tekne attribuita al mitico Efaistos, l’artefice divino, il dio gettato dal padre Zeus dentro il vulcano Mosiclo nell’isola di Lemno, e perciò zoppo e allevato dalle ninfe, che avrebbe insegnato i misteri della sua arte ai Sintii, ai quali l’eroe Prometeo avrebbe rapito il fuoco per gli uomini. E senza suo figlio Talos, che per Zenobio era un automa di bronzo che difendeva la Sardegna nuragica; infaticabile guardiano, secondo il lessico della Suida, l’automa alato Talos , il figlio di Efesto, impediva agli stranieri ed in particolare ai Sardi di penetrare nell’isola di Creta, bruciandoli vivi e causando quella smorfia definita Riso Sardonio, già raccontata tre mila anni fa da Omero pagando della smorfia di Ulisse minaccioso verso i Proci: e Ulisse è il capostipite dell’uomo, legato al legno della barca, tra i canti delle sirene, paragonato all’uomo che si attacca al legno della salvezza. E sappiamo che la letteratura latina nasce con un atto di fondazione che è la traduzione dell’Odissea da parte di Livio Andronico.
Se abbiamo un futuro – e noi vogliamo avere un futuro, vogliamo superare ogni domanda retorica e affermare un futuro per il liceo classico – il futuro sta proprio nel far intendere ai giovani il loro rapporto con il passato e quindi saper leggere il loro presente in relazione al passato e il passato in relazione al presente, ricorrendo all’intertestualità e riscoprendo il continuum della nuova Europa con il mondo antico: ben prima di Cristo, era in uso l’espressione non di solo pane vive l’uomo. E il pane per noi è la civiltà tecnologica, ma non basta, ci occorre altro, ossia la cultura occidentale, umanistica, basata sull’antichità greco-latina e poi sul Cristianesimo.
Mons. Pietro Meloni ha scritto che Ludus era la scuola nell’antichità e Ludus deve diventare la scuola del domani, che non deve essere soltanto un dovere: dobbiamo riscoprire il piacere che proviene dalla lettura di un testo in lingua originale, il piacere della traduzione, il piacere di un confronto, il piacere di una scoperta. Dobbiamo cogliere un aspetto ludico della ricerca, che deve coinvolgere e appassionare, perché siamo stufi di magistri plagosi, come quelli che insegnavano il greco ad Agostino.
Chi mi conosce sa che sono convinto che gli studi classici possono rappresentare un punto di riferimento oltre che per i paesi europei paradossalmente anche per il Maghreb e per altre aree del mondo, a iniziare dall’America latina.
Dirigo dal 1994 gli scavi di Uchi Msius in Tunisia ai quali hanno finora partecipato oltre 500 studenti italiani e tunisini dell’Istituto superiore dei mestieri del patrimonio, interessati a condividere con noi un’esperienza di formazione che credo resterà indimenticabile.
A me sembra che troppo poco facciamo per rivitalizzare la cultura classica attraverso l’incontro tra le due rive del Mediterraneo e tra paesi diversi, soprattutto dopo l’esperienza esaltante della primavera araba. Non sempre abbiamo colto l’interesse, il rsspetto, l’ammnirazione che anche al di là del mare esistono per la nostra tradizione.
Sono trascorsi ormai oltre 30 anni dallo svolgimento dello straordinario congresso Africa et Roma, promosso a Dakar dall’Istituto di studi romani sotto gli auspici del Senegalensium Rei Publicae Princeps, Leopold Sedar Sengor, i cui atti sono stati pubblicati nel 1979 nel volume Acta omnium gentium ac nationum coventus latinitatis litteris linguaeque favendis, che ho sfogliato proprio in questi giorni. Scorrendo queste pagine ho sorriso alla lettura di alcuni testi molto ingenui, scritti da colleghi africani, come quelli a proposito dell’insegnamento della lingua latina nelle scuole dello Zaire o del Ruanda, del Burundi, o di quel maestro elementare che notava come maxime placere adulescentulis narrationes sallustianas belli iugurtini et orationes in Catlinam; placent quoque saturae oratianae.
In quell’occasione, il Rettore dell’Academia Argentoatensis di Strasburgo rivolgendosi al Presidente Sengor si augurava: maneant sempere vincula illa inter Africam et Europam quibus nos eadem communitate eademque inter nos caritate coniunctos nosmet sensimus.
Noi viviamo un tempo di conflitto tra culture, tra popoli, tra paesi, anche per la nostra incapacità di comprendere gli altri, di sviluppare una pacifica vita in comune, di mettere da parte egoismi ed interessi, di rifiutare integralismi e intolleranze, anche da parte nostra. Il mondo antico di fornisce gli strumenti per un tempo nuovo fondato sulla tolleranza e il rispetto per gli altri, sul pluralismo e il rispetto delle diversità.
La cultura classica è una componente fondamentale della cultura europea ma non solo. Perché lo studio delle letterature antiche, perché la Storia? La necessità di leggere i testi nella loro lingua originale, perché la lingua non è tanto esercizio logico ma strumento di comprensione storica dei testi. La volontà di usare i mezzi elettronici oggi a disposizione, strumento al servizio della filologia, dell’epigrafia, della numismatica, ad esempio, è oggi positivamente una forma di democratizzazione della cultura contemporanea, e poi l’informatica, ma anche la televisione, il cinema, i power point, altri strumenti.
Dal convegno di Sassari di dieci anni fa emerge il bilancio di una progressiva emarginazione della cultura classica in alcuni paesi europei, l’assenza di studenti in alcune facoltà universitarie come in Germania, in Svizzera, in Austria, in Inghilterra; la dicotomia che noi viviamo tutti i giorni tra un interesse crescente della gente per l’antichità classica, anche per le sue manifestazioni artistiche o archeologiche, per il patrimonio – le grandi mostre, le riviste di archeologia – e poi l’interesse specialistico per gli studi universitari di antichità classica che rischia di diventare un fatto di nicchia o di élite. La separazione delle scienze storiche o archeologiche da quelle filologiche in alcuni paesi, come in Spagna; alcune volte la poca duttilità dei filologi ad adattarsi a forme di insegnamento meno specifiche; e poi i problemi della Russia, i temi di un disaccordo che riguarda il problema della identità scientifica da parte dei filologi, specie quelli ancorati ad un modello tedesco mommsenino di filologia; l’uso del Latino come lingua di comunicazione, un tema evocato da Tuomo Pekkanen, un esercizio elitario, inutile, oppure mezzo per rinvigorire lo studio del latino ? Si può parlare infine di valori eterni nei miti, nei classici antichi ? Non si falsa in questo modo la necessità della loro comprensione storica, della loro collocazione nel tempo e nello spazio ? E poi i quesiti posti da Bruno Luiselli a proposito della moderna civiltà tecnologica, che è anche una civiltà di mercato ? I problemi dell’obslesceza degli strumenti, dei metodi, delle forme dell’insegnamento delle lingue antiche; il problema del linguaggio; il senso di una cultura classica con il proprio patrimonio di valori, come sistema unitario integrale.
Nel dibattito Paolo Fedeli ha ricordato processi formativi che si sviluppano nei licei, in particolare nel Liceo classico; l’esigenza che la cultura classica si confronti con la cultura scientifica, con la linguistica, con l’informatica. Una scuola classica dunque del futuro, più adeguata ai tempi, non relegata in un ghetto per pochi privilegiati.
E poi Ferruccio Bertini che ha ricordato anche gli errori che noi stessi abbiamo computo, il fastidio causato agli allievi, la noia, l’incapacità di molti di noi di suscitare interesse e curiosità, la stanchezza di molti docenti, con la precisazione che le cose più belle sono quelle più faticose.
Il tema dell’aggiornamento dei docenti, all’indomani delle Scuole di specializzazione per insegnanti, oggi verso il Tirocinio Formativo Attivo e le altre forme di abilitazione all’insegnamento, un tema che ci vede impegnati da anni con difficoltà ma anche con soddisfazione. E poi il dibattito, le polemiche, il tema della traduzione dall’italiano al latino: una polemica che mi consente di ricordare come mia madre traducesse in realtà dal Greco al Latino.
Al principio del terzo millennio la cultura antica non cessa di stupirci per il suo perenne senso di sorgente della conoscenza.
L’Università di Sassari vorrebbe proporsi come osservatorio privilegiato sulla cultura classica, individuando il suo valore formativo e direi educativo, che non può essere basato solo sul riconoscimento di una complessità della grammatica o della sintassi, ma che è in relazione con il nostro essere uomini oggi. Non solo dunque in quei paesi la cui formazione linguistica o culturale è più direttamente connessa alla cultura classica, ma anche e forse soprattutto gli altri paesi di tradizione anglosassone o slava o islamica; e in primis il valore della paideia greca e il valore dell’humanitas latina, che ci stringe indissolubilmente a questo complesso patrimonio di cultura classica, che non si erge in un iperuranio etnocentrico,. Ma si svolge attraverso le nazioni e i popoli nel corso della storia, e che ora si confronta con i progressi dell’informatica, delle scienze naturali, della medicina, della stessa archeologia, dei nuovi metodi di insegnamento.
Ammirare i segni anche minimi della cultura classica (faccio l’esempio delle legende monetali greche e latine circo antri al di là dei confini dell’impero) : tutto ciò ci dà il segno di una oikoumene dove i popoli di diversa etnia, cultura, religione, percepirono i barlumi della civiltà classica.
Alla faccia di Bin Laden, la civiltà islamica si è innestata mirabilmente nella civiltà classica, sia sul piano della trasmissione libraria, sia sul piano, più propriamente, della trasmissione e interazione culturale; e tutto ciò costituisce una profonda lezione per i nostri giorni, che conoscono una spaventosa accelerazione, un nuovo modo di provincializzarsi, una provincializzazione non più dello spazio ma del tempo.
Dunque, cultura classica come libertà, diritto, giustizia, solidarietà, fides, ragione, poesia, arte, patrimonio degli uomini, faticoso a raggiungersi, se volete, ktema es aiei, secondo il monito di Tucidide, non oggetto di antiquariato e di nostalgica erudizione.
Nell’età della globalizzazione, dove troppo spesso emerge il demone dell’homo oeconomicus, del mercato, la lezione antica e moderna della cultura classica ci insegna a riconoscerci nei valori fondati sull’humanitas, di quel nihil humani a me alienum puto. Ancora nel terzo millennio, la lezione della cultura classica sgorga dalla fonte Castalia e ripete il motto delfico del conosci te stesso.
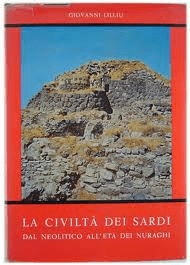 Ho iniziato a leggere La civiltà dei Sardi di Giovanni Lilliu quasi cinquanta anni fa, all’inizio degli anni sessanta, quando avevo ancora i calzoni corti, a Bosa: ricordo un volume rosso, rilegato con cura, gonfio a soffietto con i ritagli degli articoli pubblicati da Lilliu su “L’Unione Sarda”, che mio padre aveva iniziato a raccogliere negli anni e che riguardavano i temi più diversi.
Ho iniziato a leggere La civiltà dei Sardi di Giovanni Lilliu quasi cinquanta anni fa, all’inizio degli anni sessanta, quando avevo ancora i calzoni corti, a Bosa: ricordo un volume rosso, rilegato con cura, gonfio a soffietto con i ritagli degli articoli pubblicati da Lilliu su “L’Unione Sarda”, che mio padre aveva iniziato a raccogliere negli anni e che riguardavano i temi più diversi.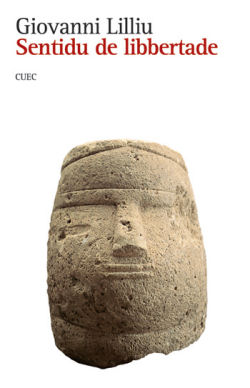 E allora la lingua sarda, innanzi tutto, che avrebbe voluto insegnata nelle scuole ed utilizzata liberamente nelle sedi ufficiali, in modo che si affermasse il biliguismo. Lilliu aveva seguito costantemente il dibattito in Consiglio Regionale sul problema, fino alla legge regionale a tutela della lingua, della cultura e della civiltà del popolo sardo.
E allora la lingua sarda, innanzi tutto, che avrebbe voluto insegnata nelle scuole ed utilizzata liberamente nelle sedi ufficiali, in modo che si affermasse il biliguismo. Lilliu aveva seguito costantemente il dibattito in Consiglio Regionale sul problema, fino alla legge regionale a tutela della lingua, della cultura e della civiltà del popolo sardo. La storia della Sardegna era fondata dunque su quella che Lilliu chiamava una costante residenziale e libertaria dei Sardi, che illuminava il fondo dell’identità di un popolo perseguitato ed oppresso ma non vinto. A quest’anima profonda di una nazione vietata e compressa, di una nazione perduta o proibita (come non pensare a Camillo Bellieni ?) rimanderebbe la cultura alternativa popolare sarda, non quella delle città, ma quella dei paesi dell’interno: anche la nomenclatura ed i valori erano allora ribaltati, se barbarica e selvaggia erano due categorie positive e contrastive della diversità del processo della storia del mondo, contro l’integrazione e la monocultura imposta dall’esterno.
La storia della Sardegna era fondata dunque su quella che Lilliu chiamava una costante residenziale e libertaria dei Sardi, che illuminava il fondo dell’identità di un popolo perseguitato ed oppresso ma non vinto. A quest’anima profonda di una nazione vietata e compressa, di una nazione perduta o proibita (come non pensare a Camillo Bellieni ?) rimanderebbe la cultura alternativa popolare sarda, non quella delle città, ma quella dei paesi dell’interno: anche la nomenclatura ed i valori erano allora ribaltati, se barbarica e selvaggia erano due categorie positive e contrastive della diversità del processo della storia del mondo, contro l’integrazione e la monocultura imposta dall’esterno. Quando il Presidente Soru gli conferì cinque anni fa l’onorificenza del Sardus Pater, Lilliu aveva rinnovato il suo appello contro ogni forma di centralismo, per il trasferimento di competenze in materia di beni culturali dallo Stato alla Regione, perché riteneva che il patrimonio culturale potesse essere un insieme di risorse umane e ambientali capaci di produrre una domanda sociale. E il patrimonio archeologico gli sembrava un insieme di materiali per l’identità della terra e del popolo sardo.
Quando il Presidente Soru gli conferì cinque anni fa l’onorificenza del Sardus Pater, Lilliu aveva rinnovato il suo appello contro ogni forma di centralismo, per il trasferimento di competenze in materia di beni culturali dallo Stato alla Regione, perché riteneva che il patrimonio culturale potesse essere un insieme di risorse umane e ambientali capaci di produrre una domanda sociale. E il patrimonio archeologico gli sembrava un insieme di materiali per l’identità della terra e del popolo sardo. ho l’onore di aprire a nome dell’Università di Sassari questo XXXII Seminario sulla cooperazione mediterranea promosso dall’Istituto di studi e programmi per il Mediterraneo e dal nostro Ateneo, nell’ambito delle celebrazioni per i 450 anni, in collaborazione con l’Unità di ricerca Giorgio la Pira del CNR-Università di Roma La Sapienza.
ho l’onore di aprire a nome dell’Università di Sassari questo XXXII Seminario sulla cooperazione mediterranea promosso dall’Istituto di studi e programmi per il Mediterraneo e dal nostro Ateneo, nell’ambito delle celebrazioni per i 450 anni, in collaborazione con l’Unità di ricerca Giorgio la Pira del CNR-Università di Roma La Sapienza.