Utilisation de l’eau en Afrique du Nord dans le passé
Attilio Mastino – Antonio Ibba*
Djerba, 24 mai 2012
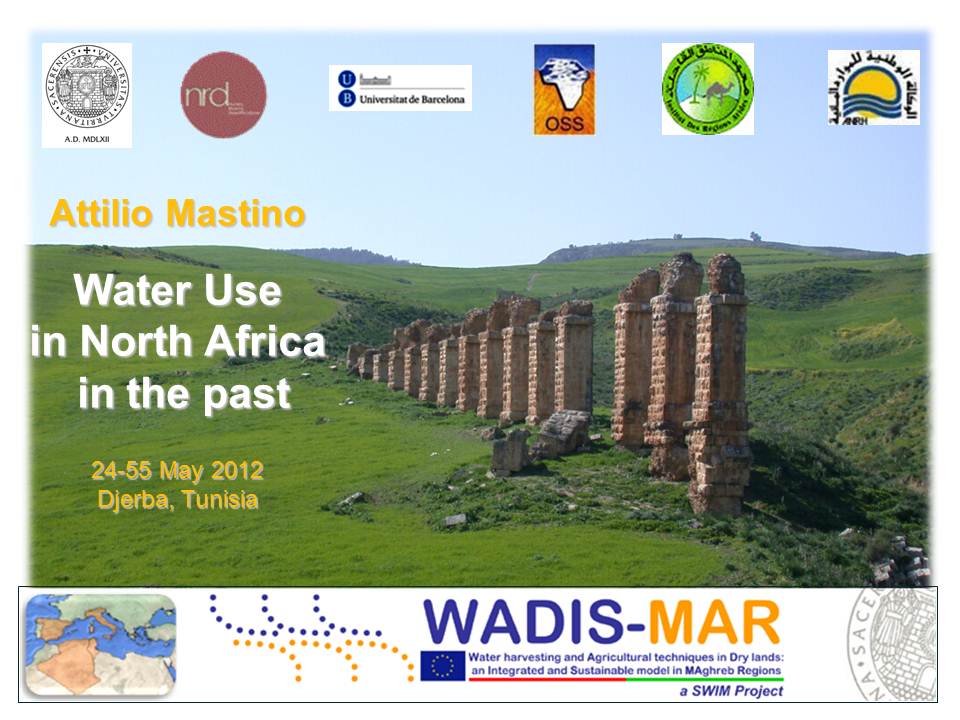
{phocadownload view=file|id=79|text=Télécharger le rapport…|target=b}
WADIS-MAR, Water harvesting and Agricultural techniques in Dry lands: an Integrated and Sustainable model in Maghreb Regions [Collecte des eaux et techniques agricoles dans les régions arides : un modèle intégré et durable dans les régions du Maghreb]
0. Je suis très honoré de représenter l’Université de Sassari et de revenir en Tunisie à l’occasion de cette rencontre sur la rareté des ressources en eau, sur la gestion de l’eau et les processus de désertification, rencontre promue également par le NRD-Nucleo ricerca desertificazione [Unité de recherche sur la désertification] de l’Université di Sassari. Je suis particulièrement ému de revenir en Tunisie où me reviennent en mémoire tant d’occasions vécues et tant d’espoirs partagés, à Djerba également, lors du XVe Congrès sur L’Afrique Romaine. Mais, parmi tous ces souvenirs, je voudrais surtout évoquer ceux qui sont étroitement liés à nos recherches archéologiques à Dougga et Téboursouk à Henchir Douamis, la colline des souterrains, dont le nom rappelle la présence d’un grand nombre de citernes destinées à la récolte de l’eau au point d’arrivée d’un important aqueduc. J’espère que vous me pardonnerez si, durant un court moment, je vous convie à remonter le temps pour aller à la découverte des lieux qui gardent de nombreuses traces des techniques utilisées dans l’Antiquité classique pour la collecte de l’eau, précieuse ressource pour la survie dans les zones internes du Maghreb.
1. A la fin de l’époque coloniale, comparant la situation de l’Afrique méditerranéenne française avec celle de la France, Jean Despois, dans son ouvrage, désormais rangé au nombre des classiques, intitulé L’Afrique du Nord et publié en 1963[1], résumait en un mot, à savoir le terme “inégalité”, l’aspect essentiel du climat nord-africain et mettait en évidence notamment la distribution irrégulière des précipitations en hiver, la rareté des pluies au printemps, les fortes variations pluviométriques d’une année sur l’autre, la sécheresse qui dure de 4 à 5 mois dans les régions dominées par la steppe.
« 300 millimètres de pluie bien réparties, affirmait Despois, suffisent à assurer une assez bonne récolte de céréales, alors que 400 ou 500 mal distribués donnent de médiocres résultats. Les pluies torrentielles sont en grande partie perdues pour l’agriculture, surtout si elles tombent sur un sol déjà saturé…. Les pluies torrentielles amènent des désastres par les ravinements et les inondations qu’elles provoquent, en particulier quand elles ont une violence inaccoutumée. Inversement on assiste souvent à des longs mois secs ou qui n’ont que des pluies faibles suivies de vents violents. Des pluies d’automne trop tardives ou rares empêchent ou gênent les labours et les semailles ; l’insuffisance des pluies de printemps compromet non seulement la récolte des céréales au point de la rendre nulle dans certains régions, mais aussi celles du raisin et des olives » [2].
Des averses intenses mais brèves empêchent l’eau de pénétrer en profondeur dans le terrain, dénudent violemment les surfaces en érodant les couches fertiles ; l’évaporation est très forte, notamment dans les zones internes, caractérisées par un ciel limpide et par des vents forts et chauds. Durant l’hiver, toutefois, une forte humidité dans des zones comme le sud-ouest marocain et la Tunisie orientale, en particulier dans la région de Gabès, permet la mise en place de différentes cultures. Selon ce chercheur, l’existence de cours d’eau temporaires (oueds, wadis), très rarement alimentés par les neiges et dépendant dans la plupart des cas de précipitations irrégulières, abondantes uniquement en hiver et quasiment inexistantes en été ‒ et donc peu efficaces dans la lutte contre la sécheresse et pour l’agriculture ‒ serait l’une des conséquences directes du climat[3].
Se basant sur une approche déterministe aujourd’hui inacceptable, Despois concluait que le climat avait des conséquences dévastatrices et irréversibles sur l’économie locale, sur l’organisation de la société berbère, voire même sur l’humeur des pauvres fellahs impuissants face à une nature cruelle et donc quasiment justifiés dans leur apparente indolence. Si cette lecture, fille de son temps, a désormais perdu l’essentiel de son crédit dans la communauté scientifique, force est de constater que les problèmes climatiques mis en évidence par ce chercheur caractérisent le Maghreb depuis la plus lointaine Antiquité : l’homme a tenté, au fil du temps, de remédier à ces difficultés objectives avec des solutions que les différentes disciplines historiques (en particulier l’archéologie et l’épigraphie) ont mises en évidence et qui, en partie, peuvent ou pourraient être appliquées aujourd’hui encore.
2. En effet, le problème de l’eau était fort bien connu dans l’Afrique romaine entre les colonnes d’Hercule sur l’Océan et les Arae Philenorum en Libye, aux confins entre la Tripolitaine et la Cyrénaïque, soit à cause de la force destructrice des crues subites[4], soit grâce à la force vivifiante de celles-ci qui favorise la naissance des établissements humains et les activités productives.
Nous pouvons rappeler quelques témoignages épigraphiques. A Zireg, au sud des Monts du Hodna, sous le principat de Septime Sévère, des agri, pascua, fontes sont octroyés aux colons établis dans une région délicate de la frontière, une zone militaire et de passage des tribus : l’empereur africain est convaincu que l’eau est un élément indispensable pour la productivité et la mise en valeur de ces terres et il veut empêcher que ce bien ne soit réservé qu’à un nombre restreint de personnes favorisées par le sort[5]. Au contraire, voulant probablement frapper les domini de Lepcis Magna, qu’ils détestaient au plus haut point et qui les exploitaient comme ouvriers agricoles, les Berbères détruisirent, en 238, l’aqueduc qui permettait d’irriguer les terres situées au sud-est de la colonie, stratégie souvent utilisée au IVe siècle par les Austuriani[6].
Les installations d’adduction d’eau constituent le corollaire indispensable de la richesse d’un domaine. A Biha Bilta, dans la région du Haut Tell tunisien, tel propriétaire diligent se vante d’avoir construit un puits qui, à l’époque d’Aurélien, lui a permis d’améliorer son fundus et de créer de nouvelles richesses[7]. Ad Henchir El-Left, Florentius, procureur du patrimoine impérial dans la Proconsulaire, entre les années 321 et 324, dédie à Neptune un long canal qui du bassin d’adduction (ninfio!) amenait l’eau sur les praedia de Constantin[8]; à Albulae, Terentius Cutteus réalise sur ses terres avec sa femme et ses enfants un aquagium, un canal d’écoulement de toute évidence indispensable pour améliorer l’efficacité de sa ferme[9].
La nécessité quotidienne en eau est soulignée par les nombreuses dédicaces faites au genius qui protège la source (par exemple, les sources de l’Ampsaga, l’Oued Rhumel, la Ferme du Caïd à Batna, ou à Hammam Sayala) ou à Neptunus, le dieu de la mer mais plus généralement des eaux, raison pour laquelle il est vénéré dans des établissements humains éloignés des côtes, comme par exemple dans le village de Tituli entre Haïdra et Le Kef, à Gafsa, à Lambaesis, probablement dans les montagnes de l’Ouarsenis en Algérie occidentale[10].
Les inscriptions datant des IIe-IVe siècles, en Libye et en Algérie, témoignent en général de l’attention particulière que suscitent l’eau, les sources et les installations d’adduction ou de distribution de l’eau : thermae, aquaeducti, fontes, putea, cisternae sont des termes récurrents dans l’épigraphie africaine (en vérité, quantitativement limitée à une quarantaine de textes traitant ce sujet). Autant d’installations essentielles pour le bon déroulement de la vie civile, qui permettent de distinguer un centre urbain d’un village, qui accroissent le prestige d’une agglomération et le bien-être de ses habitants, qui reflètent l’adhésion de la population à des modèles de vie romains. Ce sont des ouvrages qui ont un fort impact sur la collectivité ; c’est pourquoi ils sont réalisés soit par l’empereur ou par ses fonctionnaires (16 cas), soit pecunia publica par des magistrats locaux (14 exemples), soit enfin grâce à la contribution d’évergètes aisés en quête de consensus politique et électoral auprès de la communauté[11]: à Sabratha, Flavius Tullus aquam privatam induxit, construisit 12 bassins et versa deux cent mille sesterces pour l’entretien de l’installation offerte à la ville[12]. Nous reviendrons sur ces aspects mais il est intéressant, dès à présent, d’observer que les installations exploitaient une ou plusieurs sources situées dans les proches environs des établissements humains : en général, dans la Tunisie actuelle, les aqueducs les plus longs ne dépassent jamais les 10 kilomètres (a milliario septimo rappelle un texte de Thugga) et dans la plupart des cas ils oscillent entre 4 et 5 kilomètres[13]. Ces structures avaient une grande importance stratégique, d’où l’intervention fréquente et non fortuite en Numidie de militaires mobilisés soit comme force de travail soit comme support technique ; en Libye et dans les oasis du prédésert, ce sont les esclaves qui étaient utilisés pour construire les canaux souterrains.
3. La documentation archéologique dont nous disposons est beaucoup plus vaste mais nettement moins homogène car ce secteur de la recherche a été partiellement négligé dans le passé. Au Maroc, les informations se concentrent sur les centres urbains dont certains, parmi lesquels Volubilis, ont été explorés de façon très ramifiée, alors que les sites ruraux n’ont fait l’objet que d’investigations limitées ; on ignore souvent à travers quel type de canalisations l’eau arrivait dans les centres urbains. Les prospections franco-marocaines dans le bassin de l’oued Sebou prouveraient d’ailleurs que pour les vici de la région, implantés généralement près des oueds, aucun ouvrage hydraulique pour la récolte ou la distribution de l’eau n’a été réalisé, mis à part quelques ouvrages à proximité des côtes (citernes, bassins, canaux) liés aux différents processus de préparation et de conservation du poisson, destiné en grande partie à l’exportation[14].
En Algérie, le Service des Antiquités et Stephan Gsell concentrèrent le programme de leurs investigations sur la viabilité de l’époque romaine, socle sur lequel construire le réseau de la viabilité moderne, nécessaire pour le contrôle d’un territoire peu sûr. C’est au colonel Jean Baradez que revient le mérite d’avoir accompli un premier pas en avant ; en effet, recourant à la technique de la photographie aérienne, ce dernier parvint à repérer dans la région située tout près du massif de l’Aurès d’anciennes structures qui servaient à recueillir, à contrôler et à réguler les eaux, sans toutefois réussir à l’époque à en préciser la chronologie exacte. S’inscrivant et opérant dans le même sillage, Jean Birebent se livra, une dizaine d’années plus tard, à un ensemble d’enquêtes de terrain particulièrement approfondies et réalisa une série d’études spécifiques dont on peut toutefois regretter qu’elles ne concernent que les installations de l’Algérie orientale[15].
Par contre, les informations abondent en ce qui concerne la Tunisie, protectorat politiquement tranquille aux yeux du gouvernement français, bien disposé pour cette raison à y investir quelque ressource. Et, en effet, nous savons très bien que la Brigade Topographique tout comme les spécialistes des Antiquités qui parcouraient le pays, prêtaient une attention particulière aux installations hydrauliques, convaincus que ces informations pouvaient être encore utiles au XIXe siècle et se révéler un précieux volant pour l’économie de la nouvelle Tunisie ; une vision des choses qui transparaît encore dans les écrits de Despois et de Gilbert Picard à la moitié du XXe siècle. Toutes ces données furent rassemblées et commentées, dès 1897, par Paul Gauckler dans son Enquête sur les installations hydrauliques romaines en Tunisie. Ces travaux reflètent tous l’idée manifeste que seuls les Romains avaient réussi à exploiter de façon très ramifiée l’énorme potentiel agricole de l’Afrique et que seule la récupération de toutes ces connaissances aurait permis de remédier aux dommages provoqués par les Berbères qui pratiquaient le nomadisme et par les envahisseurs arabes, incapables selon eux de gérer ce patrimoine, voire même responsables de la destruction insensée d’installations indispensables au progrès du pays et à sa prospérité[16].
Les travaux de Gauckler étaient plutôt sommaires en ce qui concerne les installations rurales et négligeaient, à quelques exceptions près, les régions proches du désert et les oasis. Par contre, la recherche a été renforcée durant ces quarante dernières années grâce aux investigations systématiques que Pol Trousset a conduites entre Gafsa, el Djérid et Gabès[17]. Simple filon collatéral dans les enquêtes menées en Libye par les archéologues italiens et anglo-saxons durant la première moitié du XXe siècle, celui-ci a été repris plus récemment par l’équipe anglaise dirigée par Graeme Barker et David Mattingly dans le cadre du projet UNESCO Farming the Desert consacré aux établissements humains en milieu rural de la Tripolitaine[18]. Trousset et Mattingly ont délibérément orienté leurs recherches vers la redécouverte et la mise en valeur du patrimoine culturel, sans perdre de vue les éventuelles retombées pratiques sur l’économie locale ; ils ont attiré l’attention sur les techniques d’adduction des eaux dans la région du pré-désert et ont mis l’accent sur l’existence d’une ligne de continuité entre les mondes préromain, romain, byzantin, aglabide, voire contemporain, obtenant ainsi des résultats extraordinaires qui rendent justice à un monde qui, loin d’être sous-développé, est capable de produire un surplus de biens pour commercer avec les centres urbains de la côte.
Plus récemment encore, la perception au niveau social et politique de certains changements climatiques globaux a remis à l’honneur les études d’hydraulique et a remis au premier plan les solutions hydriques adoptées par les Romains pour fournir en eau les villes et les campagnes. C’est en 2008 que paraissent, à quelques mois près, certaines communications dans les Actes du XVIIe colloque sur L’Afrique Romaine, consacrées aux foggaras et aux citernes de La Malga à Carthage[19] et surtout le répertoire de Massimo Casagrande, qui rassemble toute la bibliographie sur les installations hydriques de la Zeugitania et de la Byzacena ; ce dernier en recense 422 répandues sur 362 sites différents et fournit nombre d’observations intéressantes sur les techniques et les finalités de ces structures[20]. L’année suivante paraissent les Actes du colloque Contrôle et distribution de l’eau dans le Maghreb antique et médiéval qui, malgré leur caractère incomplet (certaines communications présentées à Tunis en 2002 ne sont pas comprises dans le recueil), offrent un panorama vaste et critique des études menées dans toute l’Afrique méditerranéenne sur un arc chronologique qui s’échelonne volontairement de l’époque punique à l’époque aglabide. Rappelons, enfin, les Actes du colloque de Cadix de 2009 Aquam perducendam curavit, publiés dès 2010, colloque consacré en particulier à la situation de la Baetica mais ouvert également à toute confrontation avec d’autres réalités de l’empire romain d’Occident, et notamment deux aperçus sur l’Afrique Proconsulaire et sur la Tingitania.
4. Le temps qui nous est imparti aujourd’hui ne nous permet pas d’entrer dans les détails de cette riche documentation ; aussi nous limiterons-nous à citer quelques exemples parmi les plus importants en mettant l’accent sur la pluralité des solutions face à un certain nombre de problèmes communs.
Les travaux de Trousset entre Gafsa, le Chott El-Djérid, Gabès, El Hamma, Arad, que nous avons évoqués plus haut, ont permis de saisir à quel point les installations hydrauliques ont conditionné la vie agricole et la naissance de sociétés fortement structurées et impliquées dans la gestion de l’eau. Les constructions présentes dans la région sont alimentées par les eaux qui descendent des derniers prolongements du massif du Tell saharien, captées par les aqueducs, ou par les eaux ramenées à la surface au moyen de puits artésiens comme c’est le cas dans le Jérid ou dans le Nefzaoua[21].
Dans la région sud-est, entre les montagnes de Matmata et Dehibat jusqu’au djebel Nefoussa, le relief tuniso-tripolitain constitue une zone intermédiaire entre les Steppes et le Sahara due à la hauteur des montagnes (715 m), à la pluviométrie (200 mm), à la proximité de la Méditerranée. Ici, la population sédentaire pratique l’arboriculture grâce à des méthodes d’irrigation très particulières qui puisent l’eau non pas dans les sources qui sont très rares mais grâce à un système de terrasses ou de digues (jessour) qui permettent de contrôler et de canaliser les eaux des alluvions ou des oueds Merteba, Seradou, El Hamma[22]. Des structures semblables ont été retrouvées en Libye[23], en Tunisie sud-orientale dans la plaine de Augarmi[24], entre Fériana et Kasserine dans la région des Hautes Steppes[25]. Les archéologues les ont très souvent confondues avec les clausurae, barrages linéaires situés le long des pistes sur lesquelles se déplaçaient jadis les hommes, les troupeaux et les marchandises, destinés à réguler les flux plutôt qu’à défendre ou à fermer hermétiquement le territoire provincial[26].
Les jessour sont, en effet, de petites digues partielles construites dans le lit des torrents et dans les vallons qui retiennent les eaux de reflux et les limons fertiles que celles-ci charrient, réduisant ainsi l’érosion hydrique. Les jessour sont agencés en séquences, à intervalles réguliers, dans le lit du torrent. Chaque jesr est constitué d’un barrage (tabia ou katra) perpendiculaire au vallon, et d’une aire de récolte des sédiments (fond du jesr) qui est une sorte de terrasse située en amont de la tabia sur laquelle sont installées les cultures et dont la base est parfois renforcée à l’aide de pierres ; chaque tabia a un ou deux déversoirs, appelés menfess pour indiquer les déversoirs latéraux et masraf pour indiquer les déversoirs centraux, qui permettent de faire défluer l’excédent d’eau vers le jesr situé en aval ; les eaux s’infiltrent progressivement dans le sol et ne s’évaporent pas, constituant ainsi une réserve vitale pour lutter contre la sécheresse. Certains experts estiment que grâce à cette méthode 200 mm de pluie sont aussi efficaces que 500 mm et que l’agriculture en tire de nets avantages[27].
Les jessour sont déjà connus au XIe siècle comme l’attestent certains documents mais il est fort probable que cette technique plonge ses racines dans des codes non écrits qui remontent à l’Antiquité. Ils supposent l’existence d’une organisation collective qui limite le droit subjectif au nom de l’intérêt de la collectivité. Chaque jesr, en effet, ne peut retenir qu’une certaine quantité d’eau et doit céder l’excédent d’eau au jesr situé en aval ; la hauteur de la tabia, la position et la largeur des déversoirs, l’inclinaison du jesr ne peuvent être modifiées qu’après accord entre les propriétaires de jessour contigus et ces derniers doivent en assurer l’entretien ; il est interdit d’obstruer les déversoirs pour retenir les eaux, ce qui causerait un tort au propriétaire voisin ; chaque propriétaire est responsable des dommages causés en aval par les eaux qui débordent de son jesr.
L’usage des jessour a probablement favorisé la sédentarisation des tribus du désert dans le Djebel, où l’élite punico-libyque, romanisée par la suite, pratiquait depuis longtemps la culture de l’olivier : la nécessité d’accaparement de nouvelles parcelles de terre susceptibles grâce aux jessour d’assurer d’importants revenus pourrait être à l’origine de la violente rivalité entre Lepcis Magna et Oea, qui a explosé en 71 apr. J.-C. avec l’intervention armée du commandant de la légion. Il apparaît clairement que l’existence des jessour situés entre la Libye et la Tunisie est liée à celle d’une série de fermes nées parallèlement à la création d’un réseau serré de fortins érigés, à l’époque julio-claudienne, pour assurer le contrôle du territoire ; ce n’est probablement qu’au IVe siècle que ces fermes furent fortifiées et se transformèrent en ksour. Le singulier ksar dérive sans doute du latin castra et les occupants mêmes aimaient qualifier ces fermes à l’aide de termes militaires comme turris, castra, oppidum : sous sa forme la plus classique, le ksar est une tour quadrangulaire aux murs épais qui abrite deux ou plusieurs dépôts, un puits et une étroite porte permettant d’y accéder[28].
5. Les ksour, isolés ou regroupés en petits noyaux de cinq ou six édifices, étaient entourés d’espaces circulaires identifiés comme d’anciennes cours, des greniers circulaires destinés au stockage des céréales, des pressoirs et surtout des citernes ou des puits qui captaient les eaux des oueds : les citernes (majen) étaient généralement placées au bord des oueds et les bassins étaient creusés dans la roche[29]. L’exemple le mieux conservé est celui de Tininai qui présente un petit puits quadrangulaire d’une profondeur de 7 mètres et dont chaque côté mesure 2 mètres sur 2 mètres, à la base duquel s’ouvrent quatre canaux croisés de 24 m sur 4 m; l’eau était tirée à partir de puits plus petits et de bassins de décantation, selon des modèles fort bien décrits par Rebuffat lors de ses investigations sur les fermes de la Libye. Ce type d’installations pouvait recueillir de 50 à 200 m3 d’eau mais à Tininai la batterie de citernes arrivait à stocker 3000 m3. A Ain Merzak près de Bir Scedua, il y a quelques années encore, l’eau était captée d’une source pérenne grâce à un manège tiré par des animaux qui permettait de puiser l’eau jusqu’à une profondeur de 20 mètres. Mais le système le plus couramment utilisé était celui des bassins quadrangulaires creusés en surface, revêtus d’un enduit de chaux hydraulique et dotés d’une couverture voûtée ou plate dont la surface présente de petites ouvertures circulaires qui permettaient de puiser l’eau par le haut. L’eau était transportée vers la citerne grâce à des puits de captation et de petits bassins de décantation situés en amont de la citerne même[30].
6. Les foggaras, galeries souterraines capables de drainer les eaux de la nappe aquifère et de les convoyer vers les oasis, constituent une technique répandue dans les régions prédésertiques situées entre la Libye et l’Algérie ; au Maroc, ce système, sans doute introduit à partir des Aglabides, est connu sous le nom de khettara mais il est fort possible que cette technique soit originaire d’Iran (où ces galeries sont connues sous le nom de qanats), et qu’elle ait été introduite en Egypte au Ve siècle av. J.-C. par les Achéménides et transmise d’abord aux Garamantes du Fezzan et ensuite aux Romains ; les chercheurs ont retrouvé certaines traces de ce système en Andalousie (on parle alors de madjira ou de pozeria) et en Amérique du Sud où il a été récemment exporté.
Les foggaras sont des puits d’aération verticaux, creusés à intervalles réguliers, qui relient la galerie souterraine, située parfois à vingt mètres de profondeur, à la surface libre. Ces puits sont indispensables pour le creusement de la galerie et pour les opérations d’entretien et de nettoyage. Pour réaliser la galerie, il faut dans un premier temps procéder au creusement d’une série de puits, à intervalles réguliers et à profondeur constante ; on procède ensuite au creusement d’un tunnel à la partie basse de deux puits contigus jusqu’à ce que l’on parvienne à relier entre elles les deux excavations convergentes, et l’on obtient ainsi un tunnel hydraulique entre les deux puits de départ. En surface, à l’ouverture des puits, sont entassés les matériaux d’excavation ainsi récupérés, lesquels indiquent la présence et la direction des conduits souterrains. En aval, la galerie, caractérisée par une inclinaison douce, débouche sur un bassin situé dans l’oasis et relié ensuite à un réseau de canaux servant à irriguer les champs. Les opérations de creusement de la galerie commencent dans les zones agricoles de l’oasis, pénètrent le sol des vallées alluviales et remontent les lits du réseau hydrographique pour finalement atteindre l’ensemble des strates perméables de la nappe phréatique. Grâce à ce système, il est possible d’utiliser à travers les strates perméables la nappe phréatique alimentée par les précipitations ou par les condensations nocturnes de l’humidité de surface, due aux fortes excursions thermiques. L’eau de captation et l’eau de condensation peuvent ainsi être canalisées et utilisées pour l’irrigation, sans dispersion inutile de liquides dans le terrain ou dans l’atmosphère. Plus la surface drainante de captation est grande, plus la quantité d’eau distribuée dans les champs en aval est importante[31].
Grâce aux foggaras, les Garamantes, installés entre l’Hamada el Jamra et le Tropique du Cancer, développèrent une forte agriculture dont les produits étaient en partie destinés au commerce avec les villes romaines de la côte libyenne. Leur capitale, Garama, centre de 20 hectares entouré de murs d’enceinte, parsemée de temples, de thermes, de quartiers habitatifs, de marchés, de vastes et riches nécropoles, peut être considérée comme une véritable ville. Leur territoire était doté d’un système d’irrigation fort bien structuré qui, aujourd’hui encore, compte des milliers de foggaras dont la longueur oscille entre 500 mètres et 2 kilomètres[32]. Les Garamantes ont probablement enseigné cette technique aux Gétules qui, à leur tour, la répandirent dans les régions sahariennes algériennes du Gourara, du Touat, du Tidikelt et de l’Ahaggar, entre Tébessa et Batna, régions où les galeries drainantes, environ un millier, constituent un long réseau oscillant entre 3000 et 6000 kilomètres[33]. En Algérie, la profondeur du drainage de la nappe phréatique est toujours limitée et la distance entre les puits d’aération varie entre 2 et 4 mètres à cause de la fragilité du terrain et aussi probablement pour ne rien perdre des précipitations occultes ; la longueur des canaux souterrains oscille entre 3 et 10 kilomètres ; les galeries étroites ne dépassent pas les 60-70 cm de largeur et atteignent une hauteur qui varie entre 1-1,50 m et 3-4 m, probablement à la suite d’un abaissement de la nappe phréatique qui, dans certains cas, a donné lieu à la réalisation d’une deuxième galerie creusée plus bas[34]. En Tunisie, nous citerons les fameux tunnels drainants de la plaine d’El Soukra, à l’ouest de Carthage, ceux de Sidi Nasseur Allah, situés à environ 80 km à l’ouest d’El Djem, entre Kairouan et Gafsa, dans l’oasis d’El Guettar, dans la région du Nefzaoua[35].
7. Les caractéristiques hydrogéologiques de la région située tout près des pentes septentrionales du massif de l’Aurès ont favorisé un fort peuplement à l’époque romaine et ont contribué à la naissance de nombreux bourgs agricoles qui, grâce à un système d’approvisionnement hydrique bien structuré et diversifié, étaient capables d’exploiter au mieux les nappes phréatiques de surface[36]. La foggara d’Inemarem située dans la région montagneuse du Bellezma, dans l’Aurès nord-occidental, était probablement l’une des sources de l’Aqua Claudiana de Lamasba. D’où le célèbre règlement de aquis[37], rédigé sous le principat d’Elagabal suite à un arbitrage interne à la communauté qui disciplinait les coloni (pour la plupart des Numidae) installés sur les terres impériales. Ce texte établissait de façon précise, pour la période comprise entre le 25 septembre et le mois de décembre, les horaires et la durée d’irrigation de chaque lot en fonction de la position du terrain, de la faible ou de la forte évaporation durant la journée, du niveau du bassin de collecte de l’eau (aqua descendens ou ascendens). Un système d’écluses permettait probablement de contrôler le niveau de l’eau du bassin qui ne devait jamais aller au-delà ou en-deçà du niveau de sécurité. L’eau du bassin était distribuée à travers un canal central (matrix riganda) relié à des canaux secondaires qui débouchaient sur les différentes parcelles de terre, dont certaines étaient cultivées en terrasses (scalae). La quantité d’eau destinée à chaque parcelle était calculée sur la base d’un certain coefficient K, une sorte d’échelle de valeur garantissant impartialité et uniformité dans l’irrigation des terres. Le règlement de Lamasba naît de la rencontre pragmatique entre la tradition juridique italique et les systèmes de mesure puniques, encore répandus parmi la population locale au début du IIIe siècle.
L’application de ce règlement était probablement fort répandue si l’on tient compte du fait que l’on se référait encore à l’aqua ascendes ou descendes dans une des Tablettes Albertini, document extrait du fichier de Flavius Geminius Catullinus, riche propriétaire de la région de Tébessa, et rédigé en 494 : les parcelles vendues par Iulius Restitutus et son épouse Donata sont cultivées en terrasses (particellas agrorum id est aumas sivi coerentes), et leur valeur est déterminée en fonction des plantes qui y sont cultivées et des droits sur l’eau détenus par le propriétaire[38]. Pol Trousset établit un lien, et ce de façon très perspicace, entre ces mécanismes de distribution hydrique et les mécanismes relevés dans les oasis et dans les jessour tunisiens où, comme à Lamasba, ils ont donné naissance à une forme de propriété très parcellisée : par exemple, dans les oasis du Touat et du Gourara, à la sortie des foggaras, les eaux passent à travers un canal découvert dans un bassin de distribution et sont ensuite déversées dans les canaux (seguia) de chaque propriétaire, proportionnellement aux quotes-parts de propriété de celui-ci.
Bien qu’elles soient d’origine préromaine, les foggaras se sont répandues en Afrique à l’époque impériale et les Romains ont enrichi ce système en y apportant certaines améliorations techniques : par exemple, en revêtant le canal souterrain à l’aide de dalles ou de pierres, pratique que les Garamantes ignoraient, afin de réduire les fuites d’eau ; ou encore, en recourant à un autre expédient qui consistait à réaliser dans le canal une petite goulotte, également revêtue, pour faciliter l’écoulement de l’eau. L’Aqua Paludensis de Thamugadi, construite dans les années 183-185, était probablement une foggara, mais elle utilisait également un grand nombre de puits et de citernes et exploitait les eaux de la source pérenne d’Ain Morris : en effet, l’inscription rappelle que cet ouvrage hydraulique était capable de drainer (conquirere) les eaux d’une nappe phréatique (aquae paludensis)[39].
8. Jessour, foggaras, puits, canaux et aqueducs constituent souvent les éléments d’un système intégré qui, aujourd’hui encore sur un même territoire, par exemple dans l’oasis d’El Guettar près de Gafsa, visent à exploiter les ressources hydriques présentes, luttent contre l’érosion des sols et contre les phénomènes de désertification, favorisent le rehaussement de la nappe phréatique[40]. Les effets de cette organisation sont décrits dans un célèbre passage de Pline l’Ancien, procureur fiscal en Afrique Proconsulaire entre l’année 70 et l’année 72, qui visita probablement l’oasis de Gabès, ancienne Tacape, et qui fut frappé par son extraordinaire fertilité : « il y a en Afrique, au milieu des sables, … une cité nommée Tacape, dont le territoire, bien irrigué est d’une fertilité miraculeuse. Dans un rayon d’environ trois mille pas, une source fournit une eau abondante sans doute, mais qu’on ne distribue pourtant qu’à heures fixes aux habitants. Là, sous un immense palmier, pousse un olivier ; sous l’olivier, un figuier ; sous le figuier, un grenadier ; sous le grenadier, une vigne ; sous la vigne on sème le blé, puis des légumineuses, enfin des herbes potagères : tout cela la même année, tout cela se nourrissant à l’ombre du voisin. … Le plus étonnant c’est que la vigne y porte deux fois et qu’on fait la vendange deux fois par an. Et si la fécondité du sol n’était pas épuisée par des productions multiples, tous ses fruits périraient à cause de l’abondance elle-même. Le fait est que toute l’année on y récolte quelque chose, et il est certain que les hommes ne favorisent pas cette fertilité ». La source à laquelle Pline fait allusion est dans doute celle de Sed Reha, où les archéologues ont retrouvé les ruines d’un barrage datant probablement de l’époque romaine[41]. Pline est séduit par la richesse de l’oasis, où les parcelles de terre atteignent des prix très élevés mais qui sont justifiés par la rentabilité des terres ; il observe la méthode étrange que les habitants utilisent pour calculer les surfaces (Quaterna cubita eius soli in quadratum, nec ut a porrectis metiantur digitis, sed in pugnum contractis), méthode que le système de mesure romain ignorait totalement ; il souligne à quel point la nature a été généreuse avec l’homme en le récompensant au-delà de ses mérites mais reconnaît dans le même temps les capacités que déploient les habitants de l’oasis dans l’organisation et la distribution de cette richesse pour maximiser leur profit. Les représentations funéraires liées aux ksour les plus importants attestent également l’efficacité de ces systèmes d’adduction et leur impact sur l’économie : les scènes de guerre, de chasse, d’administration de la justice côtoient des scènes représentant des caravanes chargées de marchandises et des scènes de la vie agricole : la cueillette des dattes, les semailles et la récolte des céréales, les dromadaires qui labourent les champs, une image esthétique presque, pourrait-on dire, de ce que Pline avait pu observer à Gabès.
9. L’usage d’un bien précieux comme l’eau appelait l’application de normes. La source était souvent considérée comme un bien privé dont la disponibilité totale revenait au dominus du fundus où elle se trouvait, mais dans de nombreux cas l’intérêt de la communauté l’emportait sur l’intérêt privé, comme c’était le cas à Lamasba, dans les oasis du Touat et du Gourara, à Gabès. Les autorités provinciales favorisaient, par le biais de servitudes rurales, l’accès des hommes et des troupeaux aux sources, soit parce que la source était en tout état de fait fréquentée depuis des temps immémorables, soit parce qu’il était admis qu’une utilisation ininterrompue de la source échelonnée sur une dizaine d’années seulement suffisait pour y accéder. Dans d’autres cas (par exemple à Ain Sidi Mansour dans l’Ouarsenis, à l’époque de Probus), le gouverneur même créait un nouveau droit, en autorisant l’accès à la source, considérée comme un bien d’intérêt général, de certaines catégories et en transformant ce bien privé en bien public[42].
A Ammaedara, l’intervention de Caius Postumius l’Africain, sénateur et patron de la colonie entre les années 160 et les années 180, se révèlera nécessaire pour imposer les servitudes prédiales permettant de faire passer l’aqueduc destiné à alimenter la ville et les champs : nous savons, en effet, que les techniciens chargés de réparer la structure pouvaient y accéder à tout moment et qu’ils pouvaient utiliser tout ce dont la propriété disposait pour effectuer les réparations ; de chaque côté sur une distance de 15 pieds, il était interdit de construire des habitations, d’ériger des tombes ou de planter des arbres. Cette limite imposée était une limite importante, surtout lorsque l’on approchait de la ville et que les surfaces constructibles prenaient plus de valeur, en particulier les surfaces situées à proximité d’une route, qui était souvent la directrice suivie par un aqueduc [43]. La nomination de l’Africain atteste de toute évidence la forte résistance qu’opposèrent les propriétaires à une construction qui en désavantageant un nombre restreint de personnes aurait profité à toute la collectivité : d’où la nécessité de choisir à cet effet un notable capable de convaincre les plus réticents à ne pas opposer de vétos qui auraient contraint l’administration à la mise en place de longues procédures et à la coûteuse prise en charge des modifications du projet. L’Africain agissait sur ordre du proconsul, en qualité de légat spécial, ou après avoir été autorisé par le procureur à traverser les terres impériales. A bien y regarder, les problèmes de ce genre ressemblent beaucoup à ceux que doivent affronter aujourd’hui nos responsables administratifs et cet aspect même contribue à rendre extraordinairement moderne à nos yeux cette approche de l’eau des anciens Romains.
* Nous remercions Messieurs M. Casagrande, M. B. Cocco, R. Zucca qui ont bien voulu nous assurer de leur collaboration et discuter avec les auteurs des différents thèmes abordés.
[1] Despois, 1963, 15-29, 97-110.
[2] Despois, 1963, 19.
[3] Despois, 1963, 26, 27-28, 98, 103.
[4] AE 1975, 880 de Ureu: … [aquam (?) corrup]/tam post diluviem [—]/to servato recte (?) [—] / propria liberalitate [ex]o[rnavit] …; CIL VIII, 2661 (p. 1739) = ILS 5788 da Lambaesis: Aquam Titulensem quam ante annos / plurimos Lambaesitana civitas in/terverso ductu vi torrentis amiserat / perforato monte instituto etiam a / solo novo ductu …; de Gherait el Garbia (Chiron, 2011, 276): Ab impetu aqu[arum —] / Multa loca ed[ucta(?) — / — pa]lude du[— per(?)] / [limi]tem Ten[theitanum — / —]I CVII m[ili(?)] …
[5] Leschi, 1948, 103-116 = Etudes, pp. 75-79.
[6] IRT 896 = AE 1973, 573: … [aquaeductu]m bell(o) dissi[patum] …. Sulla strategia degli Austuriani Felici, Munzi, Tantillo, 2008, 627-632.
[7] AE 1975, 883 = 1978, 835 = 1983, 975 = 2005, 1685: … praeter cetera bona q[uae] / in eodem f(undo) fecit steriles / qu[o]que oleastri surculo[s] / inserendo plurimas o[leas] / instituit puteum [iuxta] / viam pomarium cum tric[hilis] / post collectarium vin[eas] / novellas sub silva aequ[e in]/stituit …
[8] AE 1949, 49 cfr. CIL VIII, 23653 = 23673 = ILTun 565 = ILS 5732.
[9] CIL VIII, 21671 = ILS 5769: …. aquagium suis possessionibus / constituerun(t) et dedicaverunt.
[10] Salama, 1973, 344, notes 11-12; Bel Faïda, 2002, 1715-1728. Les dédicaces consacrées aux Nymphes, liées généralement à une installation thermale ou à un puits d’eau chaude, sont moins évidentes, cf. Arnaldi, 2004, 1355-1364.
[11] Cf. les différentes positions de di Shaw 1984, 121-173 ; Slim 1990, 169 ; Peyras 1991, 208-209 ; Wilson 1998, 91-92; Wilson 1999, 314.-331 ; Bel Faïda, 2000, 1589-1602 ; Bel Faïda, 2009, 123-141 ; Casagrande, 2010, 469. Cf. également Casagrande, 2008, passim.
[12] IRT 117.
[13] CIL VIII, 1480 (p. 2616) = 26534 = ILTun 1408 = AE 1966, 511 = DFH 36 = ZPE-175-288: [Pro salute Imp(eratoris) Caes(aris) M(arci) Aureli Commodi Antonini Aug(usti)] Pii Sarm[atici Ge]rmanici max[i]mi Britannici p(atris) p(atriae) civitas Aurelia Thugga [a]quam con[duxit e fonte M]occol[i]tano a milliario septimo [sua] pecunia induxi[t et] lacum fecit M(arcus) Antonius Zeno proc[o(n)s(ul) Africae dedic(avit) cur(atore) L(ucio) Terentio Romano] cf. Casagrande, 2010, 461-462, 469.
[14] Lenoir 2009, 41-83 ; Pons Pujol – Lagostena Barrios, 2010, 533-542; cf. Euzennat, 1989.
[15] Baradez, 1949, pp. 165-212 ; Birebent, 1964.
[16] Picard, 1959, 59-76 ; Despois 1963, 120.
[17] Trousset, 1986 ; Ben Ouezdou-Trousset, 2009, 1-16.
[18] Barker, 1996, passim ; Mattingly, 1996, passim.
[19] Baklouti, 2008, 811-856 ; Mosca-Di Stefano, 2008, 857-877 ; De Angelis-Finocchi, 2008, 2179-2196. Sur les installations de Carthage, cf. également Wilson, 1998, 65-102 ; Rossiter, 2009, 177-197 ; Di Stefano, 2009, 143-164.
[20] Casagrande, 2008, en particulier 249-260 : en Zeugitania, les chercheurs ont répertorié 249 installations réparties sur 202 sites (118 installations urbaines, 13 installations rurales, 17 installations privées), en Byzacena, on compte 173 installations réparties sur 163 sites (49 installations urbaines, 18 installations rurales, 8 installations privées).
[21] Ben Ouezdou-Trousset, 2009, 11.
[22] Ben Ouezdou-Trousset, 2009, 11-12.
[23] Supra; voir également Mattingly, 1995, 68-77.
[24] Trousset, 1974 ; Trousset, 1987 ; Mrabet, 1999 ; Mrabet, 2003.
[25] Hitchner, 1995, 143-158.
[26] Voir les différentes approches de Bénabou, 1976, 429-445 ; Whittaker, 1978, 332-337, 340-350 ; Trousset, 1980, 935-942 ; Trousset, 1984, 383-398 ; Casella, 2004, 211-238.
[27] Ben Ouezdou-Trousset, 2009, 3-4.
[28] Rebuffat, 1982, 193-195 ; Elmayer, 1985, 78-80 ; Rebuffat, 1988, 44-60 ; Mattingly, 1987, 75-83 ; Mattingly, 1989, 141-143 ; Mattingly, 1995, 202-209 ; Mattingly-Dore, 1996, 127-133 ; Mattingly, 1998, 168-173 ; Felici, Munzi, Tantillo, 2008, 647-650 ; Munzi, Felici, Cirelli, Schingo, Zocchi, 2010, 727-731, 737-739. Certains ksour ont été repérés dans la vallée du Wadi Bei el-Kébir et dans les bassins de l’oued Zem et de l’oued Soffegin, à la lisière du Grand Erg oriental, dans le couloir entre Gabès et le Chott El-Djérid.
[29] Mattingly-Dore, 1996, 133-158.
[30] Rebuffat, 1988, 38-40, 43, 46, 53-55.
[31] Mattingly-Wilson, 2003 ; De Angelis-Finocchi, 2008, 2179-2196 ; Wilson, 2009, 19-39.
[32] Mattingly-Wilson, 2003, 47-49.
[33] Mattingly-Wilson, 2003, 39, cf. Birebent, 1964, 51-58, 63-66, 81-83, 203-205, 213-215, 267-268, 387-389 : les chercheurs ont répertorié certaines foggaras à Souma el Kiata, Henchir Oukhmida et Fridju, sur le haut plateau du Mahmel entre les monts Némentchas, à Ksar el Kelb (Vegesala), à Ain Ferhat, dans la plaine de Sbikra, à Ain Kharoubi, dans la plaine de Baghaï, Badias.
[34] De Angelis-Finocchi, 2008, 2189.
[35] De Angelis-Finocchi, 2008, 2190.
[36] Jacques, 1992, 125-139.
[37] CIL, VIII, 4440 = 18587 cf. Birebent, 1964, 341-343, 387-389 ; Trousset, 1986, 175-178, 192-193 ; voir également Picard 1959, 64; Shaw, 1982, 61-103 ; Meuret, 1996, 87-112 ; De Angelis-Finocchi, 2008, 2191; Casagrande, 2010, 468.
[38] AE 1952, 209 = 1954, 212 ; cf. Shaw, 1982, 81.
[39] AE 1934, 40 cf. Leschi (1934-1935) ; Birebent, 1964, 325-330 ; Fentress (1979), 168-70.
[40] De Angelis-Finocchi, 2008, 2188-2189.
[41] Plin. NH, XVIII, 188-189 : Civitas Africae in mediis harenis petentibus Syrtis Leptimque Magnam vocatur Tacape, felici super omne miraculum riguo solo. Ternis fere milibus passuum in omnem partem fons abundat, largus quidem, sed et certis horarum spatiis dispensatur inter incolas. Palmae ubi praegrandi subditur olea, huic ficus, fico punica, illi vitis, sub vite seritur frumentum, mox legumen, deinde olus, omnia eodem anno, omniaque aliena umbra aluntur. Quaterna cubita eius soli in quadratum, nec ut a porrectis metiantur digitis, sed in pugnum contractis, quaternis denariis venundantur. super omnia est bifera vite, bis anno vindemiare. Et nisi multiplici partu exinaniatur ubertas, pereunt luxuria singuli fructus. Nunc vero toto anno metitur aliquid, constatque fertilitati non occurrere homines. Cf. également Trousset, 1986, 169, 173-175.
[42] Salama, 1973, 339-349, cf. AE 1973, 652.
[43] AE 1988, 1119 : Amm[aed]ar[ae] Aug(ustae) s[acrum] / C(aius) Postu[miu]s C(ai) f(ilius) Qui[r(ina)] / Afr[icanus c(larissimus) v(ir)] / [I]IIvir ca[pital(is) tr]ib(unus) leg(ionis) VII Gem(inae) q(uaestor) urb(anus) [ab ac]/[tis] senatus aedil(is) curul(is) p[r]aet(or) [urb(anus)] / [leg(atus) p]ro pr(aetore) patronus col(oniae) aq[uae ductum] / [e legi]bus praediorum iuris su[scepit] / [cum] / [rivo a]quae [q]uae permissu p[roco(n)s(ulis) vel p[roc(uratoris) fluit]. Cf. Ben Abdallah, 1988, 236-251; Casagrande, 2010, 463-466.

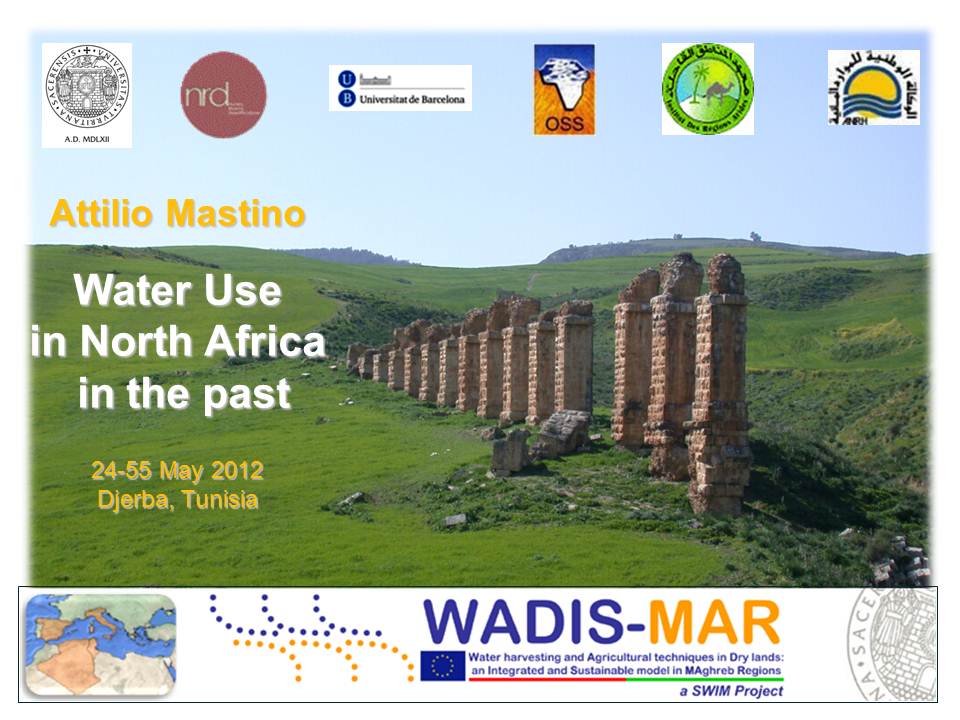
 ho il piacere di accogliere a nome dell’Università di Sassari in questa solenne cerimonia tanti Rettori ospiti, tante autorità, tanti colleghi, tanti studenti, con un abbraccio ideale col quale vogliamo rinnovare in questo stesso Teatro Verdi il faustissimus eventus di 50 anni fa, che ci riporta al 30 maggio 1962 quando furono celebrati i 400 anni del nostro Ateneo, l’Alma in Sardinia mater studiorum.
ho il piacere di accogliere a nome dell’Università di Sassari in questa solenne cerimonia tanti Rettori ospiti, tante autorità, tanti colleghi, tanti studenti, con un abbraccio ideale col quale vogliamo rinnovare in questo stesso Teatro Verdi il faustissimus eventus di 50 anni fa, che ci riporta al 30 maggio 1962 quando furono celebrati i 400 anni del nostro Ateneo, l’Alma in Sardinia mater studiorum. 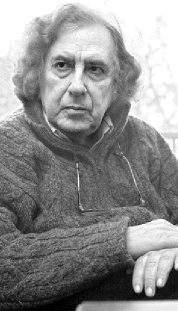 con dolore desidero informarVi che domenica 26 febbraio Giulio Girardi è scomparso dopo una lunga malattia. Aveva appena compiuto ottantasei anni di un’esistenza straordinaria di studioso, di militante e di educatore.
con dolore desidero informarVi che domenica 26 febbraio Giulio Girardi è scomparso dopo una lunga malattia. Aveva appena compiuto ottantasei anni di un’esistenza straordinaria di studioso, di militante e di educatore. è un grande onore per l’Università di Sassari, per gli studenti, i professori e il personale, aprire le celebrazioni per i 450 anni dell’Ateneo, l’Alma in Sardinia mater studiorum, alla presenza del signor Presidente della Repubblica sen. Giorgio Napolitano, accompagnati da centinaia di messaggi augurali provenienti da tanti Atenei. Siamo commossi per una così alta presenza che rende omaggio alla nostra storia. Si ripete, a distanza di 50 anni, il faustissimus eventus delle celebrazioni centenarie dell’Universitas Turritana Sacerensis, aperte il 30 maggio 1962 da un altro Presidente, il sen. Antonio Segni.
è un grande onore per l’Università di Sassari, per gli studenti, i professori e il personale, aprire le celebrazioni per i 450 anni dell’Ateneo, l’Alma in Sardinia mater studiorum, alla presenza del signor Presidente della Repubblica sen. Giorgio Napolitano, accompagnati da centinaia di messaggi augurali provenienti da tanti Atenei. Siamo commossi per una così alta presenza che rende omaggio alla nostra storia. Si ripete, a distanza di 50 anni, il faustissimus eventus delle celebrazioni centenarie dell’Universitas Turritana Sacerensis, aperte il 30 maggio 1962 da un altro Presidente, il sen. Antonio Segni.