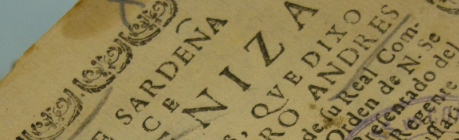Attilio Mastino
Le relazioni storiche della Sardegna con la Tunisia
Convegno Sardegna e Tunisia: un patrimonio comune verso uno sviluppo condiviso
Cagliari, 12 aprile 2013

La riflessione sulle relazioni storiche tra Africa e Sardegna in età antica in questi ultimi trenta anni è stata quanto mai estesa e ricca di risultati: i convegni internazionali di studi su «L’Africa Romana», promossi annualmente a partire dal 1983 dal Centro di studi interdisciplinari sulle province romane dell’Università di Sassari anche a Tunisi, Cartagine, Djerba e Tozeur, hanno consentito di mettere a confronto le esperienze di archeologi, storici, epigrafisti, al fine di individuare gli apporti regionali e nazionali al complesso fenomeno della romanizzazione e insieme di mettere a fuoco le relazioni tra le diverse province mediterranee. Abbiamo affrontato il rapporto tra centro e periferia per valorizzare gli apporti specifici delle diverse province, per indicare, sul piano culturale, artistico, religioso, linguistico, le articolazioni locali ed il contributo delle singole aree.
Andando oltre la storia di Roma, che privilegia una concezione unitaria, abbiamo affrontato il tema delle persistenze indigene e del contributo che le differenti realtà nazionali e locali hanno dato al processo di romanizzazione. In questo senso lo studio della storia delle provincie africane può diventare un indispensabile complemento della Storia Romana tradizionale vista esclusivamente sotto il profilo istituzionale ed organizzativo ed intesa come ricostruzione di quella corrente che provocò un processo di livellamento che introdusse anche sul piano culturale e sociale unitari elementi romani.
Abbiamo in sostanza voluto ribaltare la visione coloniale che perseguiva l’obiettivo romantico di ripercorrere le strade di una civiltà perduta, di ritrovare le radici dell’anima europea del Nord Africa travolto dagli Arabi, perché nella visione coloniale europea della prima metà del secolo scorso la civiltà classica in Nord Africa non morì di morte naturale, ma fu assassinata con l’occupazione araba di Cartagine nel 698, quando il comando bizantino dell’esarcato fu trasferito a Karales. Le scoperte archeologiche furono effettuate nella Tunisia di fine Ottocento inizialmente dagli ufficiali dell’esercito di occupazione francese, dopo il trattato del Bardo del 1881: così ad esempio a Dougga ed ad Uchi Maius, dove operarono l’aiutante maggiore medico de Balthazar, il capitano De Proudomme ed il capitano Gondouin, tutti in rapporto con l’Academie des inscriptions et belles lettres e con la Société des Antiquaires de France.
Più tardi arrivarono gli archeologi, gli storici e gli epigrafisti, alcuni di altissimo livello come P. Gaukler, René Cagnat, Alfred Merlin, J. Poinssot, maestri della nutrita e apprezzata serie degli archeologi tunisini. Intanto all’incrocio del cardo e del decumanus maximus della colonia cesariana di Cartagine, sulla collina Byrsa, i francesi costruivano la cattedrale del card. Charles Martial Allemand Lavigerie, recentemente trasformata in un Acropolium laico per turisti. A fianco fu consacrato il cenotafio di San Luigi, le cui ossa durante la VIII crociata erano state ricondotte a Parigi.
Con la colonizzazione si affermava una nuova cultura egemone e restò ormai fissata nell’immaginario collettivo dei popoli del Maghreb l’idea di una forzatura, di una strumentalizzazione del mondo classico al servizio della prospettiva coloniale francese in Algeria e Tunisia, ma anche italiana in Libia e spagnola iun Marocco.
Nel momento in cui i paesi del Maghreb ritrovavano, dopo la II guerra mondiale, una loro sovranità nazionale, la conseguenza inevitabile fu una reazione contraria, una sostanziale sottovalutazione delle radici classiche e una enfatizzazione, in realtà purtroppo spesso solo teorica, delle fasi islamiche della storia del Nord Africa. Teorica perché se è vero che sullo sfondo c’è il convinto apprezzamento per la grande cultura araba arrivata anche ad influenzare l’Europa cristiana; di fatto però le fasi medievali del primo insediamento arabo in Ifriqya non sono mai state studiate davvero scientificamente e la cultura materiale islamica delle origini non ha fin qui avuto una presentazione adeguata. Nel quadro della progressiva indifferenza per il patrimonio pre-islamico, indubbiamente la Tunisia tra il 1956 con Bourghiba e il 1986 con Ben Ali ha rappresentato un’eccezione nel panorama dei paesi del Maghreb, grazie all’impegno dell’Institut National d’Archéologie et d’art, da quindici anni trasformato in Institut National du Patrimoine al quale si affianca l’azione dell’Agence National du Patrimonie che ha la specifica missione di gestire monumenti e musei archeologici. Enti che hanno sostenuto molte grandi imprese internazionali in particolare europee, che spesso però furono costrette a cambiare decisamente i loro obiettivi. Rimane sullo sfondo il nuovo tema della “resistenza” alla romanizzazione, che, se si è manifestata con clamorosi fenomeni militari come a Zama, spesso si è svolta in modo sotterraneo ma non per questo meno significativo. Essa è interpretata da figure come Annibale o Giugurta valorizzate anche sulle monete ufficiali del nuovo stato tunisino.
Con la primavera araba, con la fuga di Ben Ali il 14 gennaio 2011, si è fin qui evitato il pericolo che i lunghi e brillanti periodi preislamici del Maghreb potessero rappresentare una minaccia per il progetto di panarabismo dominante. Si rende dunque sempre più necessario riprendere un cammino che sarà possibile solo partendo dalla consapevolezza che il patrimonio rappresenta una ricchezza anche per l’identità della Tunisia di oggi, superando nel rispetto dovuto la strumentalizzazione del passato per scopi politici o religiosi.
La strada è quella di arrivare scientificamente ad una ricostruzione storica complessiva, fondata su un’indagine interdisciplinare, indirizzata verso una valutazione globale del mondo antico e tardo antico: dalle indagini più recenti emergono le nuove linee del processo di organizzazione municipale romana, nelle sue stratificazioni storiche e nei suoi condizionamenti determinati da precedenti realtà regionali; è così possibile un approfondimento del tema delle civitates indigene, tribù e popolazioni non urbanizzate, nomadi, seminomadi e sedentarie, raccolte intorno a re e principi indigeni, in un rapporto di collaborazione o di conflitto con l’autorità romana. La persistenza di istituzioni, abitudini, usi e costumi arcaici all’interno dell’impero romano è una delle ragioni della convivenza tra diritto romano classico e diritti locali, anche se spesso improvvise innovazioni sono entrate in contrasto con antiche consuetudini. Solo così si spiega come, accanto all’affermarsi di nuove forme di produzione, di organizzazione sociale, di scambio, in alcune aree siano sopravvissute le istituzioni locali, il nomadismo, la transumanza, l’organizzazione gentilizia, mentre la vita religiosa e l’onomastica testimoniano spesso la persistenza di una cultura tradizionale e di una lingua indigena come ad Uchi Maius. Altre problematiche di estremo interesse riguardano il paesaggio agrario, le dimensioni della proprietà, la pastorizia nomade, le produzioni, i commerci di minerali e di marmi come a Chemtou-Simittus, i dazi, i mercati, l’attività dei negotiatores italici o africani comme a Sullectum, la dinamica di classe, l’evergetismo, la condizione dei lavoratori salariati, degli schiavi e dei liberti: temi che ora possono essere affrontati con metodi e strumenti rinnovati, grazie anche alle nuove tecniche di indagine, come l’archeologia sottomarina, da noi praticata a Nabeul.
Alla vigilia del XX Convegno de L’Africa Romana che organizziamo a settembre ad Alghero grazie alla collaborazione con l’Università di Sousse, la Sardegna può aspirare ad essere il laboratorio ideale per nuovi studi sulle province africane, intese come ambiti territoriali di incontro tra culture e civiltà. All’interno del bacino occidentale del Mediterraneo, la Sardegna ha ancora oggi una posizione centrale significativa; per l’età antica l’isola, periferica da un punto di vista culturale ma collocata geograficamente al centro dell’impero, fu arricchita immensamente dagli scambi mediterranei, partecipando essa stessa alla costruzione di una nuova cultura unitaria, mantenendo tuttavia nei secoli una specificità propria. Esplorare il confine tra romanizzazione e continuità culturale, tra change e continuity, è compito che deve essere ancora affrontato, al di là della facile tentazione di impossibili soluzioni unitarie.
I rapporti tra Africa e Sardegna dovettero essere intensi anche in epoca preistorica, se appunto ad un libico, all’eroe Sardus, figlio di Maceride (nome dato dai Libii ad Eracle-Melqart), i mitografi greci attribuivano la primitiva colonizzazione dell’isola. Ancora in età storica Sardus era venerato in Sardegna con l’attributo di Pater, per essere stato il primo a guidare per mare una schiera di colonizzatori giunti dall’Africa e per aver dato il nome all’isola, in precedenza denominata ‘l’isola dalle vene d’argento’, con riferimento alla ricchezza delle sue miniere: a questo eroe-dio, identificato con il Sid Babi punico e con Iolao patér greco, il condottiero dei Tespiadi, fu dedicato un tempio presso Metalla, restaurato all’inizio del III d.C., mentre la sua immagine ritorna propagandisticamente sulle enigmatiche monete di M. Atius Balbus.
Gli apporti etnici africani erano ben noti, se i mitografi classici registravano un nuovo arrivo di popoli libici, evidentemente via mare, dopo Aristeo (passato da Cirene), Norace, Dedalo ed i Troiani: infatti una moltitudine di Libii avrebbe raggiunto l’isola con una forte flotta, sterminando quasi completamente i Greci che vi si trovavano e costringendo i Troiani a ritirarsi sui monti dell’interno ed a proteggersi in zone quasi inaccessibili. Ancora nel II secolo d.C. essi si chiamavano Iliei, «assai simili nell’aspetto e nell’apparato delle armi ed in tutto il tenore di vita ai Libii».
Al di là del mito, può essere sostanzialmente condivisa la realtà di forti e significativi contatti tra l’Africa numida e la Sardegna nuragica: queste relazioni indubbiamente si intensificarono con l’arrivo dei Fenici e, in epoca ormai storica, con la dominazione cartaginese, per la quale si pongono problemi d’interpretazione più facilmente risolvibili da archeologi e storici.
L’integrazione culturale tra Africa e Sardegna continuò in maniera notevole nei secoli successivi: la romanizzazione della grande isola mediterranea conobbe indubbiamente fasi comuni rispetto alle province africane, in relazione – se non si vuole pensare ad una simile matrice etnica – alla situazione geografica e soprattutto all’uguale esperienza punica, vissuta rispettivamente su un sostrato nuragico e libio-numida.
Un capitolo importante in questa problematica è rappresentato dalla sopravvivenza di modelli costituzionali cartaginesi e di tradizioni puniche nell’organizzazione delle città della Sardegna romana, durante gli ultimi secoli della repubblica e dell’impero: sappiamo che le promozioni giuridiche delle civitates indigene dell’isola non datano ad epoca precedente a Cesare; è da presumere che tutte le città e le popolazioni rurali abbiano dunque continuato ad amministrarsi secondo le norme del diritto pubblico punico, che sopravvisse in alcuni casi fino al II-III secolo d.C. se non oltre.
Il caso più significativo è dato dalle attestazioni (quasi esclusivamente in iscrizioni puniche o neo-puniche) della magistratura dei sufeti in numerose città sarde anche molti anni dopo la costituzione della provincia romana, a tre-quattro secoli dalla distruzione di Cartagine: citeremo in particolare i casi di Karales, di Sulci, di Neapolis, di Tharros e di Bitia.
L’unica attestazione non epigrafica ed in lingua latina è quella della moneta di bronzo con la rappresentazione al diritto di due ritratti (Cesare ed Ottaviano ?) con la leggenda Aristo Mutumbal Ricoce suf(etes); al rovescio compare un tempio con la scritta Veneris Kar(ales). In passato il documento è stato riferito a Kar(thago) ed utilizzato per supporre che nella colonia fondata da Cesare accanto ai duoviri romani operassero i sufeti, a capo di una comunità indigena subito aggregatasi alla città dedotta nel 44 a.C. e poi rinforzata da Ottaviano nel 29 a.C.; in questo senso si è parlato, anche per Cartagine, di un’improbabile doppia comunità romano-punica; il collegamento con Cesare e poi con Ottaviano parrebbe assicurato dal riferimento a Venere, madre di Enea, capostipite degli Iulii.
E’ stato però ampiamente dimostrato che la moneta, della quale sono numerosi gli esemplari rinvenuti in Sardegna, si riferisce non a Cartagine ma a Kar(ales), una città ugualmente collegata a Cesare o ad Ottaviano, in quanto municipium Iulium. Nel nostro caso i due sufeti attestano più che l’esistenza di una doppia comunità sardo-romana, il momento del passaggio dalla civitas indigena all’organizzazione romana del municipium; Aristo e Mutumbal Ricoce, i cui nomi sono sicuramente punici, sarebbero quindi i magistrati che si trovarono a gestire tra il 46 ed il 36 a.C. il delicato processo di transizione costituzionale dalle forme sardo-puniche alle nuove strutture romane; in questo senso essi furono gli ultimi sufeti della civitas, sostituiti poco dopo dai quattuorviri del municipio.
L’abbandono delle forme costituzionali sardo-puniche avvenne dunque in Sardegna molto tardi, a partire dalla seconda metà del I secolo a.C.; in alcuni casi, particolarmente periferici e conservativi, le strutture indigene furono mantenute in piena età imperiale (fino a quattro-cinque secoli dalla caduta di Cartagine): è noto il caso di Bitia, città per la quale ci è rimasta una dedica all’imperatore Marco Aurelio Antonino (169-180 d.C.), che è stata anche riferita, con meno probabilità, a Caracalla (212-217), dove è ricordata la realizzazione di una serie di opere pubbliche, nell’anno individuato dai due sufeti bb’l (Bodbaal ?) ‘il romano’ ed un collega anonimo [—]h.
Questo tipo di documentazione trova adeguato confronto soltanto in Africa, dove le città sufetali sono attestate a partire da Cesare (p. es. Curubis), fino alla piena età imperiale, nelle iscrizioni latine; si tratta di «persistenze» di istituzioni puniche o di «sopravvivenze» ereditate da Cartagine più o meno direttamente (sono attestate anche nei territori dell’antico regno di Numidia). In Africa come in Sardegna le testimonianze riguardano il più delle volte quei centri per i quali si può ipotizzare un’originaria colonizzazione fenicia: gli ultimi rinvenimenti epigrafici avvenuti recentemente in Tunisia non modificano ma anzi confermano questo quadro.
Per la Sardegna avrà pesato sicuramente l’insularità, il senso d’isolamento di alcune comunità dalla lontana ascendenza fenicio-punica, vere e proprie énclaves in territorio romano, la fedeltà a tradizioni che in Africa contemporaneamente dimostravano tutta la loro vitalità. Pare probabile che una così lunga sopravvivenza sia stata favorita dai nuovi apporti, dai successivi contatti e dai continui scambi culturali con l’Africa, che consentivano verifiche, conferme e ulteriori convergenze.
Siamo scarsamente informati sulle caratteristiche della religiosità tradizionale nella Sardegna nuragica, che qualche esito avrà sicuramente avuto in epoca punica e romana. L’unica divinità veramente «indigena», per quanto reinterpretata a posteriori, fu il Sardus Pater, eroe-fondatore giunto nell’isola con una schiera di Libii. Un’iscrizione rinvenuta in Tunisia in località Henchir el-Ksar (presso l’antica Thignica) conterrebbe, secondo un’improbabile ipotesi di A. Dupont Sommer, una dedica Sar(do Patri) Aug(usto); in realtà per quanto suggestiva, questa proposta andrà abbandonata e, se non si può pensare a Serapide per gli attributi e la simbologia presenti sulla stele, dovrà ipotizzarsi una dedica a Saturno, che intenderei Sa(tu)r(no) Aug(usto), piuttosto che supporre l’esistenza di una divinità africana sconosciuta.
Per ciò che riguarda invece la Sardegna, sorprendono le sopravvivenze della religiosità punica in epoca romana: così come per l’Africa, si può parlare di fenomeni di sincretismo e di sviluppo di particolarismi nella vita religiosa, non ostacolati dall’autorità romana: si è già detto di Sid Babi (figlio di Melqart e di Tanit ?), venerato ad Antas, ricordato in una ventina di iscrizioni puniche tra gli inizi del V e la fine del II secolo a.C. ed ora anche in una iscrizione latina; a Sulci è attestato il signum Sidonius, sicuramente connesso con questa divinità; si tratta con tutta probabilità di un culto sovrapposto ad una devozione più antica per un’analoga figura paleosarda, influenzata comunque da Baal-Hammon e proseguita in età imperiale con altre forme.
Dopo l’occupazione romana furono praticati in Sardegna anche i culti di Tanit, già presente sulle monete sardo-puniche, che aveva un tempio a Sulci; di Bashamen (b’l smm, signore dei cieli), ricordato a Karales nel III secolo a.C.; di Melqart, venerato a Tharros nel III-II secolo a.C.; di Eshmun Merre, identificato con Asclepio ed Esculapio nella famosa trilingue di San Nicolò Gerrei attorno al 150 a.C., al quale vanno forse riferite le statue del così detto Bes; di Ashtart che a Karales ebbe nel III secolo a.C. un altare di bronzo.
Anche il culto di Demetra e Kore, introdotto dai Cartaginesi, presenta nell’isola peculiari caratteristiche, per essere associato (a Terreseu), ancora nel III secolo d.C. a sacrifici cruenti. E’ stato già osservato che i busti fittili di Cerere, tanto diffusi in Sardegna, sono eredi dei thymiateria punici.
Il dio africano per eccellenza, Saturno, è forse attestato un’unica volta in Sardegna, nella dedica S(aturno) A(ugusto) s(acrum) conservata al Museo di Marsiglia e pubblicata nel CIL VIII erroneamente come proveniente da Cartagine; si tratta di un ex voto posto da C. Aburrius Felix Aburrianus, che meno probabilmente ricorda Serapide.
Lascerei da parte le numerose divinità d’origine egiziana rappresentate su amuleti e scarabei ancora fino al I secolo a.C., il culto di Giove Ammone attestato a Turris Libisonis e soprattutto di quello di Iside e di Serapide fin dal 35 d.C.
Una serie di rapporti tra Karales, Lilybaeum e Cartagine sono attestati ad esempio per il culto di Venus Erycina.
Anche da un punto di vista etnico, la popolazione che abitava la Sardegna aveva notevoli affinità con i libio-punici africani: per quanto avvelenate dalla polemica giudiziaria, le affermazioni di Cicerone, pronunciate in occasione della difesa di M. Emilio Scauro, il governatore del 55 a.C., accusato dai Sardi di concussione e di altri reati, contengono molte verità. L’appellativo Afer è ripetutamente usato da Cicerone come equivalente di Sardus; Cicerone rimprovera ai Sardi le loro origini africane e sostiene la tesi che la progenitrice della Sardegna è stata l’Africa. L’espressione Africa ipsa parens illa Sardiniae suggerisce secondo il Moscati la realtà di una «ampia penetrazione di genti africane ed il carattere coatto e punitivo della colonizzazione o, meglio, della deportazione».
Numerose altre fonti letterarie e le testimonianze archeologiche confermano già in epoca preistorica la successiva immissione di gruppi umani arrivati dall’Africa settentrionale, fino alle più recenti colonizzazioni puniche. Gli incroci di razze diverse che ne erano derivati, secondo Cicerone, avevano reso i Sardi ancor più selvaggi ed ostili; in seguito ai successivi travasi, la razza si era «inacidita» come il vino, prendendo tutte quelle caratteristiche che le venivano rimproverate: discendenti dai Cartaginesi, mescolati con sangue africano, relegati nell’isola, i Sardi secondo Cicerone presentavano tutti i difetti dei Punici, erano dunque bugiardi e traditori, gran parte di essi non rispettavano la parola data, odiavano l’alleanza con i Romani, tanto che in Sardegna non c’erano alla metà del I secolo a.C. città amiche del popolo romano o libere ma solo civitates stipendiariae.
L’ipotesi che fasce etniche insediate in Sardegna, originarie del Nord Africa, appartenessero a strati piuttosto bassi della popolazione è stata formulata da Sandro Bondì sulla base della totale mancanza, nei villaggi dell’interno, di carattere fondamentalmente rurale, di attestazioni scritte in lingua punica, che rimangono dunque appannaggio dei soli centri maggiori.
La deportazione in Sardegna di genti straniere (Africani in particolare) è variamente attestata anche per l’età successiva a Cicerone. In epoca vandalica, per decisione del re Unnerico, dopo il concilio di Cartagine del 484 d.C., furono deportati in Corsica e probabilmente in Sardegna numerosi vescovi africani di fede cattolica, che furono però subito richiamati in patria da Gundamondo. Ancor più significativo è l’esilio, deciso nel 507 dal re vandalo Trasamondo, di numerosi ecclesiastici africani ostili all’arianesimo, forse oltre duecento, tra i quali il monaco Fulgenzio, vescovo di Ruspe, e Feliciano, vescovo di Cartagine. Questi esuli africani, che ben presto si sparpagliarono nell’isola (solo un piccolo gruppo forse di 14 vescovi restò a Karales) e che si trattennero fino al 523, allorché furono richiamati da Ilderico, diedero un apporto decisivo per la rinascita culturale della Sardegna; abbiamo notizia di dispute teologiche e di tecniche liturgiche tipicamente africane; si svilupparono alcuni cenobi e fu avviato un significativo rilancio dell’edilizia religiosa, fortemente influenzata dai modelli africani.
Non fu forse il vescovo di Ippona (come pure si sosteneva, secondo un’interpretazione che oggi appare superata), esiliato dai Vandali in quest’occasione, colui che portò con sé a Karales le spoglie di S. Agostino, che invece sembra giungessero nell’isola alla vigilia dell’occupazione araba, alla fine del VII secolo. Le preziose reliquie rimasero in Sardegna fino al 721-725, allorché furono riscattate e traslate a Pavia, per iniziativa dal re longobardo Liutprando, preoccupato per gli attacchi che ormai annualmente gli Arabi muovevano contro la Sardegna.
A parte le deportazioni, la popolazione della Sardegna romana appare notevolmente composita. Per quanto riguarda gli immigrati d’origine africana, si ricorderà nella colonia di Uselis (oggi Usellus) un [I]ulius Lu[cia(?)]nus, Utice[nsi]s, forse originario di Utica in Africa (o di Othoca in Sardegna), morto a 15 anni d’età.
La presenza di popolazioni africane stanziate nell’isola è desumibile anche dai numerosi cippi di confine che attestano, alla fine dell’età repubblicana, una vasta operazione di centuriazione nella Sardegna centro-occidentale, nell’area che era stata interessata nel 215 a.C. dalla rivolta di Ampsicora: la limitatio che fu allora effettuata (con una prima fase forse già alla fine del II secolo a.C.) ha notevoli affinità con uguali operazioni che si svolsero in tempi diversi in Africa sul limes o anche all’interno della provincia, con lo scopo di accellerare il processo di sedentarizzazione delle tribù nomadi e di favorire lo sviluppo agricolo; i nomi degli Uddadhaddar Numisiarum, dei [M]uthon(enses) Numisiarum, dei Giddilitani hanno puntuali confronti con l’Africa punica. Gli Aichilensioi, ricordati in prossimità di Cornus, sono stati avvicinati alla città di Acholla in Byzacena. Più dubbio è un collegamento dei Rubr(enses) sardi, ricordati a Barisardo al confine con gli Altic(ienses) ed identificati con i Roubrensioi di Tolomeo, che difficilmente possono esser messi in rapporto con i Rubrenses, martirizzati in Africa il 17 gennaio di un anno incerto, menzionati dal Martirologio Geronimiano.
Una cohor(s) Maur(orum) et [A]frorum, dunque costituita inizialmente con contingenti arruolati in Mauretania ed in Africa Proconsolare secondo l’interpretazione più probabile, è attestata a Cagliari nella carriera di Sex(tus) Iul[ius Sex(ti) f(ilius) Qui]r(ina tribu) [Fe]lix, IIIIv[ir ae]d(ilicia) pote[s(tate)], che è ricordato come [pr]aef(ectus) cohor(tis) Maur(orum) et [A]frorum ed anche come IIIIvir iure [dicun]d(o) iterum. Si trattava evidentemente di un alto magistrato del municipio di Karales che aveva ricoperto tra il quattorvirato aedilicia potestate e quello iure dicundo (quest’ultimo per due volte) la prefettura della coorte: si discute sulla provincia nella quale il nostro personaggio (appartenente all’ordine equestre) svolse il suo servizio militare; sembra accettabile pensare alla Sardegna, come da tempo suggerito da P. Meloni, ora anche alla luce dell’integrazione di alcune lacune proposta da F. Porrà; proprio a Karales del resto sarebbero stati ricoperti anche i due sacerdozi cittadini, l’augurato ed il pontificato.
Tra gli Africani che visitarono l’isola, si citeranno alcuni funzionari d’età imperiale, che giungevano in Sardegna accompagnati da un seguito più o meno numeroso; il caso più significativo è quello di Settimio Severo, il futuro imperatore, che attorno al 173 ricoprì l’incarico di questore propretore nell’isola, dove giunse da Leptis Magna, sua città natale; Severo si era recato in Tripolitania, per sistemare alcune faccende familiari, dopo la morte del padre, prima di ricoprire l’incarico di questore in Betica. Il viaggio verso la penisola iberica gli fu impedito da una rivolta di Mauri, arrivati dall’Africa, che aveva suggerito all’imperatore Marco Aurelio il temporaneo passaggio della provincia spagnola dall’amministrazione senatoria a quella imperiale.
Non furono pochi i funzionari giunti in Sardegna per un soggiorno provvisorio, che avevano avuto modo di conoscere in precedenza le province africane.
E’ significativa l’attestazione ad Ostia dei navicul(arii) et negotiantes Karalitani, assieme ai navic(ularii) Turritani e ad una serie di navicularii di città africane: presso il teatro, nel così detto Piazzale delle Corporazioni, questi armatori avevano i propri uffici di rappresentanza, in un’epoca che è stata fissata tra il 190 ed il 200, comunque alla fine del II secolo, forse durante il regno di Settimio Severo.
Non si dimentichi che Commodo aveva riorganizzato i navicularii, costituendo una vera e propria flotta (classis Africana Commodiana), con sede a Cartagine, finalizzata a garantire l’approvvigionamento granario della capitale.
Qualche anno prima, nel 173 d.C., dunque durante il principato di Marco Aurelio, i domini navium Afrarum universarum (ai quali si erano aggiunti in un secondo tempo i rappresentanti dei domini sardi: item Sardorum), avevano dedicato ad Ostia una statua in onore di M. Iulius M. f. Pal. Faustus, duoviro, patronus cor[p(oris)] curatorum navium marinar[um]. Dunque gli armatori africani si erano associati, almeno temporaneamente, tra loro e con colleghi sardi; che la merce che veniva trasportata fosse soprattutto frumento è assicurato dal fatto che il personaggio in onore del quale fu dedicata la statua è indicato esplicitamente come mercator frumentarius.
Per l’epoca di Diocleziano, un nuovo frammento dell’edictum de pretiis del 301 ha consentito di accertare che esistevano almeno quattro rotte le cui tariffe erano sottoposte al calmiere, con partenza dalla Sardegna, terminanti rispettivamente forse a Roma, a Genua, in Gallia ed in Africa.
Le testimonianze fin qui presentate costituiscono solo un campione, del tutto parziale a causa della frammentarietà delle notizie pervenuteci, dell’apporto etnico africano nella Sardegna romana; eppure l’impressione che se ne ricava è quella di una continuità di immigrazioni in epoche successive tale da giustificare il giudizio che, ormai alla metà del XII secolo, fu espresso dall’arabo Edrisi di Ceuta: «i Sardi sono di schiatta Rum ‘afariqah berberizzanti, rifuggenti dal consorzio di ogni altra nazione di Rum»; il “fondo” etnico della razza sarda formatosi da età preistorica ma confermato in età romana, era dunque berbero-libico-punico.
Ugualmente significativa è la presenza in Africa di numerosi immigrati provenienti dalla Sardegna. Il nucleo più cospicuo fu certamente costituito dai militari arruolati in reparti ausiliari o nella legio III Augusta, accasermati nella Mauretania Cesariense oppure in Numidia. Si trattava di una destinazione tradizionale, dal momento che la presenza di mercenari originari dalla Sardegna è ampiamente documentata negli eserciti punici fin dal V secolo a.C.
Sarebbero state le caratteristiche bellicose dei Sardi dell’interno a consigliare la costituzione della cohors II Sardorum e della cohors I Nurritanorum, reparti arruolati in Sardegna e quindi dislocato almeno all’inizio del II secolo in Mauretania Cesariense o in Numidia. Come località di provenienza originaria per gli ausiliari di questo reparto c’è da pensare alla Barbaria ed in particolare alla regione confinante con il Marghine-Goceano, immediatamente al di là del Tirso. Come è noto, un cippo di confine dei Nurr(itani) è stato rinvenuto in località Porgiolu, in agro di Orotelli (Nuoro); al di qua del fiume sembra siano da localizzare gli Ilienses. Connessi all’attività di queste coorti e alla presenza di sardi nella legio III Augusta tra Ammaedara-Haidra, Lambaesis e Theveste potrebbero essere alcuni dei Sardi ricordati in Africa in età imperiale. Meno significativi sono altri casi (a Cuicul e ad Hadrumetum), nei quali il cognome Sardus non sembra attestare espressamente un collegamento con l’isola.
Sono stati da me presentati in passato alcuni dei parametri che possono essere utilizzati per delineare, lungo un ampio arco cronologico, i rapporti tra la Sardegna e le province romane del Maghreb: queste convergenze, fondate su una consuetudine che risale almeno ad età fenicio-punica, si alimentarono con ripetuti significativi scambi di popolazione ed in particolare con la presenza di deportati e di immigrati africani in Sardegna, di militari e di civili sardi nel Nord-Africa. La romanizzazione si sviluppò perciò in modo analogo, specie per le affinità strutturali dell’economia e più precisamente dell’agricoltura di queste province, collegate da un intenso traffico commerciale e spesso associate anche nel destino politico. La sopravvivenza di elementi culturali punici ed indigeni si manifestò in Sardegna come in Africa nelle istituzioni cittadine, nella vita religiosa, nella lingua e nell’onomastica; la documentazione epigrafica conferma ulteriori successive convergenze.
Con l’occupazione bizantina avvenuta nel 533 sotto il comando del duca Cirillo, la Sardegna divenne una delle province africane di Giustiniano, organizzate in prefettura e successivamente in esarcato; siamo ormai cronologicamente fuori dal periodo che è oggetto di quest’intervento: eppure non potrà omettersi che la conquista araba di Cartagine avvenuta nel 698 (vanamente contrastata da un esercito bizantino, forse integrato da elementi sardi), provocò il distacco politico della Sardegna dall’Africa, ma non interruppe gli scambi culturali. A parte i numerosi profughi africani che si rifugiarono nell’isola prima dell’arrivo degli Arabi (nell’occasione furono trasferite a Karales da Ippona le reliquie di Sant’Agostino), le spedizioni inviate da Tunisi fin dal 705 tentarono senza successo di togliere la Sardegna ai Bizantini; con i prigionieri che allora furono catturati nell’isola, nel 733 fu fondato un centro Sardaniyan nel Maghreb.
Gli elementi in nostro possesso sono eterogenei e di diversa qualità: eppure, per quanto alcune categorie utilizzate possano essere generiche ed interpretabili in maniera diversa, l’abbondanza stessa delle testimonianze, pur con significative oscillazioni nel tempo, è tale da render certi che non può più essere sottovalutata la componente «africana» della storia della Sardegna antica, nel quadro di una più ampia vocazione «mediterranea», che costituì la vera specificità isolana.
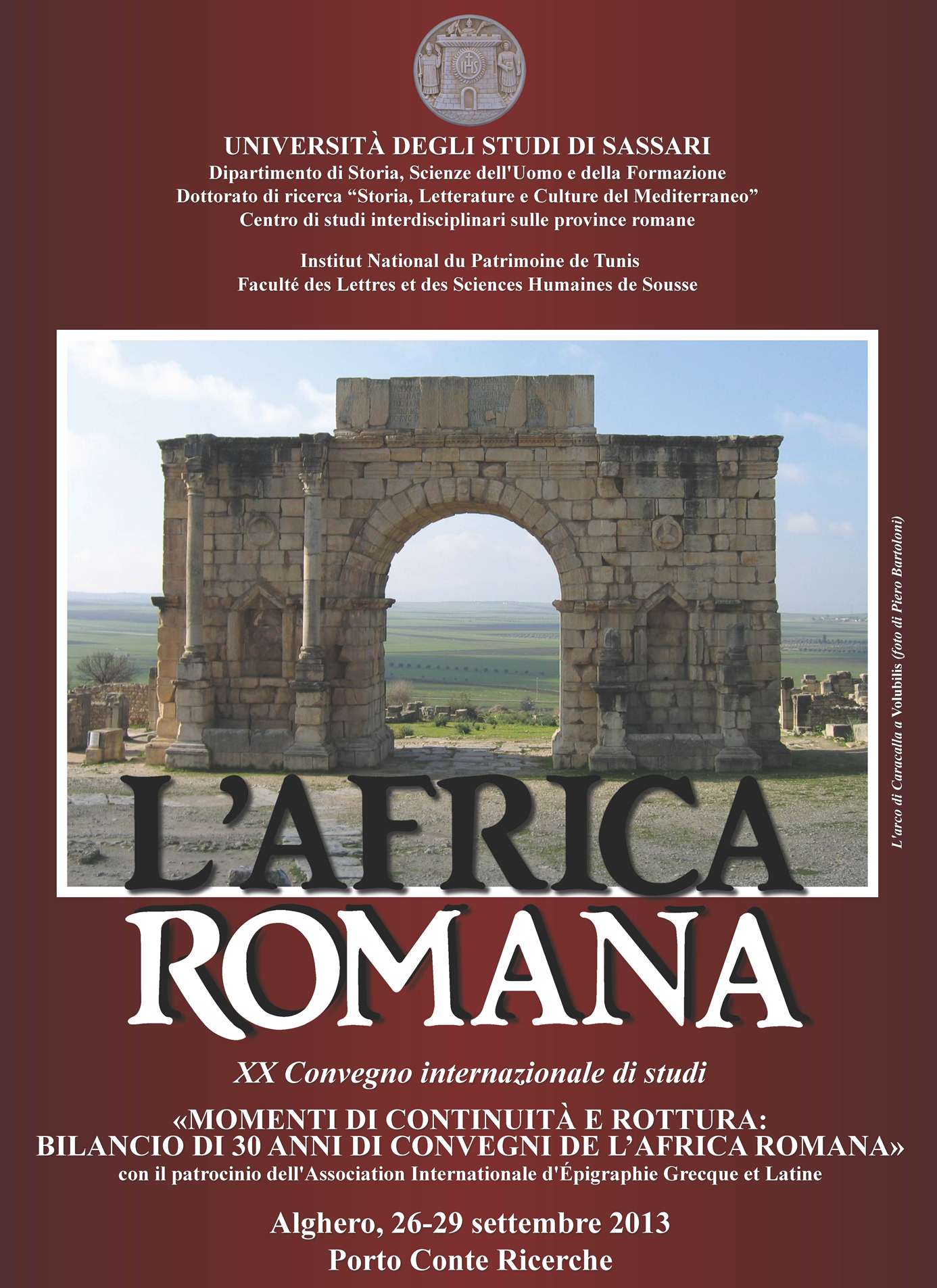
 Santità,
Santità,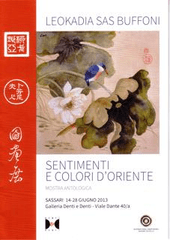 Attraverso le opere di Leokadia Sas Buffoni riscopriamo oggi sentimenti e colori d’oriente, con i profumi, i sapori, le sensazioni di un mondo lontano che amiamo soprattutto per il mistero. Complessivamente questi 25 pezzi (un paravento, 6 rotoli, molte altre opere su carta di riso e in seta) ci presentano una visione della vita che è innanzi tutto fondata sulla serenità, sull’equilibrio, sulla pace: il primo pannello contiene un richiamo ai principi della filosofia Tao, che ci rimanda al vecchio maestro Lao Tzou e al VI secolo a.C., per i quale la via per comprendere il sistema del Taoismo passa su un’armonia del mondo fondata su tre diverse prospettive, che incanalano desideri e risonanze, l’universo, la terra, l’uomo.
Attraverso le opere di Leokadia Sas Buffoni riscopriamo oggi sentimenti e colori d’oriente, con i profumi, i sapori, le sensazioni di un mondo lontano che amiamo soprattutto per il mistero. Complessivamente questi 25 pezzi (un paravento, 6 rotoli, molte altre opere su carta di riso e in seta) ci presentano una visione della vita che è innanzi tutto fondata sulla serenità, sull’equilibrio, sulla pace: il primo pannello contiene un richiamo ai principi della filosofia Tao, che ci rimanda al vecchio maestro Lao Tzou e al VI secolo a.C., per i quale la via per comprendere il sistema del Taoismo passa su un’armonia del mondo fondata su tre diverse prospettive, che incanalano desideri e risonanze, l’universo, la terra, l’uomo.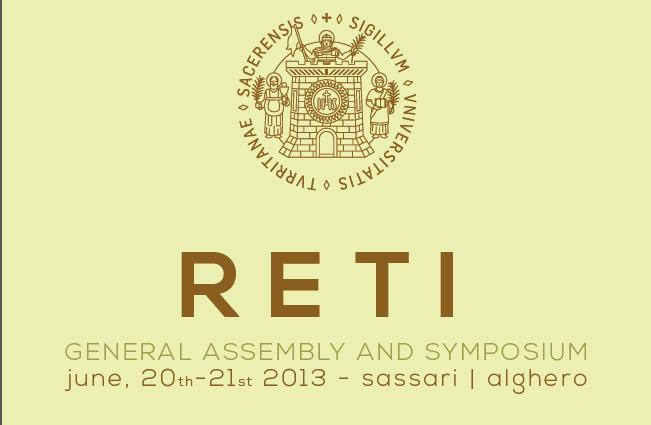 è con emozione e vivo interesse che a nome dell’Università di Sassari accogliamo a Porto Conte il Réseau d’excellence des territoires insulaires in occasione dell’assemblea generale e del Symposium I mari delle isole.
è con emozione e vivo interesse che a nome dell’Università di Sassari accogliamo a Porto Conte il Réseau d’excellence des territoires insulaires in occasione dell’assemblea generale e del Symposium I mari delle isole. Per volontà dell’Arcivescovo e della famiglia, ho l’onore di intervenire a nome dei colleghi, del personale e degli studenti dell’Università di Sassari per accogliere con emozione e con affetto vero il nostro Rettore emerito Giovanni Palmieri che ci lascia per sempre. Il coro ICNVSS lo ha salutato all’ingresso con il Gaudeamus igitur, che spesso cantava a squarciagola per farci sorridere.
Per volontà dell’Arcivescovo e della famiglia, ho l’onore di intervenire a nome dei colleghi, del personale e degli studenti dell’Università di Sassari per accogliere con emozione e con affetto vero il nostro Rettore emerito Giovanni Palmieri che ci lascia per sempre. Il coro ICNVSS lo ha salutato all’ingresso con il Gaudeamus igitur, che spesso cantava a squarciagola per farci sorridere. l’accogliamo con emozione e simpatia in questa aula magna, a pochi mesi dalla conclusione delle celebrazioni per i 450 anni dalla nascita del Collegio Gesuitico che si sono svolte tra l’altro con la visita del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e del Presidente della Camera allora in carica Gianfranco Fini.
l’accogliamo con emozione e simpatia in questa aula magna, a pochi mesi dalla conclusione delle celebrazioni per i 450 anni dalla nascita del Collegio Gesuitico che si sono svolte tra l’altro con la visita del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e del Presidente della Camera allora in carica Gianfranco Fini.