L’Epigrafia latina nelle province danubiane negli ultimi 15 anni (2000-2015)
Vienna, 10 novembre 2015, Istituto Italiano di cultura
3rd International Conference on Roman Danubian Provinces
di Attilio Mastino (Testo letto da Angela Donati.)
 1.L’epigrafia provinciale. 2. Lo specifico epigrafico. 3. La lunga conquista. 4. Questa rassegna. 5. Storia degli studi. 6. Nuove acquisizioni sui governi provinciali. 7. La storia: novità sui viaggi imperiali. 8. Recenti acquisizioni sui fasti provinciali. 9. La municipalizzazione. 10. Alcuni populi e nationes. 11. Gli immigrati. 12. Opere pubbliche. 13. L’esercito: legioni, coorti, alae, flotta. 14. Miniere e dogane. 15. La vita religiosa. 16. Le articolazioni e le festività del culto imperiale. 17. Conclusioni
1.L’epigrafia provinciale. 2. Lo specifico epigrafico. 3. La lunga conquista. 4. Questa rassegna. 5. Storia degli studi. 6. Nuove acquisizioni sui governi provinciali. 7. La storia: novità sui viaggi imperiali. 8. Recenti acquisizioni sui fasti provinciali. 9. La municipalizzazione. 10. Alcuni populi e nationes. 11. Gli immigrati. 12. Opere pubbliche. 13. L’esercito: legioni, coorti, alae, flotta. 14. Miniere e dogane. 15. La vita religiosa. 16. Le articolazioni e le festività del culto imperiale. 17. Conclusioni
1.L’epigrafia provinciale.
Dopo Ferrara e Cento, Livio Zerbini mi ha nuovamente coinvolto chiedendomi di intervenire a questa 3rd International Conference on the Roman Danubian Provinces (Society and Economy), prevalentemente dedicata all’epigrafia, promossa dal Laboratorio della sua Università d’intesa con l’Institut für Alte Geschichte und Altertumskunde, Papyrologie und Epigraphik Wien (Fritz Mitthof e Theresia Pantzer). Allora lasciatemi dire la gratitudine per l’onore che mi viene fatto e l’ammirazione per il lavoro portato avanti in questi anni dal “Laboratorio sulle province danubiane di Ferrara”, che in qualche modo collabora in parallelo con il nostro “Centro di studi interdisciplinari sulle province romane” dell’Università di Sassari fondato 25 anni fa, con attenzione al tema delle specificità regionali e locali nel quadro del generale fenomeno della romanizzazione, coordinando gruppi di studiosi e proponendo una cooperazione interdisciplinare e internazionale sulla cultura, l’urbanizzazione, l’economia, la vita religiosa di un impero mediterraneo divenuto spazio di contatto, di cooperazione, di integrazione fra popoli differenti. Negli ultimi anni il Laboratorio di Ferrara, in una linea di continuità con antichi indirizzi di studi dell’Università di Bologna, è riuscito sempre più a porsi progressivamente come punto di riferimento per la cooperazione scientifica internazionale, tra archeologia, epigrafia, numismatica, storia delle religioni; è diventato un prezioso strumento per allargare l’indagine in ambito continentale e per costruire nuove reti di ricercatori[1].
Il volume del II Convegno internazionale dedicato a Culti e religiosità nelle province danubiane, pubblicato nel 2015 dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Ferrara, si concentra sulla vita religiosa attraverso i contributi di alcuni dei più autorevoli ricercatori del mondo danubiano in età romana, provenienti da quindici Paesi. Gli esiti delle ultime ricerche mettono sempre più in evidenza che il mondo provinciale danubiano non costituisce un organismo uniforme e omogeneo, in quanto ogni provincia è caratterizzata da una propria identità che è andata maturando nel tempo, i cui tratti specifici meritano di essere ulteriore indagati e studiati[2].
L’esigenza di distinguere la storia delle province dalla storia di Roma, le sue fonti, i suoi orizzonti, le sue relazioni, è dovuta alla necessità di far emergere le specificità regionali, le persistenze indigene, gli apporti originali che le differenti realtà nazionali e locali hanno espresso all’interno dell’impero romano. Questo tipo di analisi, che nel rapporto tra centro e periferia valorizza gli apporti specifici delle diverse province e supera il tema dell’egemonia e dell’imperialismo rilevando il ruolo fondamentale della geografia nella storia, è stata definita già in occasione del Colloquio di Cluj-Napoca del settembre-ottobre 2006. Ho potuto rileggere lo splendido volume degli Atti che mi è stato donato animo grato da Ioan Piso, per conto del Centrul de Studii Romane dell’Universitatea “Babeş-Bolyai” e del Muzeul Naţional de istorie a Transilvaniei[3]: un volume di sintesi che poneva il tema della flessibilità romana nella creazione di nuove province e insieme si soffermava ad analizzare aspetti specifici relativi alla storia provinciale romana. Per quanto ci riguarda in questa sede, con riferimento alla Rezia (C. Sebastian Sommer), al Norico (Ekkehard Weber), all’Illirico (Péter Kovács), alla Mesia (Miroslava Mirković, Costantin C. Petolescu, Florian Matei-Popescu), alla pianura della Dobrugia tra le attuali Romania e Bulgaria alla foce del Danubio (Alexandru Suceveanu), alle Pannonie (Eduard Nemeth), soprattutto alla Dacia (Gelu Florea, Paul Puppeză, Viorica Rusu-Bolindeţ, Barnabás Lőrincz, Ioan Piso), tutti studiosi che hanno animato il fervido dibattito storiografico sull’epigrafia e la storia delle province danubiane fino ad oggi. È particolarmente la Dacia la provincia per la quale in questi ultimi anni viene rapidamente colmato un ritardo storico di conoscenze e di dati, anche per merito dei nostri colleghi italiani[4]. Nel frattempo abbiamo maturato una coscienza nuova sul tema della diversità delle società provinciali, delle distinte identità e appartenenze, dell’assoluta inadeguatezza di formule astratte e di categorie interpretative capaci di definire nel tempo e nello spazio processi che hanno determinato eterogenee trasformazioni politiche, economiche, sociali, culturali, fortemente condizionate dalla geografia, dalla distanza, dall’impegno di Roma in una provincia. Del resto è nostro dovere evitare di ingabbiare in schemi precostituiti una realtà complessa, vivace, articolata, che va molto al di là delle formule e che aderisce a situazioni locali ancorate a tradizioni, ad ambienti culturali e territoriali, all’evoluzione diacronica sempre in rapporto con l’ambiente circostante. Non ci sono formule semplici per definire realtà complesse. Eredità dell’ellenismo, è evidente il progressivo affermarsi di una realtà culturale nuova che attraversa tutto l’impero, una “Romanitas” che oggi appare assai differenziata, fondata soprattutto nelle regioni di frontiera su un controllo militare che si innestò con il processo di urbanizzazione[5] e le promozioni giuridiche di intere comunità peregrine a livello municipale[6], il coinvolgimento delle popolazioni locali, la scelta strategica di stabilizzare i territori[7], la promozione dell’evergetismo cittadino[8]; il controllo militare fu incardinato su singoli avamposti che controllavano i flussi di uomini, animali, merci da e per l’impero. Sullo sfondo rimangono i temi ambientali che emergono con prepotenza, il paesaggio, la flora, la fauna, come da ultimo a proposito della caccia al bisonte d’Europa sui Balcani documentato dall’iscrizione di Montana in Mesia Inferiore[9]. Quindi gli aspetti amministrativi legati alla conquista e alla provincializzazione, il governo, gli avvenimenti storici riflessi sulle pietre.
Partecipano ai nostri lavori alcuni maestri, molti giovani ricercatori, molti studiosi provenienti da numerose università europee, che ci condurranno per mano a ricostruire i paesaggi antichi delle province danubiane, con relazioni che investiranno aspetti storici, epigrafici, archeologici, topografici di un’area vasta che si affaccia sul grande fiume, alla quale guardiamo con rinnovato interesse, alla ricerca delle origini della cultura europea, ritrovando radici comuni e percorsi storici convergenti. Il nostro mestiere di storici del mondo antico deve sempre di più renderci consapevoli dell’importanza e della vitalità dell’eredità dell’antico nel mondo che viviamo e insieme deve farci cogliere il senso della responsabilità di un impegno di ricerca che si proietti nella costruzione di un futuro comune. I nostri lavori consentiranno di colmare fossati, di abbattere steccati antichi e muri moderni e di trovare una strada insieme, soprattutto promettono uno sviluppo di rapporti tra Paesi diversi, tra Università, tra scuole, tra metodi di indagine, nella direzione che porta verso il consolidamento di una rete di relazioni che immaginiamo intensa e vitale, capace di avviare un fortissimo rinnovamento di metodi e di modelli culturali su un’area vasta, complessa, piena di fermenti nuovi.
Proprio lungo le frontiere danubiane la cultura politica romana produsse efficaci modelli di organizzazione civica: fondazioni di colonie, istituzioni municipali, governi per territori con specifiche identità etno-culturali ed economiche mentre «l’urbanizzazione fece passi considerevoli, anche con l’affiancamento di nuove città ad impianti castrensi, specie sul limes». Parlando al convegno sul Limes svoltosi nel 1989 a Svishtov, l’antica Novae, alla vigilia della caduta del muro di Berlino che segnava la fine di quella che era stata la cortina di ferro del secondo dopoguerra, Giancarlo Susini volle ribadire che il Limes romano non fu soltanto una barriera, ma anche una soglia, un liminare da varcare per entrare di là, e una strada di terra e magari di fiume, che raccordava “a valle” singoli entroterra per farli comunicare, una via maestra, insomma, che tale si potrebbe definire perché tramite primario dei transiti e delle conoscenze, e perché straordinario fattore di omologazione tra le culture che, dai lati della via, vi confluivano[10]. Oggi tante cose sono più chiare, intorno alle funzioni diverse che il limes ha svolto nel tempo, all’attività di legioni, coorti, alae, numeri, alla edificazione di castra e di fortificazioni come burgi e praesidia militari, ad esempio come quelli in Pannonia Inferiore per iniziativa del prefetto del pretorio Tigidius Perennis, nell’età di Commodo[11]; o quelli sul basso Danubio in età tardo antica presentati nella sintesi di D. Bondoc[12].
Sono ora disponibili numerosi lavori sull’archelogia e l’epigrafia delle province danubiane in atti di convegni, come quello bulgaro di Veliko Tărnovo del luglio 2000 per il centenario degli scavi di Nicopolis, con particolare attenzione anche per Novae[13]; il volume udinese Roma sul Danubio del 2002[14]; la Giornata di studio del settembre 2008 a Ratisbona[15]. Consentitemi di citare infine il volume di D. Boteva-Boyanova, L. Mihăilescu-Bîrliba e O. Bounegru, pubblicato nel 2012, Pax Romana, dedicata alla cultura e all’economia nelle province danubiane, con gli Atti del Convegno di Varna e Tulcea del 2008[16].
Ma anche questo terzo convegno viennese appare ricchissimo soprattutto per la parte epigrafica. Proprio per questa ragione ci siamo dedicati a raccogliere un quadro, per quanto rapido e per saltus, delle scoperte e riscoperte epigrafiche effettuate dal 2000 ad oggi nelle province danubiane: un periodo di 15 anni, lungo, ricco di novità e di risultati, in relazione ai numerosi scavi archeologici che si stanno conducendo per iniziativa di soggetti diversi in dieci Paesi, con una forte componente internazionale e con un progressivo ampliarsi dei soggetti coinvolti, con il prodigioso riemergere di intere collezioni e il riordino dei lapidari di antichi musei. L’impressione generale che ne abbiamo tratto è quella di un forte rinnovamento degli studi, del passaggio di testimone tra due generazioni di studiosi, di una nuova vivacità della ricerca archeologica ed epigrafica, di un interesse crescente per i risultati scientifici che toccano territori tanto diversi, che hanno vissuto il fenomeno della romanizzazione in modi e forme davvero originali[17].
Ora che nuove porte si aprono in Europa e che nuovi muri purtroppo si innalzano, abbiamo un’opportunità ed un’occasione storica, che è quella di ritrovare una dimensione perduta, quella di ricostruire una rete di rapporti, di relazioni e di amicizie che rafforzi la comprensione tra i popoli, affermi valori comuni, definisca un quadro di stabilità e di pace, in un’Europa più consapevole delle proprie radici comuni, più capace di individuare quelle complesse e radicate esperienze culturali che da gran tempo compongono i suoi fondamenti. Eppure nulla come l’esodo di intere popolazioni attraverso nuove strade e nuovi percorsi di terra, di mare e di fiume che osserviamo in questi ultimi mesi ci può far capire quella che fu nella sostanza la fragilità e la crisi del mondo antico.
Noi oggi possiamo articolare nel tempo e nello spazio i flussi migratori che hanno investito le province danubiane dall’Italia o da altre aree del Mediterranneo; soprattutto possiamo apprezzare il ruolo delle élites locali, attratte dai vantaggi economici, giuridici e politici offerti da Roma, interessate ad adottare volontariamente usi e costumi di una comunità nuova, talvolta, come ricordava Géza Alföldy, con un gusto quasi antiquario nell’illusione di essere i veri discendenti di Roma, i soli custodi di valori comuni[18]. Possiamo allora ribaltare la prospettiva e sostenere il ruolo fondamentale della geografia nella storia: in età imperiale nacquero diverse società provinciali, che ideologicamente si richiamavano a Roma ma che nella pratica, senza contraddizioni con l’identità romana, erano peculiari di un determinato territorio giacché della cultura italica avevano recepito solo alcuni elementi, quelli che meglio si adattavano alla società locale e che preservavano numerosi tratti della tradizione pre-romana; su questa base si innestavano poi gli influssi divergenti, dovuti ai tanti funzionari, militari, coloni provenienti da altre provincie che esportavano la specifica concezione di “cultura romana”. Senza contare l’apporto ininterrotto proveniente da quelle popolazioni stanziate nel Barbaricum oltre il limes rappresentato dal grande fiume simboleggiato dal Neptunus Danuvius dell’iscrizione di Stepperg in Baviera, pubblicata nel 2012[19], una linea che in realtà è stata costantemente attraversata, se non altro per consentire ai giovani peregrini di svolgere il servizio militare all’interno dei reparti ausiliari romani, come dimostrano tanti diplomi[20]. La divinizzazione del grande fiume Danuvius (allo stesso modo in Pannonia il Dravus, il Savus[21], il Colapis, il Bathinus) testimonia il suo ruolo nell’immaginario collettivo e l’importanza del traffico fluviale[22]. Analogamente parliamo del Fluvius Acaunus paredro della dea Salacia (la sposa di Nettuno) a Vienna[23]. A Salzburg-Iuvavum nel Norico la personificazione del fiume Salzach onorato da un navicularius comparirebbe nella spettacolare base decorata con un’aquila, dedicata insieme I(ovi) O(ptimo) m(aximo) et Iuvavo pro salute Mari Aniceti e per il suo successo commerciale, negotiationi eius[24]. A Vranjske Njive presso Podgorica in Montenegro (Doclea) ci rimane la dedica studiata da D. Grbić che richiama i pericoli della navigazione marittima sull’Adriatico piuttosto che fluviale: un commerciante italico offre un altare a Nettuno con un epiteto davvero inconsueto: Neptuno sacrum periculorum absolutori[25].
In questo contesto, il tema della provincializzazione delle province danubiane e in particolare della Dalmazia ad esempio è da affrontare alla luce di un doppio orizzonte culturale, quello del processo di integrazione e unificazione di popoli tanto diversi nell’ambito della communis patria Roma (attraverso la religione ufficiale, il culto imperiale, l’urbanistica, le iscrizioni pubbliche), ma anche quello, generato dalle delimitazioni cittadine e provinciali, che ha determinato profonde differenze tra popoli e province, con i presupposti della successiva frammentazione dioclezianea[26]; fino a giungere all’estremità orientale del territorio, come ad Odessos (oggi Varna) in Mesia Inferiore, dove quattro termini indicano nella seconda metà del I secolo d.C. il percorso della frontiera amministrativa della provincia e della città: [F(ines) te]rr(ae) [T]hraciae, [F(ines) terr(ae) Ode[ss(itanorum)][27].
2. Lo specifico epigrafico.
In questo quadro emerge uno specifico, nello studio delle scritture antiche, latine soprattutto e greche, quello dei metodi utilizzati dalle diverse epigrafie, le paleografie come il lavoro di Mrozewicz per 230 iscrizioni di Novae[28], i graffiti[29], i tituli picti anche per il restauro di monumenti[30], gli errori del lapicida e gli strumenti officinali[31], le officine lapidarie[32], le damnationes[33] e le successive reincisioni[34], le provenienze dei marmi epigrafici[35], i marchi di artisti e artigiani[36], i bolli sui vasi, mattoni, importati o fabbricati localmente anche da figlinae imperiali nelle province danubiane[37]; le scritte sulle corazze militari[38] o su anelli[39]; le tesserae nummulariae della Carinzia[40]; in generale l’instrumentum come nei Testimonia epigraphica Norica[41] o negli ex voto religiosi, come quelli dedicati alle divinità dalle terme salutari di Aquae Iasae in territorio di Poetovio in Pannonia Superiore[42]. E poi i tituli picti[43], le tavolette di cera dalla Dacia[44], la decorazione iconografica[45], le tipologie monumentali[46], gli errori del lapicida[47], il reimpiego ad es. dei miliari [48], i falsi[49], i “doppi epigrafici”[50], il ductus[51], il formulario[52], la damnatio memoriae[53], la poesia epigrafica studiata da Paolo Cugusi e Maria Teresa Sblendorio Cugusi[54], con varie reminiscenze ovidiane che da Tomi riemergono nei carmina epigrafici, come a Sarmizegetusa (heroides, 21,91)[55], oppure come a Transmarisca secondo D. Adameşteanu dai Tristia di Ovidio, hic ego qui iaceo tenerorum lusor amorum (III, 3, 73 s.)[56]. Sulla stessa linea a Melta (oggi Lăžane in Bulgaria), un carme funerario racconta della lunga malattia della defunta quattordicenne, con riprese dal mito di Atlante nelle Metamorfosi di Ovidio (X, 689-690)[57]: temi che ci riportano alle radici della cultura latina di età augustea, in ambiente danubiano. Infine l’epigrafia rupestre tanto cara a Lidio Gasperini: in Bulgaria a Pleven R. Ivanov ha rivisto l’iscrizione rupestre di Somovit[58]. Come dimenticare che dieci anni fa Miroslava Mirković attraverso le iscrizioni rupestri diel Djerdap nelle emozionanti gole del Danubio (già note al Marsigli) ha ricostruito la politica imperiale romana tra Tiberio e Adriano in territorio mesico[59] Ma l’epigrafia è capace di far riemergere tradizioni, riti, miti di un passato lontanissimo da noi[60]; fa scorgere il tema dell’assenza, la disperazione, il cordoglio, il pianto di fronte alla morte, ben al di là degli stereortipati formulari epigrafici legati al rimpianto da parte degli eredi[61]; suscita emozioni e contiene indicazioni erotiche[62]; oppure ci informa sugli aspetti sociali come a proposito dell’applicazione in Mesia delle leggi matrimoniali di Augusto dopo la recente scoperta delle due tavole bronzee contenenti la Lex Municipii Troesmensium dell’età di Marco Aurelio e Commodo, ffettuata nel 2003[63]; oppure sui rapporti di parentela come a proposito dell’utilizzo del termine amita o del termine nepos/neptia in Dacia[64].
Significativi passi in avanti sono stati compiuti sui fenomeni linguistici caratteristici del latino parlato in provincia, in particolare in Pannonia, a causa dei rapporti transfrontalieri e della varietà di provenienze della componente militare, per quanto assistiamo sul piano geografico a una progressiva riduzione della “densità epigrafica” dopo l’età dei Severi[65]; è stata studiata da B. Fehér la sintassi delle frasi complesse nel latino della Pannonia e la coesistenza tra lingue differenti[66]; in Mesia Superioe a Naissus V. Nedeljković ha studiato l’evoluzione del volgare in età tardo-antica[67]; la lingua latina sulle iscrizioni daciche è stata studiata da Eugenia Beu-Dachin[68]; per non parlare della prosopografia[69], della situazione sociale e del ruolo degli schiavi e dei liberti imperiali[70]: l’applicazione della lex Aelia Sentia, che secondo L. Mihăilescu-Bîrliba in Dalmatia, Pannonia, Mesia, Dacia testimonia che gli schiavi erano liberati molto giovani, a meno di 30 anni di età[71]. La vita familiare in particolare dei liberti nell’Illyricum[72] oppure in Dacia[73]; ma anche la condizione femminile[74], l’età del matrimonio, lo ius hereditatium in Dacia[75], l’onomastica specie in ambiente militare[76], i gentilizi imperiali, i pseudogentilizi[77], la vita religiosa, l’organizzazione del culto imperiale a livello municipale e provinciale[78], le tradizioni legate al mondo della magia[79], della religione o della medicina ufficiale nelle loro interrelazioni[80]; le minacciose defixiones[81]; con attenzione per tanti aspetti sociali, come l’età media o la speranza di vita[82]; ancora le nuove possibilità offerte dall’epigrafia alla delimitazione dei territori delle città e delle province, come ad Histria (civitas libera et immunis), dove un editto del governatore della Mesia Inferiore nei primi anni di Traiano Manius Laberius Maximus fissava i limiti territoriali della città, alla base di successive controversie che giunsero fino all’età dei Severi[83]; oppure ad esempio alla conoscenza delle professioni[84] o alla navigazione fluviale e all’attività di mercatores e dei corpora naviculariorum[85]; alla realizzazione di opere pubbliche[86] e di edifici da spettacolo, come gli anfiteatri, in Dalmazia a presso il campo legionario di Burnum (Ivoševci)[87] e Salona[88], in Pannonia a Brigetio[89], a Carnuntum già nell’età di Vespasiano[90], ad Aquincum[91] e nella Dacia romana[92].
Infine, il rapporto tra culture religiose differenti, la presenza ebraica come a Brigetio[93] o ad Aquincum[94] o nelle province daciche[95]; la fase cristiana è testimoniata ad esempio dalle citazioni della Bibbia[96]. L’insieme dei documenti è ora studiato anche con riferimento alla collocazione cronologica, attraverso i formulari, le caratteristiche tecniche, la paleografia[97], la scrittura corsiva[98].
Già il nostro compianto Géza Alföldy si interrogava nel volume degli atti della Conferenza sul Danubio svoltasi a Belgrado edito da M. Mirković nel 2005 sulla concreta possibilità di ricondurre ad un discorso unitario il processo di sviluppo della “cultura epigrafica” nelle province danubiane, in rapporto a variegati processi di urbanizzazione e municipalizzazione nello spazio danubiano, visto che dobbiamo registrare ritmi differenti di un discorso articolato per province tanto differenti tra loro, con tante originali diversità. In alcune aree, specie nel settore illirico, la “cultura epigrafica” si affaccia già a partire da Augusto; Pannonia e Mesia hanno ospitato reparti legionari, mentre altri territori, come la Rezia e il Norico, sono stati controllati solo da guanigioni ausiliarie; in molte province, a maggior ragione in Dacia, si può parlare di cultura epigrafica solo dopo la prima metà del II secolo d.C., a causa della “bassa densità epigrafica” per tutto il I secolo d.C. (e ci troviamo di fronte prevalentemente a iscrizioni funerarie)[99]. Di conseguenza mi sono interrogato a lungo se proporre con questa relazione un quadro unitario per l’insieme dell’area balcanico-danubiana oppure più correttamente un ragionamento articolato per settori e per province. Ovviamente mi riservo in futuro di raggiungere un livello maggiore di dettaglio e di approfondimento.
3. La lunga conquista.
Sembra opportuno partire ancora una volta dalla “regina inscriptionum”, le Res Gestae Divi Augusti, con le parole di Augusto evocate da Werner Eck al nostro primo convegno di Ferrara: Pannoniorum gentes quas ante me principem populi Romani exercitus numquam adiit…imperio populi Romani subieci protulique fines Illyrici ad ripam fluminis Danuvi[100]. Le recenti riflessioni di H. Grassl e di K. Strobel hanno portato a rivalutare l’azione di Augusto e ad arrivare ad una sintesi sulle nuove teorie sulla provincializzazione di Rezia, Norico, Pannonia[101]. Anche il recente lavoro di D. Grbić sulla conquista romana alla luce dei monumenti trionfali (partendo dalle statue che rappresentano i popoli balcanici provenienti dall’Augusteo di Afrodisia), ha chiarito i contenuti delle campagne militari di Ottaviano Augusto, segnando le tappe della conquista dell’Illirico e delle regioni danubiane[102].
Augusto costituì definitivamente la provincia dell’Illirico solo nel 27 a.C., considerandola pacificata e lasciandola nelle mani del Senato, che vi inviò dei proconsoli. Qualche anno dopo, a seguito di una nuova rivolta di Dalmati, la provincia fu dichiarata imperiale, allargata fino a comprendere parte della Pannonia e della Mesia e, tolta al Senato, a partire dall’11 a.C. ospitò un presidio legionario che aveva sede a Salona, sotto il comando di un legato di rango consolare (il primo fu il figliastro Tiberio). Gli ultimi studi hanno chiarito molti aspetti della grande rivolta pannonica del 6 d.C.: Sirmio (Mitrovica in Serbia) sulla Sava fu a lungo assediata da Tiberio, indebolita da carestie e pestilenze, come ha dimostrato Dénes Gabler dell’Università di Budapest[103]. La Pannonia, ormai quasi spopolata, fu allora sottoposta ad una dura occupazione militare ed affidata inizialmente col nome di Illyricum Inferius ad un autonomo legato, così come ora precisato dalla Šašel Kos, M. Emilio Lepido nel 9 d.C. e alla morte di Augusto Quinto Giulio Bleso[104]. È possibile ricostruire l’attività delle legioni e dei reparti ausiliari, impegnati a costruire strade, canali, accampamenti. L’esercito è presente con i suoi castra legionari e ausiliari affiancati dalle canabae. Le regioni adriatiche della Dalmazia venivano definitivamente scorporate dalla Pannonia e costituivano una provincia distinta. I recenti lavori di Jenő Fitz hanno spostato nel tempo la bipartizione della provincia di Illiria. La divisione non sarebbe avvenuta come fin qui sostenuto tra il 9 e il 20 d.C. ma solo sotto Claudio tra il 46 e il 49. Dopo aver fatto parte del Norico, Carnuntum appartiene alla Pannonia dal 50. Savaria ha ottenuto il titolo di colonia allo stesso tempo delle città del Norico con un perfetto sincronismo. La prima menzione di un governatore in Pannonia è del 50, di Dalmazia dal 65[105].
Già in ertà augustea si sviluppa una forte immigrazione di artigiani, come i Barbii recentemente studiati da G. Piccottini[106]; a questi anni può forse essere riferita l’iscrizione incisa sulla gamba della celebre statua di atletas Jüngling von Helenberg che si data alla seconda metà del I secolo a.C. (dunque all’inizio di età augustea secondo Wohlmayr) e su uno scudo perduto sempre dal Magdalensberg con i nomi M. Gallicinus Vindili f. L. Barbius L. l. Philotaerus procurator, Craxantus Barbi P. servus [107]. Infine ad officine di inizio di età augustea viene riferita la dedica effettuata alle calende di maggio alle divinità ctonie con 25 misure di vino per libagioni da A. Poblicios D.l. Antiochus [108].
4. Questa rassegna.
Naturalmente la nostra ricerca è partita da L’Année épigraphique che a questi primi 13 anni (l’ultimo numero del 2012 è uscito in questi giorni) riserva oltre 500 schede, e da numerose altre riviste (Arheološki Vestnik nr. 66 dedicato a Slavko Ciglenečki sulla tarda antichità è arrivato al 2015) e altri repertori, tra i quali l’Annona epigraphica Austriaca di E. Weber su “Tyche”, dal XV volume, curata da un gruppo di studiosi: K. Böhm, V. Hofmann, M. Holzner, M. Pesditschek, R. Selinger, I. Weber-Hiden, fino a F. Beutler nel 2014-15; una rassegna che raccoglie articoli spesso difficili da trovare, accompagnata da un commento epigrafico, indici e lista di concordanze[109]. Ma ormai possediamo numerosi repertori bibliografici, come quelli sulla religione in Dacia curato da Cs. Szabó e I. Boda, uscito nel 2014.
Ma questi sono gli anni della pubblicazione di diversi nuovi volumi del Corpus Inscriptionum Latinarum, relativi ad alcune province e ad alcune categorie di iscrizioni, come i 572 nuovi miliari, quelli della Rezia e del Norico studiati nel 2005 nel volume XVII, Pars V, Illyricum et provinciae Europae Graecae, fasc. I, miliaria provinciarum Raetiae et Norici del CIL, da Anne Kolb, dal compianto Gerold Walser e da Gerhard Winkler (Berlino New York 2005), pubblicato a cura di Manfred G. Schmidt e Ulrike Jansen per conto dell’Academia Scientiarum Berolinensis et Brandenburgensis. Nel nuovo fascicolo (CIL, XVII, IV, 1), si raccolgono 73 miliari delle sette vie della Rezia e 155 miliari lungo dieci vie del Norico: citerò almeno la via a Vindobona per Cetium Lauriacum Ovilavis ad Aenum flumen in Norico[110] e la via sulla riva destra del Danubio (via secundum amnem Danuvium) in Rezia, tra Guntia, Augusta Vindelicorum, Castra Regina, Boiodurum (in totale 229 nuovi testi o riedizioni con significative rettifiche)[111].
A tre anni fa, al 2012 risale il secondo fascicolo CIL, XVII, IV, 2, relativo ai miliari della Dalmazia (ediderunt Anne Kolb et Gerold Walser, nel frattempo deceduto, adiuvante Ulrike Jansen), con altri 342 miliaria provinciae Dalmatiae e gli indici dei fascicoli 1 e 2 curati da A. Fassbender[112]. L’opera permette di identificare almeno 11 strade della Dalmazia, tra le quali la strada costiera settentrionale che si originava da Aquileia: via ex Italia per Tarsaticam, Seniam, Burnum ad Salonas; ma la messe più significativa di nuovi documenti è quella relativa ai quasi cento miliari delle due strade meridionali lungo la costa, le viae a Narona Scodram.
L’impresa della riedizione di CIL III per le iscrizioni pannoniche (in particolare di Carnuntum) presentata a Ferrara da Ekkehard Weber rende bene la difficoltà di un impegno internazionale di ricerca che però rappresenta una speranza per il futuro. Siamo certi che accanto alla individuazione di nuovi falsi, accanto alla riedizione di testi già noti ed alla riorganizzazione dei dati, la nuova edizione di CIL III presenterà rilevantissime novità e numerosi inediti[113].
Le iscrizioni della Pannonia sono state già ampiamente discusse nei cinque fascicoli degli Studia Epigraphica Pannonica SEP, curato dal gruppo di lavoro ungherese che prepara il nuovo volume di CIL III seconda edizione consacrato alla Pannonia (ultimo a cura di P. Kovács, B. Fehér), con attezione per Aquincum, Brigetio, Scarbantia, e la revisione delle epigrafi, in particolare le false di Carnuntum; un capitolo significativo è dedicato agli umanisti alla corte del re Matthias Corvin[114]. Rare (37 in tutto) le nuove iscrizioni greche della Pannonia studiate da P. Kovács, 11 delle quali bilingui, a testimonianza di specifiche componenti sociali (soldati, negotiatores, cristiani)[115]. Proprio P. Kovács ha curato la terza edizione accresciuta del Corpus Inscriptionum Graecarum Pannonicarum: 31 su pietra, 11 bilingui locali, nelle due province di Pannonia e nella contigua regione del Barbaricum, con osservazioni sull’influenza del greco sul latino della regione e la confusione tra alfabeti diversi[116]. Non mancano le iscrizioni ebraiche, una delle quali in lingua greca conserva un versetto del Deuteronomio (6,4), proveniente dalla Pannonia Superiore, il più antico testimonio ebraico in suolo austriaco, II secolo[117].
Al 2011 risale il Corpus Inscriptionum Latinarum et Graecarum Montenegri, di J. Martinović: in totale 347 iscrizioni latine e 8 greche scoperte nel Montenegro, quasi tutte già note, con non poche imprecisioni[118] .
Le iscrizioni latine dell’Albania sono state presentate in due volumi usciti a pochi anni di distanza, rispettivamente nel 2009 e nel 2012: il primo è opera di Skender Anamali, Hasan Ceka, Élisabeth Deniaux (Corpus des inscriptions latines d’Albanie), il secondo di Ulrike Ehmig e di Rudolf Haensch (Die lateinischen Ischriften aus Albanien)[119].
Naturalmente per i nostri territori sono molto significativi i recenti dati relativi a nuovi diplomi militari (pubblicati da Wener Eck e dai suoi colleghi)[120] e gli aggiornamenti a CIL XVI. Un incredibile numero di nuovi diplomi (una sessantina) ci provengono dalla Mesia, pubblicati su “Chiron” da P. Weiss, W. Eck, A. Pangerl: di essi 26 sono riferiti alla Mesia Superiore, 25 alla Mesia Inferiore[121]. Un significativo aggiornamento dei RMD con precisazioni e rettifiche sulla consistenza dell’esercito del Norico è stato effettuato dopo le scoperte di Lauriacum, Porgstall an der Erlauf in Bassa Austria[122]. Sono venuti alla luce dodici nuovi diplomi relativi all’esercito della Pannonia, 5 alae e 13 coorti, uno (da Bakonycsernye) relativo ad un C. Iulius C. fil. Ael(ia) Passar della legio II Adiutrix a Brigetio, poi trasferito da Settimio Severo alla X coorte pretoria pia vindex, congedato il 22 febbraio 206: egli era originario Mogionibus, forse un popolo, i Mogiones, da avvicinare al vicino municipium Aelium Mogentiana affiliato alla pseudo tribù Aelia[123]. Ci sono molti altri casi che andrebbero richiamati, come quello di Cornacum che ricorda due consoli fin qui sconosciuti: Euphrata et Romano coss., un 7 settembre tra il 192 ed il 206, diploma concesso all’ex gregale (un marinaio della flotta) Priscinus Prisci f. Priscus ex Pan. Inf. Iatumentianis e ai figli. Egli era originario di un villaggio sconosciuto della Pannonia Inferiore, Iatumentianae[124].
Sono state studiate varie collezioni, come quella Matijević di Salona, ora presentata in Varia Salonitana di D. Maršić e M. Matijević[125]. Gli ultimi anni sono stati animati dalle ricerche che hanno portato alla monumentale edizione delle iscrizioni cristiane di Salona (Salona IV, Inscriptions de Salone chrétienne, IVe-VIIe siècles, E. Marin, N. Gauthier, F. Prévot edd., Coll. EFR 194,4, Roma Split 2010): 825 iscrizioni, 742 latine e 84 greche dal IV al VII secolo conservate in prevalenza a Split, utili anche per definire i raporti di parentela[126]. L’opera è stata più volte annunciata negli anni precedenti da E. Marin, che aveva segnalato le datazioni consolari della pars Occidentis, perché la Dalmazia non fu aggregata alla pars Orientis[127] e da N. Gautier, che invece pensava ad un’epigrafia di frontiera tra Roma e Costantinopoli e segnalava l’alto numero di iscrizioni in lingua greca, in relazione ai numerosi immigrati[128]. Anche F. Prévot nella Miscellanea Emilio Marin ha presentato una brillante sintesi sulle iscrizioni di Salona cristiana, con particolare attenzione per le relazioni familiari[129]. In un epitafio che contiene le istruzioni per la tomba, conosciamo nel V secolo per la prima volta un [p]rocura[t]or Ecles[ia]e Saloni[a]nae, un titolo che richiama la struttura dell’amministrazione imperiale[130].
In conseguenza delle nuove scoperte è cambiata profondamenrte la prospettiva storica, ad esempio sulla storia della Pannonia, come testimonia l’ampio articolo di Géza Alföldy in “Rivista Storica dell’Antichità”, 41, 2011, sintesi rinnovata attraverso le fonti letterarie, epigrafiche, iconografiche, con rettifiche rispetto al volume di P. Kovács, B. Fehér, pubblicato a Budapest nel 2005 in inglese (dal 54 al 166 d.C.) [131]. La storia della Pannonia tra il 235 e il 284 durante l’anarchia militare era stata studiata da P. Kovács[132].
Se ci fermiamo sulla Panonia inferiore (più orientale), emerge l’edizione di nuovi volumi del RIU e la costante revisione dei volumi precedenti: J. Fitz, A. Mócsy, S. Soproni hanno presentato il sesto volume: Die römischen Inschriften Ungarns, 6, Das Territorium von Aquincum, die Civitas Eraviscorum und die Limes-strecke Matrica-Annamatia und das Territorium von Gorsium, Budapest Bonn 2001, che comprende i territori di Aquincum, di Gorsium, della civitas Eraviscorum e il limes tra Matrica e Annamatia. L’opera è stata ampiamente commentata su AE e recensita da Alföldy e Lőrincz su “ZPE”[133].
Numerosi inediti da Aquincum sono presenti nei primi due volumi dei Tituli Aquincenses, curati da P. Kovács e A. Szabó, usciti a Budapest tra il 2009 e il 2010, che raccolgono oltre 650 iscrizioni, in particolare quelle relative ad opere pubbliche, onorarie, sacre, sepolcrali[134]. A B. Fehér si deve il III volume dei Tituli Aquincenses uscito a Budapest nel 2011 e dedicato a 523 bolli su instrumentum domesticum[135].
Le ricerche epigrafiche in Ungheria tra il 1994 e il 2005 sono sintetizzate da B. Lőrincz partendo da RIU[136]. Un buon supplemento al RIU è quello dedicato a oltre duecento iscrizioni ungheresi, 49 delle quali trovate nel Barbaricum Sarmaticum: P. Kovács, Tituli Romani in Hungaria reperti (TRH), Supplementum, Budapest Bonn 2005, con 47 inediti[137]. Una particolarità delle Pannonie sembra la ricchezza della decorazione dei monumenti funerari[138], come ora testimoniato dal volume di C. Ertel del Corpus Signorum Imperii Romani, Ungarn, IX[139]. B. Fehér ha presentato un supplemento al Lexicon epigrahicum Pannonicum (LEP), con riferimento alle scoperte effettuate tra il 1989 e il 2003[140]. Altri studi sono dedicati all’Instrumentum, con le più diverse provenienze.
Davvero straordinari appaiono i risultati del progetto iniziato e sviluppato da F. und O. Harl www.ubi-erat-lupa.org (Bilddatenbank zu antiken Steindenkmälern), oggi www.ubieratlupa.com (Römische Steindenkmäler) del Gruppo di ricerca per Archeometria e Beni Culturali Computing dell’Università di Salisburgo, in collaborazione con EAGLE (European network of Ancient Greek and Latin Epigraphy), con oltre 25000 monumenti fin qui schedati.
Der derzeitige Datenbestand umfasst 21 056 Steindenkmäler und 31 655 Bilder (Stand 26.02.2013).
Numerose sono le Numerose sono le raccolte di iscrizioni dei Musei Nazionali, come il Lapidario romano del Museo Nazionale Ungherese studiato da M. Nagy, con i suoi specifici problemi di classificazione dei monumenti per epoche o per argomenti; le iscrizioni in totale sono 116[141]. Oppure il museo epigrafico del bastione della fortezza di Komárno (con epigrafi prevalentemente da Brigetio)[142]. Per Brigetio L. Borhy presenta un catalogo 256 monumenti del lapidario del forte di Igmánd, 73 iscrizioni, 8 inedite[143]. Il nuovo lapidario nella città di Memesvámos-Balácapuszta (Comitato di Veszprém in Ungheria) è studiato da S. Palágyi[144]. La piccola collezione lapidaria del Museo di Hamság di Mosonmagyaróvár (Ad Flexum) è stata è presentata da E.T. Szőnyi; alcuni testi provengono da Bruckneudorf in Austria[145]. Ad E. Tóth dobbiamo l’edizione del Lapidarium Savariense, con ben 238 testi ritrovati a Savaria in Pannonia Superiore, oggi Szombathely in Ungheria, con molti inediti.[146] A Carnuntum, 31 iscrizioni del parco archeologico e del museo carnuntino studiate da K. Genser riguardano essenzialmente soldati della legione XIV gemina Martia Victrix e della legio XV Apollinaris o membri della loro famiglia, talora con riferimento alle canabae[147].
Se passiamo alle Mesie, a Belgrado aspettiamo il III/1 volume delle Inscriptions de la Mésie supérieure (région des Portes de fer) che sarà pubblicato dal Centre d’Études Épigraphiques et Numismatiques “Fanula Papazoglou”, ma possediamo nuovi dati dal Catalogul expoziţiei The Romans in the Left Pontus during the Principate, Exhibition Catalog, Aegyssus 2000, Tulcea 2012 ICEM, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea, Muzeul de Istorie şi Arheologie. Sono stati inaugurati nuovi musei come a Capidava, anche se le iscrizioni vengono regolarmente trasferite nei lapidari dei musei nazionali, a Bucarest e Costanza.
Il nuovo corpus delle iscrizioni di Dacia, a valle dei Cronica epigrafică della Romania dedicato alla Dacia ed alla Scizia minore (cioè alla parte romena della Mesia Inferiore), si deve a C.C. Petolescu, con l’opera Inscripţii latine din Dacia (ILD) uscito a Bucarest nel 2005, con 805 iscrizioni, in parte riprese da SCIVA, soprattutto con le nuove nuove iscrizioni, non incluse nei volumi IDR, già pubblicati: il numero dei diplomi della Dacia (50) appare davvero ragguardevole[148]. Allo stesso autore dobbiamo fuori collana rispetto ad IDR i due volumi (l’ultimo dei quali pubblicato nel 2000) Inscriptions de la Dacie romaine. Inscriptions externes concernants l’histoire de la Dacie (Ier-IIIe siècles), II, Zones du CIL III et du CIL VIII, Bucarest 2000, dalle province danubiane e balcaniche, Asia Minore, Africa[149]. Entro le IDR III,5, I. Piso presenta le 724 Inscriptions d’Apulum, Inscriptions de la Dacie romaine (Mémoires de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, XXIV), III,5, Paris 2001, con alcune inedite. Un utile aggiornamento epigrafico dobbiamo a C.C. Petolescu, per Dacia, Scizia Minore, parte rumena della Mesia Inferiore, vd. la rassegna annuale “SCIVA”, arrivata al 65° fascicolo nel 2014[150]. Lo stesso autore ha presentato il manuale Epigafia latină, Bucarest 2001, commentando un centinaio di testi prevalentemente dalla Dacia. L. Ruscu ha raccolto i 152 testi del Corpus inscriptionum Graecarum Dacicarum (Hungarian Polis Studies, 10), Debrecen 2003.
Il catalogo delle iscrizioni del museo rumeno di Caracal in Dacia è presentato da D. Bondoc e D.R. Dincă[151]. Lo stesso D. Bondoc pubblica una nuova raccolta delle iscrizioni lapidarie del Museo di Craiova provenienti dalla Dacia inferiore[152]. Le iscrizioni di Micia (oggi Veţel) raccolte nella collezione del Museo Nazionale di storia di Transilvania a Cluj vengono riedite da D. Alicu[153]. Per il territorio di Sarmizegetusa, Apulum e Micia in Dacia Superiore, significativo è il corpus di 216 monumenti funerari inscritti curato da C. Ciongradi[154]. I. Piso ha presentato nel 2006 le cento straordinarie iscrizioni dal forum vetus di Sarmizegetusa[155].
Per la parte romena della Mesia Inferiore è stato pubblicato lo studio epigrafico postumo di N. Gostar sul grande monumento funerario del c.d. tropaeum Traiani (2008, ma scritto 40 anni fa), ora commentato da A.S. Ştefan, per il quale si tratterebbe di un tropaeum Domitiani, decisamente più antico[156]. Infine, è appena uscito il IV volume delle Iscrizioni della Scizia Minore (2015) di Em. Popescu.
5. Storia degli studi.
L’attività dei precursori dell’epigrafia e lLa Laa storia degli studi epigrafici parte con il bel contributo di X. Espluga sugli umanisti del XV secolo Ciriaco di Ancona, Giorgio Begna, Pietro Donato e Giovanni Marcanova, interessati all’epigrafia di Split e Salona in Dalmazia[157]. In Croazia nel XVIII secolo agisce Frane Radman, studiato da V. Kapitanović[158]. A Sisak (Siscia in Pannonia Superiore) nella seconda metà del XIX secolo, le figure di Mijat Sabljar e Ivan Tkalčić sono presentate da V. Vukelić[159]; a Seggauberg nel territorio di Flavia Solva nel Norico è stata ricostruita la storia delle ricerche epigrafiche effettuate da Richard Pococke nel Settecento[160]. In Dacia particolarmente rilevanti le figure di Stephanus Taurinus e Georg Reichesdorffer, umanisti del XVI secolo: attraverso i manoscritti degli umanisti possiamo ricostruire una ventina di iscrizioni[161].
Una storia degli scavi e delle scoperte nel Norico (Oberösterreich) in età romana è stata pubblicata a cura di J. Leskovar, C. Schwanzar, G. Winkler, con attenzione specifica per Ovilava, Lentia, Celeia[162].
Una difficoltà è rappresentata dall’incrociarsi delle raccolte organizzate per provincia e quelle invece promosse all’interno dei nuovi confini “nazionali”, in Austria[163], in Ungheria, in Romania, in Bulgaria, perfino nella Germania bavarese e Svizzera, nell’Albania settentrionale e nella ex Jugoslavia, non sempre all’interno dell’Unione Europea (sono entrate Croazia e Slovenia; non sono nell’U.E. Bosnia, Serbia, Montenegro, Macedonia, Kosovo). Alla rovescia, alcune province vengono frammentate sulla base dei moderni confini nazionali: nel Norico, S. Djura Jelenco e J. Visoćnik presentano il catalogo delle iscrizioni lapidarie della Carinzia slovena[164]. E. Weber presenta un quadro dell’epigrafia delle Alpi orientali e in particolare delle regioni meridionali dell’Austria[165]. M. Huber ci presenta una storia degli studi epigrafici nel Tirolo, riprendendo le iscrizioni pubblicate nel 1756 da Anton Roschmann, con uno sguardo storico e archeologico[166]. S. Loma ha effettuato una revisione di epigrafi sul corso superiore del Lim, a Nord est del Montenegro[167]. Ma ci sono altri musei internazionali, come quello di Monaco, che contengono collezioni che ci riguardano, come ha dimostrato R. Gebhard per i 125 anni del Museo, con una collezione lapidaria che comprende anche iscrizioni dalla Rezia e dal Norico.
Carattere ampio e interprovinciale hanno diversi volumi in onore di valenti studiosi, come quelli per Ioan Piso[168], Emilio Marin[169], Alexandru Suceveanu[170], Doina Benea[171], Mihai Bărbulescu[172], Dorin Alicu[173], Radu Ardevan[174], György Németh[175]; anche Silviu Sanie, Dumitru Protase, Lucia Ţeposu Marinescu. Per altri, come Géza Alföldy[176], Alexandru V. Matei[177] e Vasile Lica, si tratta di volumi in memoria. Raccolte di scripta varia sono state edite, come ad esempio per Mihai Bărbulescu[178], Alexandru Suceveanu sulla Dobrudja romana[179], Barnabás Lőrincz[180], Gerhard Winkler[181].
6. Nuove acquisizioni sui governi provinciali.
In Dalmazia possiamo distinguere tre circoscrizioni giudiziarie (conventus), con i capoluoghi Scardona per la Liburnia a Nord, Salona al centro, Narona per i territori meridionali. Il legatus Augusti propraetore di rango consolare, assistito da un procuratore equestre per l’amministrazione finanziaria, risiedeva nella capitale Salona, mentre il concilium provinciae, l’assemblea che organizzava il culto imperiale almeno per le comunità liburniche, aveva sede a Scardona[182].
Alcune delle più recenti scoperte epigrafiche hanno riguardato i primi governatori. Un’iscrizione di Iader ricorda il patrono Cn. (Baebius ?) Tamphilus Vala (Numonianus ?), forse il primo proconsole di Illiria al momento della creazione della provincia da parte di Augusto, il che spiegherebbe la frequenza dei Baebii[183]. Più informazioni possediamo ora per il legato Dolabella, grazie ai lavori di S. Mesihović[184] e alle nuove scoperte di Epidaurum (ogggi Cavtat), relative all’amministrazione della città, all’attività del legato, ai magistrati cittadini[185]. Furono i primi legati di Dalmazia all’epoca di Tiberio P. Cornelius Dolabella e L. Volusius Saturninus ad organizzare il culto imperiale in Liburnia in particolare a Scardona. Gianfranco Paci ha studiato a Narona la dedica di Dolabella ad Augusto divus, dopo la consecratio voluta da Tiberio[186]. L’attività di Dolabella è documentata anche sul territorio, con la terminatio tra Asser(iates) e C[or(nienses)] studiata da Sl. Čače: da Podgađe (Asseria) proviene il terminus posto ex [dec(reto) P. Corn(eli)i] Dol(abellae) leg(at)i pr(o) [pr(aetore)] det(erminavit) C. Titius Geminus (centurio) legionis VII inter Asser(iates) et C[or(nienses)][187]. Di grande interesse le operazioni di delimitazione catastale, iniziate come si è visto già con Augusto: proprio ad Asseria in Dalmazia conosciamo cinque iudices dati a M. Pom[peio] Silvano leg(ato) Aug(ust)i propr(etore), i quali inter r(em) p(ublicam) Asseriatium et inter rem p(ublicam) Alve[ritarum] in re praesenti per sententiam [suam] determinaverunt, documento analogo ad altri termini già noti[188]. In questo ambito, Dolabella ha provveduto ad una totale progettazione della rete stradale in Dalmazia, come ora dimostra il lavoro di M.G. Schmidt, sulle 500 miglia delle strade dell’Illirico con partenza da Salona nelle tabulae Dolabellae: ad fines provinciae Illirici inferioris, ad Batinum[189].
I Fasti della provincia del Norico, con una lista aggiornata dei procuratori governatori e finanziari del Norico si deve a G. Winkler[190], con le osservazioni di S. Demougin e S. Lefevbre e soprattutto di Andreina Magioncalda, in occasione del XII Congressus AIEGL[191].
I governatori della Provincia dell’Illiricum superior sono studiati da S. Mesihović dal 42 (rivolta di Scribonianus) al 68[192]. L’antica unità della Dalmazia, della Mesia e della Pannonia fu mantenuta nel distretto doganale, dove veniva riscosso in modo unitario il publicum portorii Illyrici (con le precisazioni ora di Lyuba Radulova). La separazione in più province dell’Illirico, l’epoca e le forme della divisione delle Pannonie, delle Mesie, delle Dacie sono stati oggetto di ampi studi. Fitz ha definito i confini della Pannonia inferior e superior dopo il 213: fu Caracalla, nel corso della guerra contro gli Alamanni, ad aggregare la legione di Brigezio (sulla riva del Danubio, ad Est del lago Balaton) e il suo territorio alla Pannonia Inferiore[193]. I miliari di Pannonia Inferiore che ricordano Pontius Pontianus e Aelius Triccianus presso Ménfosanak confermano che la frontiera coincideva con la linea del fiume Arrabo. Ciò consente di aggregare alla Pannonia Inferiore i territori a Nord e a Sud e del lago Balaton.
L’annessione del Norico (nel 15 a.C.) non abolì inizialmente l’antico regno alpino fino alla costituzione della provincia (sotto Claudio), che mantenne qualche autonomia e sopravvisse oltre il principato di Tiberio, a testimonianza forse di un’occupazione pacifica ottenuta per via diplomatica: un vincolo federale univa le tribù celtiche degli Alauni, degli Ambisonti e dei Taurisci, che riconoscevano un unico re. Più tardi, dopo la costituzione della provincia del Norico, sul Magdalensberg sorse il tempio del Divus Augustus e della Dea Roma, centro federale del culto imperiale, ricco punto terminale delle importazioni di vino, olio, garum[194], persino di metalli dalla penisola iberica[195]. Fu già Augusto ad esentare dalle imposte C. Iulius Vepo[196]. Il territorio provinciale fu sottoposto inizialmente all’autorità di un procuratore equestre (procurator regni Norici), di rango ducenario, dotato di ius gladii: una vera e propria riorganizzazione territoriale si dovette all’imperatore Claudio, protagonista con il procuratore C. Baebius Atticus (originario di Iulium Carnicum) di un’intensa opera di romanizzazione, testimoniata dalla realizzazione dell’intera rete stradale in direzione del Brennero e della valle dell’Isonzo fino ad Aquileia, tra la Rezia e la Pannonia e da una vivace politica di municipalizzazione, con l’assegnazione dello Ius Latii e la promozione ad esempio di Celeia di cinque importanti oppida celtici: Celeia, Virunum, Teurnia, Aguntum e Iuvavum al rango di municipio (municipia Claudia)[197]
La presenza romana nel Norico ebbe come immediata conseguenza l’intervento militare nella vicina Rezia (a cavallo tra Svizzera ed Austria), voluto da Augusto per proteggere il limes danubiano e per estendere il controllo sui valichi alpini. Furono Druso e Tiberio a comandare la spedizione che con due distinte colonne raggiunse oltre i valichi alpini il Pons Aeni (Innsbruck, Veldidena)[198] attraverso le vallate dell’Adige, dell’Isarco e dell’Inn e il lago di Costanza presso le sorgenti del Danubio. Come è noto la vittoria fu consacrata sul trofeo alpino di Monaco e il nome delle civitates Raeticae e Vindelices sottomesse compare nell’elenco di Plinio il vecchio[199].
Dopo la conquista la Raetia-Vindelicia et Vallis Poenina fu affidata inizialmente ad un praefectus civitatium, come [S]ex. Pedius Sex(ti filio) An(iensi) Lusianus Hirrutus, originario di Interpromium, pr[aef(ectus)] Raetis Vindolicis vallis Poeninae[200]. A. Schaub e R. Rollinger hanno studiato il governo della provincia in età augustea e tiberiana : Q. Octavius Sagitta procuratore sotto Tiberio, Q. Caecilius Cisiacus Septicius Pica Caecilianus governatore della Rezia, Vindelicia, Vallis Poenina tra Tiberio-Caligola e Claudio; per quanto Davide Faoro neghi l’esistenza di una provincia autonoma ancora nei primi anni di Tiberio e sposti il secondo al II secolo[201]. I confini della provincia furono tracciati più volte e raggiunsero il Danubio a Nord e la confluenza con l’Inn, che segnava il confine orientale. Il territorio perse successivamente (con gli Antonini) l’area della Vallis Poenina che divenne provincia a sé stante lungo l’alta vallata del Rodano. Anche la valle dell’Adige e l’attuale provincia di Trento furono presto sottratte all’autorità del prefetto provinciale ed inserite nelle regioni X e XI della penisola: la popolazione tribale fu allora aggregata (adtributa) ai vicini municipi della Cisalpina, con una sorta di subordinazione testimoniata dalla tabula Clesiana.
Per la Pannonia, la lista dei governatori curata da B. Lőrinz è in Fontes Pannoniae Antiquae in aetate Severorum, edito da P. Kovács (Budapest 2007)[202].
In Mesia Inferiore a Gigen R. Ivanov pubblica l’iscrizione che ricorda il fratello di Settimio Severo con una base dedicata P. Septimio Getae leg(ato) Augg(ustorum) pr(o) pr(aetore) patronus col(oniae), onorato dai coloni di Oescus, come governatore provinciale nominato da due Augusti diversi, forse prima Commodo nel 192, poi Pertinace nel 193[203]; la questione fa davvero difficoltà, ma del resto a Lepcis Magna Geta è ricordato anche come legato di tre Augusti, dunque anche Severo nel 194, prima di diventare nel 195 governatore della Dacia[204].
In Mesia, la Tavola di Durostorum, che proviene dall’accampamento della legione XI Claudia Pia Fidelis[205], analoga a quella di Brigetio[206], contiene nell’edizione di N. Sharankov le sacrae litterae del solo Licinio, datate al 10 giugno 311 ed è indirizzata ad un Tertius dux oppure praeses della Moesia secunda con benefici per veterani, mogli e soldati ammalati.
La creazione della provincia Dacia è affrontata nel ricco volume miscellaneo Dacia Augusti provincia : crearea provinciei, con gli Atti del Convegno di Bucarest dell’ottobre 2006 curati da E.S. Teodor ed O. Ţentea[207], dove compaiono gli importanti contributi di C.C. Petolescu sull’organizzazione della provincia e di L. Petculescu sull’esercito in Dacia durante l’età di Traiano[208]. In parallelo, per i 1900 anni dopo l’integrazione della Dacia nell’impero Romano, D. Benea ha curato l’edizione degli atti del convegno di Timişoara del marzo 2006, Simpozionul Internaţional <<Daci şi Romani>>[209].
7. La storia: novità sui viaggi imperiali.
I numerosi viaggi attraverso le province danubiane di alcuni imperatori sono spesso documentati epigraficamente.
Dobbiamo partire con le campagne militari di Ottaviano che si svolsero in Dalmazia dopo la guerra contro Sesto Pompeo. Si segnalano numerose novità dal Magdalensberg anche sui populi o meglio sulle otto civitates del regno del Norico in età augustea, forse attorno al 10-9 a.C. in occasione di una visita di Augusto ad Aquileia: N[orici, Ambilinei], Amb[idr(avi), Uperaci, Saev(ates)], Laian[ci, Ambisontes, (H)e[lv[eti], che effettuano le quattro dediche alla famiglia imperiale Livia, Giulia, Giulia iunior, oltre che Augusto[210].
Le iscrizioni ci forniscono particolari su alcune campagne militari, come quella di Domiziano in Dacia (a Dolno Rjahovo, la Cohors I miliaria Batavorum quingenaria partecipa alle guerre di Domiziano contro i Daci tra l’89 e il 92, costruendo un fortino in legno poi abbandonato)[211] e di Marco Aurelio contro i Marcomanni in Pannonia; quest’ultima è studiata da P. Kovács, che ha curato una raccolta di fonti sulla Pannonia tra 166 e 192[212]. Un tema che ha suscitato molte curiosità partendo dalla colonna Aurelia è il c.d. miracolo della pioggia, attribuito a Marco Aurelio forse un 11 giugno, una data che forse veniva ricordata annualmente nel tempio di Giove Ottimo Massimo di Carnuntum[213].
Se partiamo dalla prima acclamazione imperiale di Settimio Severo effettuata dai legionari di Viminacium, una specifica attenzione per le città delle Pannonie, con vaste promozioni municipali è ben nota ed è stata studiata da Z. Mráv[214]. Un’iscrizione del Lapidarium Savariense dedicata nel 198 pro salute di Severo e della domus divina ripresa da E. Tóth ricorda il duoviro di Lugdunum Iun(ius) Q.f. Marcia(nus) Lugu(dunensis), partigiano di Severo, fuggito all’arrivo di Clodio Albino nel 196, assieme al governatore T. Flavius Secundus Philippianus, alla vigilia della battaglia di Lugdunum, rifugiatosi a Savaria in Pannonia[215]. Alla spedizione siriaca di Settimio Severo contro Pescennio Nigro sembra alludere l’iscrizione di Budapest che ricorda un miles rientrato dalla Siria nel 194, che consacra una dedica a Giove Ottimo Massimo: ab expedit[ione] Suriat(ica) rev[ersus] [216]; tra i sopravvissuti della seconda spedizione partica di Settimio Severo possiamo considerare L. Sep(timius) Veranus vet(eranus) leg(ionis) II Ad(iutricis) apparentemente ferito in ex[p]editione Parthica, congedato con una missio causaria, poi guarito e rientrato in Pannonia Inferiore nel 205 (Székesfehérvár)[217]; mentre C. Iul(ius) Sabinus civ(is) Campanus domo Capua ha forse preso parte all’expeditio urbica della legio II Adiutrix nell’epoca dei Severi in qualità di contabile, adiu(tor) off(icii) rat(ionum)[218]. Al ritorno di Settimio Severo nelle province danubiane nel 202 d.C. è riferita l’iscrizione di Lauriacum in Norico, che ricorda significativi lavori nel campo legionario ad iniziativa del legato M. Iuventius Surus Proculus, per quanto nella nuova lettura di G. Winkler il numero delle potestà tribunizie di Settimio Severo, dieci, non si concilia con le quattro eventuali potestà tribunicie di Caracalla[219]. Conosciamo anche miliari sloveni dell’anno precedente; al 201 risale il miliario di Söchtenau in Baviera con Settimio Severo (con la dodicesima acclamazione che non si lega alla nona potestà tribunizia), Caracalla (con la quarta) e Geta Cesare[220]. Sicuramente da emendare i due miliari di Murau nella Stiria, Lorch e Celje che rimanderebbero al passaggio di Settimio Severo nel 201 o 202 (VIIII o X potestà tribunicia) e più tardi di Caracalla nel 214 (XVII potestà tribunicia), lungo il percorso: Aquileia, Celeia, Virunum, Ovilava: miliaria vetustate corrupta restitui iusserunt[221]; perplessità rimangono sull’assenza di Britt(annicus) max(imus) tra i cognomina ex virtute di Caracalla [P]art(hicus) max(imus) e [Germ(anicus) max(imus)] su un miliario di Ad Pontem (Unzmarkt in Stiria), a 46 miglia da Virunum[222]. Singolare che Caracalla abbia mantenuto il testo del miliario di Settimio Severo, ma perplessità rimangono sul fatto che nel 201 si tacerebbe il nome di Geta e del governatore provinciale. A Cibalae in Croazia, nella Pannonia Inferiore, la dedica di un tempio effettuata da Settimio Severo, Caracalla e Geta ha fatto ipotizzare una visita conclusa con la dedica di un tempio della triade capitolina nel 202 d.C.[223]. È nota la partecipazione di truppe pannoniche alle guerre partiche di Settimio Severo e Caracalla (Z. Mráv)[224]. Nell’età dei Severi numerose opere pubbliche furono realizzate in Pannonia, per compensare l’economia locale indebolita a causa dell’assenza delle truppe impegnate in altre province. Fu Caracalla a promuovere la revisione delle frontiere tra le due Pannonie: alla sua spedizione germanica si riferisce il noto epitafio di Aquincum in Pannonia Inferiore; conosciamo un soldato della legio II Adiutrix morto di morte naturale a Lauriacum durante la spedizione contro gli Alemanni: defu(n)c(tus) exp(editione) Germ(anica) Lauri(aco) mort(e) sua; il defunto era aquilifer e vexillarius; il corpo è stato rimpatriato dopo la victoria Germanica[225]. Alla visita di Caracalla nel 213 è stata collegata l’epigrafe di Ad Statuas, in Pannonia posta per la ricostruzione del tempio del Deus invictus Sarapis [pro s]alute et victoria di Caracalla e Giulia Domna: dopo la vittoria del 213 la legio I Adiutrix stanziata a Brigetio fu dunque inclusa nella Pannonia Inferiore. La titolatura di Giulia Domna proposta da Z. Mráv è errata[226].
Come è noto P. Kovács ha ripreso le fonti relative all’età di Caracalla, ridimensionando il numero delle iscrizioni che secondo la vecchia tesi di J. Fitz potrebbero conservare riferimenti al viaggio[227]. Si veda in particolare Fontes Pannoniae Antiquae in aetate Severorum, edito da P. Kovács (Budapest 2007)[228]. A questo periodo (più probabilmente alla fine dell’età severiana) dovremmo riferire il liberto imperiale Aurelius Phaon, praeposit(us) lecticariorum, morto nel corso di una visita imperiale ad Aquincum, di cui a Budapest ci rimane il sarcofago[229].
Nel Norico citerei almeno i viaggi dei Severi ed in particolare ancora Caracalla alla vigilia della campagna contro gli Alamanni del 213, apparentemente nella XV potestà tribunizia ad Engelhartszell in Baviera, lungo il Danubio, a 15 miglia da Boiodorum: Viam iuxta amnem Danuviuum fieri iussit a Boiiodur(o) in [—] m.p. XV[230].
Le sei visite di Settimio Severo, Caracalla e Geta in Mesia Inferiore tra il 193 e il 211 sono state studiate da D. Boteva[231]. Le vexillationes dell’esercito del Danubio che dalla Mesia Inferiore hanno accompagnato Severo Alessandro nella spedizione contro i Parti fino ad Antiochia (Herod. VI, 4), sono citate in un ex voto collocato da un praepositus riconoscente, appena rientrato in Oltenia[232].
Gallieno è ricordato per le guerre contro i Marcomanni, ma P. Kovács ha raccolto le allusioni epigrafiche alla peste Antonina del 182 (lues)[233]; un caso ripreso da F. Steffan è quello di Bedaium nel Norico, con una famiglia travolta dalla peste[234].
A Piliscsaba in Pannonia Inferiore, G. Alföldy commenta la dedica Adventui [[[d(ominorum) n(ostrorum) Philipporum] Aug(ustorum duorum)]] effettuata nel 247 dagli ausiliari Cretenses della Cohors I Cretum o della cohors II Cretensis in Mesia Superiore[235].
In Pannonia a Bölcske un’iscrizione dedicata a Giove Teutanus l’11 giugno 251, [di]vis Deccis co(n)s(ulibus), per la salvezza di Treboniano Gallo (invictus Aug(ustus)) e Ostiliano (Aug(ustus)) permetterebbe di datare la battaglia di Abrittus tra il 27 maggio e il I giugno, che si concluse con la vittoria dei Goti e la morte di Decio e Erennio Etrusco (Cesare tra maggio-giugno 250)[236]. All’anno successivo (ancora all’11 giugno) collochiamo la dedica I(ovi) O(ptimo) M(aximo) Teutano et dis deabusq(ue) omnib(us) per la salvezza di Treboniano Gallo e Volusiano consoli[237].
Nella Pannonia Superiore è stata rivista da G. Alföldy la straordinaria dedica di Vienna rinvenuta negli scavi del 1899 alla confluenza della Wienfluss col Danubio; si tratta di un altare militare della serie che ricorda il Fluvius Acaunus: [I.]O.M. Neptuno [Aug(usto) S]alaceae Nimph[is Fluv]io Acauno dis [deabus]q(ue) omnibus, dove Salacia è la sposa di Nettuno; Acaunus è l’antico nome del fiume Wien, che sarebbe stato difeso da un attacco di barbari. La vexillatio della Legio VIII Augusta da Strasburgo, verso il 260 fu trasferita in Illirico a Sirmium contro Ingenuo e Regaliano, poi fu attiva nel Bellum Serdicense contro i due Macriani. Da Sirmium la vexillatio fu trattenuta a Vindobona dal 260 dopo l’usurpazione di Postumo che ne impediva il rientro. Solo nell’aprile-maggio 268, al momento della partenza da Vindobona, fu posto l’altare prima che la vexillatio partisse per Lauriacum in Norico dove avrebbe dovuto sostenere l’impegno della legio II Italica[238]. L’ara conserva un rilievo di Nettuno con tridente e delfino e di Eracle che trionfa su Acheloo, dio di un fiume in Etolia[239].
Presso Sirmium in Pannonia Inferiore, nella villa imperiale di Turris Ferrata, fu ucciso l’imperatore Probo dai soldati in rivolta[240]. Conosciamo inoltre una dedica a Caro, in occasione della marcia dell’imperatore attraverso la Rezia e il Norico verso Sirmium[241]; sulle circostanze della morte di Carino, P. Kovács ha studiato le province della Pannonia nella I tetrarchia in Fontes Pannoniae Antiquae (FPA VI) in aetate Tetrarcharum, I, 2011 con attenzione per le iscrizioni di portata storica, i diplomi, le iscrizioni su medaglie[242]. Più di recente nel 2013 è stato pubblicato il volume Fontes Pannoniae Antiquae in aetate Constantini, con l’incontro degli imperatori a Carnuntum, la divisione della Pannonia, il bellum Cibalense tra Costantino e Licinio, le guerre sarmatiche, la cristianizzazione[243]. Secondo E. Tóth i numerosi anelli ritrovati ad Iovia in Pannonia Inferiore poterebbero essere collegati alla visita di Costantino II a Sirmio nel 337[244].
8. Recenti acquisizioni sui fasti provinciali.
Dopo i lavori di B. Lőrincz conosciamo il governo provinciale della Pannonia e più in dettaglio i fasti della provincia, come il nuovo legato tra il 133 e il 136 M. Nonius Mucianus. Viene corretta la cronologia di sei governatori equestri dopo Gallieno, il primo dei quali è nel 267 d.C. T. Clementius Silvius[245]. P. Kovács, B. Fehér, Budapest nel 2005 hanno presentato una storia della Pannonia, mentre B. Lőrincz presenta la lista dei governatori[246].
Meno chiara la documentazione sulla Mesia Superiore, pure raccolta nel 2007 nel volume di Miroslava Mirković: Moesia Superior: eine Provinz an der mittleren Donau. Per il periodo fino all’86 d.C., i governatori della Mesia sono studiati da L. Mrozewicz oltre che da B.E. Thomasson[247]. W. Eck e A. Pangerl hanno rivisto la lista dei legati della Mesia Superiore dal 100 al 132, partendo da C. Cilnius Proculus[248]. La lista è stata arricchita da C.C. Petolescu su “Pontica” del 2012, fino a Diocleziano. Da Nevsa, territorio di Marcianopolis, proviene l’iscrizione di T. Flavius Longinus Q. Marcius Turbo, legato di Mesia Inferiore nel 155: per fines civitat[is Mar]cianopolitano[rum re]gione Gelegetio[rum in propi]nquo phruri n(umero) [—], dove il termine traslitterato dal greco phrurium indica il posto di guardia[249].
J. Źelazowski ha studiato l’attività giudiziaria, amministrativa, religiosa, edilizia documentata da iscrizioni onorare di 58 legati di Mesia Inferiore tra 86 e 275 d.C.[250]. I duces della Moesia secunda e della Scythia Minor tra III e VII secolo sono stati studiati da J. Wiewiorowski[251].
Nell’interpretazione di G. Alföldy, M. Cornelio Nigrino Curiatio Materno console sotto Domiziano dedica un tempio ad Oescus come leg(atus) Aug(usti) pr(o)pr(aetore) provinciae Moesie inferioris, dopo la divisione della Mesia. I dedicanti anonimi dell’86-89 sono membri di un collegio cultuale[252].
I. Piso presenta la lista dei governatori di Dacia, partendo da Traiano[253]. A.Barnea ha studiato la Prosopografia della Scizia minore a partire da Diocleziano, fino all’VIII secolo, anche alla luce delle nuove iscrizioni di Tomis[254].
9. La municipalizzazione.
Un tema particolarmente sviluppato è quello della municipalizzazione, che ha favorito il consolidarsi delle aristocrazie cittadine: in Rezia l’area appare in età imperiale abbastanza arretrata, povera, spopolata, poco romanizzata, con un impressionante sviluppo del latifondo imperiale; di conseguenza la municipalizzazione fu contenuta. In particolare nell’area retica (a Sud) non c’è traccia di municipi romani fino all’età dei Severi, ma solo di vici indigeni. L’area celtica della Vindelicia appare più urbanizzata, con gli oppida celtici di Brigantium (Bregenz), Cambodunum (Kempten) e Augusta Vindelicum (capitale provinciale della Rezia da età flavia)[255], che divennero municipi di cittadini romani, ma con qualche ritardo. Uno statuto municipale ottennero anche gli insediamenti civili collocati a ridosso degli accampamenti militari di Castra Regina (Ratisbona) e di Castra Batava (Passau). Un grande impulso ebbe la realizzazione di strade di collegamento lungo i valichi alpini, in direzione del Danubio e trasversalmente da Brigantium a Cambodunum ed a Castra Batava, per il controllo delle tribù retiche e vindelicie[256].
In Dalmazia la politica di municipalizzazione romana sembra iniziare con Cesare, cui si attribuisce la colonia di Narona: conosciamo le colonie di Iader, di Salona (però colonia Martia Augusta), di Epidauro (Ragusa-Cavtat). Approfondimenti si sono svolti sulla politica di municipalizzazione, come per Municipium Magnum (Balina Gravica) sotto i Flavi[257] o Lopsica (Senj in Croazia) già sotto i giulio-claudi[258]; ancora ai Flavi si attribuisce il municipio di Scardona. Da Krivoglavci presso Sarajevo abbiamo ora la documentazione (però in età Antonina) della concessione dello statuto municipale ad Aquae S(–)[259]. Per il municipium S(polistarum) sono stati fatti importanti passi avanti dopo l’edizione dell’iscrizione di Pljevlje presso Komini in Montenegro da parte di S. Loma e dopo l’intervento di Patrick Le Roux: Sextus Aur(elius) Lupianus Lupi filius princep(s municipii), onorato nella seconda metà del II secolo dai decuriones collegae et populares et peregrini incolae. Il testo pone il problema dello statuto ufficiale per cittadini locali populares e notabili decuriones collegae e testimonia il funzionamento delle istituzioni cittadine nella seconda metà II secolo. Per Loma si tratta invece di un cittadino romano di prima generazione princeps dei peregrini incolae[260], adtributi al municipio di Splonum (Komini), secondo quanto recetemente confermato da M. Mirković[261]. Più convincente la posizione di P. Le Roux per il quale Lupianus, princeps del municipio, si sarebbe adoperato presso i cittadini locali (populares) e i notabili (decuriones collegae) per assegnare agli stranieri residenti a Splonum (peregrii incolae) uno statuto ufficiale riconosciuto dalla comunità municipale[262].
Per la colonia di Salona un nuovo studio complessivo si deve a E. Marin edit., Longae Salonae, 2 voll., Split 2002, con studi onomastici, gentilizi, cognomi. Conosciamo nuovi IVviri di Salona, auguri e decurioni[263]. Molto dubbia appare l’edizione del testo dell’epigrafe di Teodosio II e Valentiniano III nella prima metà del V secolo, sulla porta “Andetria” (porta suburbia) e sulle mura di Salona edita da J. Jeličić-Radonić[264].
Altri inediti provengono da un sito per noi oggi particolarmente significativo, Skelani, Srebrenica, nella Repubblica Srbska di Bosnia Erzegovina: qui il Municipium Malve(n)sitatium fondato ben prima del 158 d.C. ci ha restituito alcuni clarissimi, equites, tribuni, centurioni, soldati della coorte I Delmatarum ed esponenti dell’aristocrazia cittadina, in particolare un II vir q(uin)[q(uennalis)][265].
Dal Municipium Magnum (Balina Glavica) G.F. Paci ha presentato un IIII vir iure dicundo e aedilis; la municipalizzazione sarebbe da colocarsi in età flavia per Glavaš, che ha studiato la statio dei beneficiarii[266].
Il capitolo della municipalizzazione del Norico si apre con particolare riguardo al tema delle autonomie municipali nei volumi The Autonomous Town of Noricum and Pannonia, con gli atti del colloquio di Brdo in Slovenia: si tratta di una sintesi sulle città del Norico: Celeia, Virunum, Teurnia, Aguntum[267], Iuvavum, Flavia Solva, Cetium, Ovilava e Lauriacum. P. Scherrer in particolare presenta uno studio approfondito sull’urbanizzazione della provincia, antroponimi e teonimi[268]. Tra i documenti principali emerge ora il Fragmentum Lauriacense rinvenuto a Lorch studiato da H. Grassl, che propone un parallelo tra i paragrafi frammentari della legge municipale di Lauriacum e documenti analoghi provenienti da Italia e Penisola Iberica, in particolare la lex Irnitana[269]. Recentemente è stato proposto un confronto del Fragentum Lauriacense con la tavola di Eraclea, con una proposta di restituzione del testo[270]. Proprio partendo dagli ultimi studi G. Winkler ha tracciato la storia di Lauriacum anche attraverso le iscrizioni[271].
E. Weber ha studiato ad Ovilava nel Norico la dedica effettuata a Diocleziano nel 285 dall’ordo col(oniae) Ovil(avensium) devotus numini maiestatisq(ue) eius[272]. Altri studi sono stati dedicati a Flavia Solva, a Celeia e al municipium Aelium Cetium, partendo anche dall’epitafio di Nussdorf ob der Traisen che ricorda un C. Ausonius Sergia Silvinus, dove Sergia è la tribù del municipio[273]. In Bassa Austria St. Leonhard am Forst, Winkler presenta la larga famiglia di M. Sextius Vettonianus aedilis municipii Aelii Cetii, morto a 70 anni; la famiglia, composta di immigrati, viene seguita per più generazioni, all’interno del municipio di Adriano[274].
Le autonomie municipali della Pannonia sono studiate nel II volume dei citati Atti del convegno di Brdo, con una sintesi sulle città pannoniche: Vol. I Savaria, Scarbantia, Noviodunum, Andautonia, Siscia, Poetovio, Salla; Vol. II Carnuntum, Vindobona, Mogetiana, Mursella, Municipium Iasorum (Aquae Balissae), civitas Iovia, Sirmium, Mursa, Cibalae, Gorsium, Aquincum, Brigetio, Bassianae, Sopianae[275]. Per Poetovio, Sarmizegetusa e altre città traianee vd. ora I. Piso e R. Varga, Trajan und seine Städte, Cluj-Napoca 2014. In particolare Z. Mráv ha studiato la politica di Settimio Severo e le città della Pannonia: fondazioni, cambi di statuto, costruzioni imperiali. Le iscrizioni ci consentono di osservare il passaggio del municipio di Aquincum fondato da Adriano[276], promosso da Settimio Severo a colonia nel 194: prima di questa data conosciamo P. Aelius Perpetuus decurio municipi Aquincensium e M. Fouiacius Verus Iunior decurio canabarum decurio municipii Aquincensium augur[277]. Più tardi un decurione della colonia Aquincensium ricostruisce una schola ad Aquincum. Conosciamo diversi sexviri, decuriones coloniae Aquincensium, aediles, flaminici.
A Törökbálint in Pannonia Inferiore, una dedica a Giunone è posta da M. Aur(elius) Epigonus dec(urio) col(oniae) Aq(uincensium) originario dell’oriente greco, come lo era gran parte dell’élite municipale di Aquincum alla metà III sec.[278]
Il municipium Spondent(ium ?) della Pannonia Inferiore (in una località collocata a Sud-Est della provincia, forse Ušće, presso Obrenovac) è menzionato in un’iscrizione di Bassianae (oggi presso Donji Petrovci in Serbia, studiata da S. Dušanić ed ora da A. Crnobrnja[279]; Bassianae fu municipio di Adriano e colonia di Caracalla: conosciamo un P. Aelius Ce(n)sorinus d(ecurio) col(oniae) Bas(sianensium) ex voto posuit, sicuramente appartenente ad una famiglia del municipio antonino[280]. Altre iscrizioni ricordano la c(olonia) M(ursensium)[281].
Il ruolo di Traiano nella urbanizzazione della Pannonia è evidente a Poetovio, dove Mráv studia la realizzazione del foro attorno al 106 Coloniae Ulpiae Traianae Poetovionensium[282]; conosciamo casi analoghi a Sarmizegetusa e Vindobona tra il 103 e il 106; in Numidia a Thamugadi.
Nel tempio di Giove [depu]lsor di Savaria viene realizzato un po[rticum cum aeto]na, [pro salute Savariensium], per iniziaiva di un de[c(urio)] c(oloniae) U(lpiae) T(raianae) Poet(oviensium).[283] Conosciamo il monumento di Carnuntum-Petronell studiato da W. Jobst e M. Kandler. Alla fondazione traianea tra il 106 e il 111 allude anche l’epigrafe su placca metallica ritrovata tra i principia e il praetorium dell’accampamento della legio XV Apollinaris di Carnuntum, riletta da Z. Mráv[284]. A Brigetio un’iscrizione conferma che Settimio Severo nella terza potestà tribunizia, dopo la partenza della legio I Adiutrix fonda nel 195 il municipio[285]. Tra i Severi, si ricorderà la rara dedica a Fulvia Plautilla, sponsa di Caracalla, effettuata all’inizio del 202 dalla res [pu]lica Ia[s(orum)], poi Aquae Balissae, oggi Daruvar in Croazia[286]. Un’analoga dedica effettuata dalla res publ(ica) Siscianorum proviene da Sisak[287].
Il vicus di Carnuntum fu promosso da Adriano Municipio Elio e poi colonia: G. Alföldy ha studiato le iscrizioni del tumulus della grande villa romana a 10 km dal lago Balaton, che ricordano tre diverse generazioni: emerge un cavaliere [decurio c]oloniae Cl(audiae) S(avariae) [omnib(us) honor(ibus)] funct(o) [in mun(icipio) Ael(io) Ca]rn(unto)[288]; conosciamo almeno un figlio che è stato decurione del municipio fondato da Adriano[289]. Carnuntum più tardi diviene colonia. Nell’età di Marco Aurelio la famiglia sembra estinguersi e nei primi anni dell’età dei Severi i nuovi proprietari hanno ulteriormente esteso la villa lasciando però intatto il tumulo[290].
A Savaria in Pannonia Superiore l’onomastica dei notabili indigeni dimostra secondo E. Szabó l’attribuzione dello ius Latii, ben prima della fondazione della colonia di Claudio[291].
Attraverso l’antroponomastica degli Azali, D. Grbić ritiene che la civitas Azaliorum sia stata costituita per volontà imperiale con il trasferimento di popolazione prevalentemente celtica o celto-pannonica, non illirica[292]. Il municipium adrianeo di Mogetiana oggi Tüskevár, nel territorio sottratto alla civitas Azaliorum,è localizzato sulla strada da Savaria ad Aquincum[293]: una funeraria municipii Mog(etianae) ricorda un quaestorius, decurio municipi. Possediamo nel foro anche la base di una statua di Filippo l’Arabo nella sua seconda potestà tribunizia (a. 245) dall’ordo Mog(ionensium)[294].
Per la Pannonia Superiore citeremo il manuale di M. Kronberger sugli spazi funerari e le sepolture delle canabae di Vindobona, con gli aspetti legati alla cronologia e all’evoluzione, sulla base di numerose iscrizioni lapidarie e sull’instrumentum[295]. La recente pubblicazione della tesi di H. Ubl sui monumenti funerari si estende al Norico e alle Pannonie, con attenzione all’armamento e alle uniformi dei soldati dell’esercito imperiale[296]. Significativa la rilettura dell’iscrizione metrica di Scarbantia, con un quadro complesso di relazioni familiari[297]. Numerose informazioni possediamo sui pagi rurali della Pannonia[298], così come sui vici con un proprio territorium e le civitates peregrine[299].
Il tema dell’urbanizzazione dell’Oltenia (nella Dacia sud-occidentale) è trattato da C.C. Petolescu con riferimento alla Colonia Malvensis a Cioroiu Nou; a Romula municipio dopo Adriano, colonia di Severo; ad Ampelum e Sucidava municipi di Severo[300]; D. Benea ha studiato Tibiscum e Dierna[301]. Per C.C. Petolescu la menzione a Celei di curial(es) territ(orii) Suc(idavensis) dimostrerebbe che Sucidava ha ricevuto lo statuto di municipio[302].
Per la Dacia è stata studiata l’urbanizzazione, la municipalizzazione, le colonie, le fortezze, le città e le regiones del patrimonio imperiale (metalla, praedia), i villaggi, i pagi, i vici, le canabae, sempre con un’interazione con il mondo militare in ambito rurale[303]; i vici militares nella Dacia romana sono stati illustrati da D. Benea, specie Tibiscum[304].
I nuovi frammenti del trofeo di Traiano dal forum vetus di Sarmizegetusa ricordano la titolatura della [colonia Ulpia Traiana Aug(usta) D]acica Sa[rmizegetusa], che dedica [condit]o[ri s]uo tra il 116 e il 117[305]. Gli scavi nel forum vetus fondato da Traiano[306], hanno riportato alla luce ben 106 iscrizioni, studiate nel citato volume curato da I. Piso, tra le quali quella che contiene l’espressione condita colonia [Ulpia Traiana Augusta] Dacica [Sarmizegetusa], per l’intervento del legato: per [D. Terenti]um Scaurianum: secondo I. Piso si tratterebbe di un monumento commemorativo analogo a quello, famosissimo, di Uchi Maius in Africa Proconsolare sotto Severo Alessandro[307]. Sorprende il numero delle dediche effettuate nell’età di Traiano; la successiva dedica ad Adriano consul III reimpiegata nel pavimento e la conduttura in piombo della Coloniae Dacicae Sarmigegetusae, con i IIviri della fine del regno di Traiano[308]. Infine il monumento a divinità ignota per la salvezza di Marco Aurelio tra il 172 e il 175[309]; nello stesso periodo (o nei primi anni di Commodo) sarebbe stata costruita l’aedes augustalibus a spese del flamen col(oniae) M. Proc(ilius) M.f. Pap(iria) Niceta[310]; sappiamo che lo stesso edificio fu allora decorato ope[re tect]orio et picturis item sc[alis sigi]llis et linteis; senza dimenticare i [can]delabra aerea duo[311]. Conosciamo numerosi monumenti studiati da Piso, come quello di Opellius Adiutor, decurio coloniae IIvir iuris dicundi praefectus collegii fabrum, che si data attorno al 150, dopo la costruzione del forum novum.
Dopo la morte di Lucio Vero si pone nel 172 la dedica a M. Aurelio da parte della colonia Ul(pia) Traian(a) Aug(usta) Dac(ica) [Sarmizegetusa] ancipiti periculo virtutib(us) restituta, con allusione alla invasione dei Marcomanni del 170 e alle virtù dell’imperatore, associato ad una divinità incerta[312]. Pro salute di Commodo possediamo numerose dediche poste dai patroni del coll(egium) fabr(um), dagli Aug(ustales) col(oniae), dai decurioni appartenenti all’ordine equestre[313].
A partire dalla più antica attestazione relativa ad una città (Mesembria) di quella che sarebbe diventata la Mesia di inizio I secolo a.C., in relazione alle guerre contro Mitridate[314], Mladenović ha studiato l’evergetismo e munificenza nelle città della provincia [315]. Dal Municipium Dardanorum in Kosovo (Mesia Superiore) proviene la dedica M. N(ovellio) M.f. Quirina Montan(o) un cavaliere procuratore di Commodo, effettuata da M. Novel(lius) Eros pri(n)ceps m(unicipii) D(ar)[d(anorum)], apparentemente originario di Scupi. M. Novellio Montano potrebbe essere il patrono del dedicante, forse procurator metallorum sotto Commodo; è noto che verso la fine del II secolo la civitas Dardanorum diviene municipio. Il titolo di princeps alluderebbe per P. Le Roux al primo dei decurioni del municipio, senza un rapporto con l’amministrazione delle miniere come immaginato da Dušanić[316]. Da Sočanica (Municipium Dardanorum in Mesia Superiore) proviene la dedica effettuata tra il 136 e il 137 di un tempio per ricordare l’eroe Antinoo, su disposizione di Adriano e L. Elio Cesare: Antinoo He[roi aedem ?], con l’intervento dei coloni arg[entariarum Dardanicarum] curante Thelesph[oro], un liberto imperiale[317].
A Viminacium un epitafio è dedicato a T. Baeb(io) Eytychi Aug(ustali) mun(icipii) Ael(i) Vim(inacii) e a sua moglie, anch’essa patrona del municipio, per iniziativa del liberto T. Baeb(ius) Abascantus[318].
I. Piso ha studiato i forenses di Brigetio, che sarebbero gli abitanti di un vicus distante due km dal campo legionario, arrivato alla condizione di municipio sotto Settimio Severo[319].
All’inizio del II secolo in Mesia Inferiore ad Oescus conosciamo un M. Iulius Felix decurio coloniae: nessuna altra città della provincia ha avuto la condizione di colonia prima del II secolo[320].
Ad Oescus (oggi Gigen) abbiamo in età severiana la testimonianza della organizzazione dei saltus cittadini: conosciamo un cavaliere romano flam(en) et IIviral(is) col(oniae) praef(ectus) salt(us), una funzione sicuramenrte municipale[321], poi patronus colleg(ii) fabror(um) coloniar(um) Oesc(ensium) et Apul(ensium) patronus col(oniae) Ulpiae Oescensium bonus civis et amator rei p(ublicae), onorato dall’ordo[322].
L’organizzazione dei villaggi della Dobrugia romana è studiata da A. Suceveanu, con attenzione all’organizzazione amministrativa, alle strutture sociali, al regime del suolo, alle attività economiche, alla vita religiosa dei vici attraverso le iscrizioni[323]. Le iscrizioni rinvenute durante gli scavi del periodo 1981-92 a Murighiol in Mesia Inferiore (Halmyris) sono state studiate nel 2003; tra esse segnalerei quella posta dai [c(ives) R(omani) c(onsistentes) vic]o class(icorum) nell’età di Commodo[324] e riprese da M. Zahariade e C.-G. Alexandrescu, nel catalogo Greek and Latin inscriptions from Halmyris. Inscriptions on stone, signa, and instrumenta found between 1981 and 2010, Oxford 2011[325]. Il fortino costantiniano di Mihai Bravu nel distretto di Tulcea in Romania ci ha restituito l’iscrizione del Vicus Bad(—) che sarà presentata da Antonio Ibba e Lucreţiu Mihăilescu Bîrliba a questo convegno. Da Silistra in Mesia Inferiore, una dedica Iovi Opt[i]mo Maximo ci consente di localizzare il vicus Gravidin(a) ad Ostrov presso il muunicipium Aurelium Durostorum[326].
Da Sacidava in Mesia Inferiore proviene la funeraria di un militare trace, Diozenus Rigozi (filius), con l’inedito titolo di subte(serarius) bur(gariorum); conosciamo invece i burgarii in Dobroudja a Tropaeum e Sucidava[327]; uno studio frontale sul Municipium Traianum Tropaeum fondato nel 109 d.C. come Sarmizegetusa è ora di E. Popescu[328]. I monumenti epigrafici del municipium Montanensium in Mesia Inferiore sono raccolti da V. Veljov e G. Aleksandrov[329].
I primi pontarchi ad Histria e Callatis, nel Ponto della metà del II secolo, sono studiati da A. Avram, M. Bărbulescu, M. Ionescu[330]. La pentapoli del koinon del Ponto, con la dubbia posizione di Mesembria assegnata in seguito alla Tracia, è studiata da M. Tačeva[331].
Da Abrittus (oggi Razgrad) in Mesia Inferiore abbiamo due dediche effettutate dai Vet(erani) et c(ives) R(omani) [co]nsistentes Abritto, una delle due sotto Elagabalo nel 222 d.C. [332]
10. Alcuni populi e nationes.
Moltissime novità sono state raccolte negli ultimi decenni sui confini tra populi differenti, ad esempio tra Isarci della Rezia e i Saevates del Norico, lungo la vallata dell’Eisack, che segnava la frontiera tra Norico e Rezia, in rapporto alla regio X, con la sicura localizzazione a Kollman di Sublavio[333].
Estremamente significativa è la nuova documentazione relativa alla Civitas Eraviscorum nella grande ansa del Danubio, che fa perno attorno a Budapest, l’antica Aquincum: E. Szabó rifiuta l’ipotesi che la civitas Eraviscoum sia stata attribuita al municipio di Aquincum. Il fatto che due decurioni siano notabili di un municipium Aelium Aquincensium e della civitas Eraviscoum non significa che la civitas fosse adtributa al municipium[334]. A proposito della frontiera tra Aquincum e la civitas Eraviscorum J. Fitz, studiando le iscrizioni del comitato di Fejér, distingue le località a Nord della via Aquileia-Gorsium-Aquincum (pienamente aggregate al municipio) e quelle a Sud (rimaste autonome, comunque entro la civitas). Dopo la sconfitta di Valeriano ad Edessa nel 260, in occasione dell’attacco dei Sarmati, molti monumenti di Gorsium e delle località travolte dai barbari furono trasportati a Intercisa, utilizzati per ricostruire le fortificazioni del limes. Sono 38 i monumenti epigrafici repertoriati nel territorio di Aquincum[335]. I limiti occidentali e meridionali della civitas Eraviscorum e del territorio di Aquincum arrivavano fino al lago Balaton (ad occidente) e Vajta (a mezzogiorno). La principale divinità eravisca a Gorsium era Iupiter, invocato pro salute degli imperatori et pro incolumitate civitatis Eraviscorum. J. Fitz ha studiato la dedica De[o T]eutano p[ro s]alute templ(ensium) effettuata da un tribuno della coorte III B(atavorum). Come è noto all’XI secolo risale lo smantellamento della fortificazione, trasferita a Székesfehérvár da Gorsium e non da Aquincum[336]. Allo stesso Dio sono dedicate le iscrizioni di Bölcske (Komitat Tolna), sulla riva destra del Danubio: sono stati ritrovati ben 39 altari votivi e 2 funerari, i più antichi della Pannonia Inferiore, alcuni da Aquincum, Campona, Vetus Salina, dedicati per la salvezza degli imperatori del II e del III secolo, oltre che come si è detto pro salute civitatis Eraviscorum. Tutti gli altari sono dedicati a I(upiter) O(ptimus) M(aximus) Teutanus (associato talora a Giunone Regina), collocati dai magistrati cittadini, hanno la data dell’11 giugno (festa di Mater Matuta), come per I.O.M. Karnuntinus a Carnuntum[337]; si tratta più probabilmente di una festa religiosa indigena oppure ricorre l’anniversario del giorno del citato miracolo della pioggia per M. Aurelio[338]. Per Piso l’11 giugno è data del primo sacrificio I.O.M. in Pannonia; la data è stata mantenuta anche dopo la divisione provinciale. Non sembra fondata di conseguenza l’ipotesi di P. Scherrer che ora collega la data dell’11 giugno (sulle dediche a Iupiter Optimus Maximus Teutanus e K(arnuntinus) ad Aquincum e Carnuntum) al reclutamento militare effettuato attraverso l’organizzazione dei collegia iuvenum[339].
Gli Anartii, una tribù imparentata con gli Eravischi, ricordati a Tusculum per esser stati sconfitti dal legato [M(arcus) Vinu]ciu[s P(ubli) f(ilius)] già nell’età di Augusto (Anarti[os sub potestatem Imp(eratoris) Caesaris A]ugusti [et p(opuli) R(omani) redegit)[340] sono documentati a Budapest (Aquincum), in uno dei primi esempi di assegnazione della civitas alla Pannonia del NE: la tribù era precedentemente collocata all’esterno delle frontiere dell’impero[341]. In epoca Flavia conosciamo una Iulia Utta Epponis f. Florina natione Anartia[342]. Un vicus della tribù degli Anar[tii] della pianura ungherese è tra i dedicanti di un altare ad Ercole a Pagus Herculius a Budaörs in Pannonia Inferiore[343].
A Baden (Aquae, in Pannonia Superiore), abbiamo un diploma di Antonino Pio relativo ad un ex gregale della flotta di Miseno Boius ex Pannon(ia), originario della tribù dei Boi, congedato il 26 ottobre 145[344].
Se passiamo al Barbaricum, da Dunàntul e dalle Regioni transdanubiane dell’Ungheria, più precisamente dal territorio degli Azali (tra il Danubio e il lago Balaton) proviene il diploma studiato da Lőrincz dell’ex pedite della cohors II Alpinorum Terius Dasentis filius Azalus. Evidentemente il veterano è tornato in patria[345]. Un marinaio, un ex gregale era Niger Siusi f. Azalus, del diploma di Arrabona, che si è spostato nel 161 dopo il congedo[346]. Si segnala la clausola a favore dei liberi decurionum et centurionum item caligatorum quos antequam in castra irent procreatos, dunque nati prima che il padre caligatus (soldato semplice) prendesse servizio.
L’espressione generale natione Pannonius o Pannonicus riferita non esattamente ad un popolo ma ad un’origo[347], dalla Pannonia ricorre una ventina di volte nell’impero per militari e civili, in particolare a Salona[348], Hardomilje in Bosnia[349], ma anche in Siria, in Cilicia, in Gallia, in Germania, a Ravenna e a Roma[350]. Analoga diffusione ha l’espressione natione Noricus a Salona[351], Aquincum[352], Mogontiacum [353], Roma[354], Caesarea di Mauretania[355]; più rari sono i documenti relativi a natione Dalmata o Dalmaticus, abitualmente marinai della flotta di Ravenna[356] ed a natione Raetus a Roma[357]; si veda anche natione Moesia inf(eriore) civitate Oesci di un epitafio romano[358]. Numerosi Salonitani hanno servito a Roma nelle coorti pretorie[359].
I Sarmati sono ancora all’epoca di Commodo considerati latrunculi e non hostes, tra Aquincum e Intercisa[360]. M.F. Petraccia ha studiato la presenza di latrones a Drobeta[361], da non confondere con gli stationarii assassini di Timacum Minus[362]; a Naissus V. Nedeljković rivede parzialmente l’edizione di un’iscrizione funeraria di un iuvenis qui (i)nnocuus vi[x(it) a(nnos) X]X dilectus: qui[i] miserand[us a ]pessimam gentem, quu[etus] dum restaret per[em]tus, forse ucciso dai latrones[363].
11. Gli immigrati.
Le immigrazioni di Italici e da altre province, in particolare dalla Siria, dalla Numidia e dalla Mauretania, dalla Penisola Iberica, sono state ampiamente studiate[364]. Le regioni di origine dei militari, la sistemazione dei veterani attraverso i tituli veteranorum delle province danubiane sono sintetizzati da K. Królczyk[365]. B. Fehér ha studiato i molti nomi siriaci in Pannonia Inferiore dopo le guerre marcomanniche a Ulcisia e Intercisa, segnalando la persistenza dell’onomastica siriaca e giudaico-siriaca[366]. Ma nel 2012 è uscito il volume sulle unità siriane sul Danubio di O. Ţentea, Ex Oriente ad Danubium. The Syrian units on the Danube frontier of the Roman Empire, Cluj-Napoca 2012, con alcuni problemi di traduzione.
In Mesia a Viminacium Weber ha affrontato il tema degli immigrati dall’Oriente: Eusebius filiu[s] Antianu civis Germaniceu<s> ex vico Abdarmisu, IV secolo, originario di Germanicia in Commagene, villaggio di Abdarmisus qui citato per la prima volta[367].
Gli immigrati richiamerei alcuni casi particolarmente significativi: a Višegrad in Bosnia, un personaggio domo Hadrumeto arrivato dall’Africa Proconsolare[368], a Poetovio in Pannonia Superiore ex region(e) Dolich(e) a vico Arpuartura nell’età di Valeriano e Gallieno[369], a Savaria un cives Surus ex regione Zeugma[370]; nel municipium di Troesmis sono documentate alcune famiglie di Ancyra[371].
L’immigrazione di Carpi in Pannonia nell’età di Dioleziano studiata da P. Kovács[372] ci è documentata dall’incredibile carriera di un personaggio, (Flavius) Maximinus, orignario del popolo dei Carpi trasferiti nella Valeria ma ammessi ai gradi più alti dell’impero, come documentano, oltre che il 28° libro delle Storie di Ammiano Marcellino, soprattutto i miliari stradali della Sardinia nell’età di Valentiniano I, Valente e Graziano, fino al 371 e al prestigiosissimo incarico di prefetto del pretorio per le Gallie, con l’improvvisa disgrazia e la condanna a morte nel 376 per volontà di Graziano. L’episodio testimonia in modo sorprendente la mobilità sociale e la possibilità per una famiglia proveniente dal Barbaricum occupato dai Carpi di innalzarsi nell’aristocrazia della provincia e nell’impero, pur mantenedo una cultura fondata su tradizioni ancestrali legate al mondo della magia[373].
Tra gli immigrati in Dacia si segnala il libro di Lucreţiu Mihăilescu-Bîrliba, Ex toto orbe Romano: Immigration into Roman Dacia. With Prosopographical Observations on the Population of Dacia, Peeters, Leuven-Paris-Walpole 2011[374]. Recentemente G. Cupcea ha stampato nel Regno Unito la sua tesi dottorale sulle carriere dei militari semplici nella Dacia romana (a. 2014).
In generale sorprende la varietà delle immigrazioni in Dacia, in particolare a livello di aristocrazie cittadine: nomi illirici dall’area dalmato pannonica[375]; altri immigrati dalla penisola italiana, dalla Tracia[376], dal Norico[377], dalla Gallia celtica (Mihăilescu-Bîrliba), dall’Asia Minore[378].
12. Opere pubbliche.
La viabilità stradale balcanica è stata rapidamente ricostruita da Raimondo Zucca e Barbara Sanna in rapporto alle tabernae ed ai praetoria, infrastrutture che costituivano un sistema al servizio del governo provinciale e dell’esercito, come in Mesia, già con la prima occupazione ma soprattutto in età tarda come testimoniano le fonti agiografiche ora rivisitate[379]. In sintesi si può rinviare al lavoro sul sistema stradale della Dacia di F. Fodorean, con la presentazione delle più recenti scoperte di nuovi miliari[380]. Il ponte di Drobeta (in Dacia Superiore, non Inferiore come supposto da D. Benea)[381] costruito da Traiano, fu abbandonato temporaneamente, poi restaurato da Adriano. La ricostruzione della strada tra Remesiana e Naissus in Mesia Superiore potrebbe esser collegata alla guerra persinana di Severo Alessandro[382].
Le iscrizioni ci conservano il ricordo della realizzazione di numerosissime opere pubbliche, basiliche, templi, edifici di spettacolo, in ambito cittadino o castrense. Solo un esempio: nell’età di Commodo nell’estate 185 la cohors I Aurelia Antonina milliaria Hemesenorum con il legato L. Cornelius Felix Plotianus è impegnata nella realizzazione delle porte del campo militare di Intercisa, in Pannonia Inferiore[383]; qui potrebbe essere localizzata una statio, di cui conosciamo 15 beneficiarii[384].
Le fortificazioni romane tra Belgrado (Singidunum) e Prahovo (ad Aquas) nella Mesia Superiore sono studiate nel volume di M. Mirković[385]. In Mesia Inferiore ad Halmyris è molto nota la costruzione della fortezza destinata a durare in eterno sotto Diocleziano e Massimiano: post debellatas hostium gentes profuturum in aeternum rei publicae constituerunt presidium: il tempo in rapporto allo spazio universale[386].
13. L’esercito: legioni, coorti, alae, flotta.
Molto complesso è il capitolo sull’esercito in area danubiana, che in questa sede può essere solo accennato, con riferimento ai castra legionari, ai campi ausiliari delle coorti e delle alae, alla flotta. In Rezia inizialmente operavano soprattutto unità ausiliarie[387], come presso le Aquae Phoebianae, Biriciana, Mediana, Vetoniana[388], poi a Windisch è documentata la legio XXI dal 45 al 69 d.C., sostituita poi dal 70 al 101 d.C. dalla Legio XI Claudia Pia Fidelis, di cui ci rimangono i bolli della guarnigione. Più incerta la presenza della legio III Italica ad Augusta Vindelicorum e non a Ratisbona sotto Commodo: la metropoli provinciale (per Tacito splendidissima Raetiae colonia) Augsburg in Baviera in precedenza nel I secolo aveva accolto nell’accampamento una vexillatio legionaria e un’ala di cavalleria[389]; sappiamo che ospitava il governatore e la stazione doganale della quadragesima Galliarum: Géza Alföldy presenta la dedica a Mercurio[390] nell’età di Commodo da parte di Appius Cl(audius) Lateranus co(n)s(ul) design(atus) leg(atus) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) leg(ionis) III Ital(icae), che però non sarebbe il governatore della Rezia, ma solo il comandante legionario nel 188 d.C. durante l’expeditio Germanica tertia[391]. Terminata la missione, designato al consolato, dedica un altare ad Augsburg. Rimangono le perplessità di Rudolf Haensch, che non si spiega la ragione por la quale un comandante legionario abbia elevato il monumento ad Augsburg la capitale e non a Ratisbona dove si trovava la legione. Eppure gli altri governatori sono chiamati legatus Augusti propretore provinciae Raetiae.
I principali campi di ausiliari recentemente studiati sono quelli di Heidenheim (il campo dell’Ala II Flavia Miliaria) e di Gnotzheim per la III Coorte di Traci: si discute su Q. Gavius Fulvius Proculus, prefetto della coorte, cavaliere originario di Caiatia a N di Capua, come testimonia la dedica a Diana[392]. Il campo di Eining-Unterfeld (Abusina) in Baviera e il suo vicus hanno restituito recentemente diplomi[393] e preziose testimonianze della cohors III Britannorum equitata[394]. Le fortificazioni collocate a Nord del Danubio sarebbero state distrutte e abbandonate nel corso dell’anarchia militare del III secolo, e rioccupate da Diocleziano[395].
Nel Norico conosciamo legioni, reparti ausiliari, ufficiali, soldati e veterani. A Lorch documentata alla fine del II secolo la legio II Italica anche nella dedica di Faustinus cohortis I pilus posterior[396]. Ma la legione arriva ben oltre Valeriano, affiancata dalla legio I Noricorum creata da Diocleziano per difendere il Noricum Ripense: conosciamo le officine legionarie, figulinas i(u)vensianas leg(ionis) primae Nor(icorum)[397].
La caratteristica militare del territorio della Dalmazia (che con Augusto era controllato da ben sei legioni) andò sfumando nel tempo, tanto che a partire dall’età di Vespasiano la Dalmazia appare controllata ormai solo da reparti ausiliari ed in particolare da coorti di Dalmati, impiegati ampiamente anche nella flotta da guerra che aveva la base principale a Ravenna, come testimonia ad esempio il diploma del 5 aprile 71 d.C. dell’età di Vespasiano, con il nome di un tessera[rius] Tarsa Duzi f. [Bessus] e di suo figlio Macedo[398]: ciò spiega anche la rapida municipalizzazione in età flavia. Una rilettura di un epitafio del Museo di Split consente di ricostruire il nome di un T. Ti[turius] domo Fab[ia Brixia] spec(ulator) leg(ionis) X[I C(laudiae) p.f.] nel corso del I secolo[399]. La cohors VIII voluntariorum, di guarnigione a Tilurium, ora documentata a Salona[400], è nota da almeno 409 iscrizioni in Dalmazia: per I. Matijević si tratta dell’unica unità stazionata ininterrottamente in Dalmazia durante tutto il principato[401].
La legio X gemina Pia Fidelis è ugualmente ben documentata: recentemente I. Matijević ha studiato i beneficiarii consularis della legio X Gemina (a Salona in Dalmazia)[402]. J. Jeličic Radonić ha affrontato il tema delle promozioni degli equites singulares Augusti sotto Adriano sempre a Salona, seguendo la dettagliatissima carriera di T. Fl(avius) T.f. Pol(lia) castr(is) Lucilius, figlio di un peregrino, la cui origo è castr(is), un vexillarius che ha svolto una brillante carriera militare, arrivando al grado di centurione nella VIII coorte di vol(untarii), di stanza in Dalmazia; infine congedato nell’età di Adriano. Il testo è stato recentemente rettificato da P. Faure[403]. Un centurione primo pilo, centurione della IV Flavia creata da Vespasiano in Dalmazia, di stanza tra il 70 e il 85 a Burnum, poi in Mesia dalla fine I secolo.
Sull’epigrafia militare della Pannonia sono fondamentali i volumi di B. Lőrincz su molti aspetti relativi alle unità ausiliarie, storia, campi, spostamenti, monumenti posti dai militari, carriere ufficiali, centurioni, decurioni, catalogo dei documenti[404].
Ad Aquincum è documentata la Legione II Adiutrix, con effettivi provenienti anche da Amastris in Paflagonia o da Arelate in Narbonense a partire dall’età di Traiano: un’imponente documentazione è relativa a legati, praefecti legionis, centurioni, optiones[405], cornicularii[406], custodes armorum[407], stratores[408], aquiliferi, signiferi[409], vexillarii[410], capsarii[411], veterani, medici militari[412], candidati[413].
A Bölcske Z. Mráv studia il primipilo della legione II Adiutrix di Aquincum alla testa della ala I Thracum, forse a seguito della morte o improvvisa malattia del prefetto dell’ala arrivata da Campona[414].
A Bécsi in Pannonia Inferiore nel corso degli scavi è venuto alla luce l’epitafio di Fl(avius) Ursus biarcus ex numero equites Dalmatas degentium Cirpi, un soldato graduato dell’esercito di Costantino, tra i soldati accantonati a Cirpi, oggi Dunabogdány, nel Comitato di Pest[415].
A Visegrád – Lapence, entro la provincia Valeria, nell’età di Valentiniano, Valente e Graziano (371 d.C.) conosciamo un Foscianus p(rae)p(ositus) legionis prim[ae Mar]tiorum, agli ordini di un Equitius utriusque militiae magister per Illyricum incaricato da Valentiniano I di fortificare il Danubio[416].
Inoltre la cohors I Lusitanorum doveva essere accampata a Cornacum (oggi Sotin) in Pannonia Inferiore; conosciamo un veterano ex c(enturione) M. Aurel(ius) Serenus, domo Bass(ianis) [417].
Ben documentata negli ultimi anni è anche la legio XV Apollinaris a Vindobona e poi a Carnuntum[418].
Gli ultimi studi sui campi militari hanno dimostrato che l’accampamento di Vindobona ospitava la legio XIII Gemina, almeno a partire dal 68 all’epoca di Galba. Proprio per Vindobona possediamo lo studio di M. Mosser sulle origini dell’accampamento della legio XV Apollinaris, dove vengono raccolte tutte le iscrizioni provenienti dal muro sud-orientale del campo legionario[419]: possediamo gli epitafi più antichi (anche del I secolo) riutilizzati nella fortificazione del III, con tracce del precedente campo legionario in legno. Già sotto Traiano la legio XIV Gemina Martia Victrix era a Vindobona (sostituita dalla legio X Gemina Severiana), poi a Carnuntum: conosciamo alcuni beneficiarii. Particolarmente significativa la menzione dei navalia della legio XIIII Gemina presso il porto fluviale di Carnuntum, dove conosciamo nel II secolo d.C. un vet(eranus) ex magistr(o) navalior(um) leg(ionis) XIIII G(eminae), con tutta probabilità in origine un marinaio o comunque un ausiliario trasferito nella legione, come sembrerebbe testimoniato dall’utilizzo dell’espressione nation(e) Hispan(us) Tarraconensis[420].
Per Canuntum (Petronell) ci rimangono numerose stele funerarie dei militari della legio XV Apollinaris, con tribuni come L. Cossutius L. f. Sabatina Costa, originario d’Italia, nell’ epoca di Claudio[421]; milites, equites, missicii; un veteranus è arrivato all’età di 108 anni, L. Varius Secundus[422].
Oltre che nelle canabae di Carnuntum, la legione, assente tra Nerone e i primi anni di Vespasiano come testimoniano i bolli, è documentata a Scarbantia[423] e a Savaria: a Szombathely A. Szabó ha presentato il caso del veterano della legione XV Apollinaris Sex. Utti[e]dius C.f. Celer della tribù Claudia che ha partecipato all’installazione della colonia Claudia Savaria nel I secolo d.C.; tra i parenti forse una Valenti(na) Prov[i]nciae l(iberta)[424].
Altri sigilli in piombo ci ricodano i privilegi doganali dei prodotti destinati alla legio I Adiutrix ex Belg(ica), che lascia Magonza al più tardi nell’86 per il Danubio ed è a Brigetio ben prima del 97; non è accertata una presenza della legione a Carnuntum, forse è solo passata o ha spedito i suoi prodotti. Lo spostamento di legione sarebbe avvenuto dalla Belgica alla Pannonia Superiore prima della creazione delle province germaniche[425]. A Brigetio (oggi Komárom tra gli Azali della Pannonia) la legione fu comunque a lungo stanziata, come dimostrano l’instrumentum (Museo di Vienna) e numerosi epitafi del II e III secolo: un eques legionis I Adiutricis Piae Fidelis, un Iulius Nigellio (domo) Sep(timia) Flavia Sisc(ia) b(ene)f(iciarius) trib(uni) mil(itum) leg(ionis) I Ad(iutricis) Ant(oninianae)[426]; un tes(serarius) leg(ionis) I Ad(iutricis) P(iae) [F(idelis)] del sarcofago di età severiana posto dal fratello cu(stos) ar(morum) della stessa legione e un b(ene(ficiarus) leg(ati) leg(ionis) I Adi(utricis) alla metà del III secolo ancora a Komárov-Szőny (Brigetio)[427].
Le truppe ausiliarie della Pannonia sono state studiate da B. Lőrincz[428], a cui rimandiamo per brevità. Da Solva in Pannonia Superiore (Esztergom) conosciamo diverse attestazioni della cohors I Ulpia Pannoniorum equitata tra Traiano e il III secolo, accasermata sul monte Várhegy: ci rimangono i nomi di almeno nove tribuni ricordati non nei principia ma nel tempio di Giove per le dediche ex voto su altari recentemente studiate da P. Kovács e B. Lörincz, con significativi dati in relazione alle città di origine: tra essi P. Ael(ius) Aelia dom(o) Roma P.f. Mamianus trib(unus) coh(ortis) [I] Pan(noniorum) eq(uitatae) attorno al 210 d.C.; si noti la pseudo tribù Aelia[429]; inoltre un M. Fl(avius) M.f. Flavia Impetratus trib(unus) domo Saldas ex Mauret(ania) Caes(ariensi), di origine africana, dall’attuale Béjaïa; si noti la pseudo tribù Flavia[430]. Altri casi sono noti sotto Caracalla[431] o Gordiano[432], oppure Aureliano o Probo, come nel caso della dedica effettuata da M. A[fra]nius Hannibalian(us) t(ribunus) coh(ortis) I Ulp(iae) Pan(nonio rum) Vict(ricis) ter[433].
Un quadro sulle 12 iscrizioni provenienti dall’accampamento dei cavalieri ausiliari di Carnuntum e sui monumenti funerari del lapidarium di Petronell si deve a M. Kandler[434]. Le fonti archelogiche ed epigrafiche relative ai veterani e ai soldati di stanza nel I secolo d.C. lungo la Via dell’Ambra tra Poetovio e Canuntium in Pannonia Superiore sono ora studiate da Z. Mráv[435]. Alcuni campi militari di alae sono stati scavati recentemente: ad Odiavum o Azaum in Pannonia Superiore (oggi Almásfüzitő) un’iscrizione dedicata ad Antonino Pio fu collocata per la costruzione del campo in pietra tra il 150 e il 156 d.C. per iniziativa del legato C. Cl(audius) Maxi[mus], ad opera dell’[ala III] Aug(usta) Thr(acum) [sag(ittariorum)][436]. All’epoca di Diocleziano e Massimiano conosciamo nella stessa località un Vitalis tr[i]bun(us) p(rae)p(ositus) lanci[a(riorum)][437].
In Mesia a Viminacium è ben studiata la legio VII Claudia[438], di cui conosciamo i cana[barii] in età severiana[439], la legio XI Claudia Pia Fidelis, la legio V Macedonica.. Ci resta da dire della legio I Iovia Scytica accantonata nel forte del municipium Aurelium Antoninum Aug(ustum) Troesmism(ensium) sotto Licinio, poi sostituita sotto Costantino dalla legio II Herculiana a Noviodunum. Secondo Ştefan solo dopo Costantino sono spostate nei nuovi campi citati nella Notitia Dignitatum[440].
Dal campo legionario della legio VII Claudia di Viminacium proviene un nuovo frammento di CIL III 14597 con un elenco di nomi di legionari congedati nel 195 su due colonne. Alcune provenienze di soldati sono curiose: Cybira forse Remesiana o Ratiaria; Margum: nella colonna di destra le coorti VII e VIII; nella colonna di sinistra le coorti IX e X. Su 280 legionari congedati, conosciamo 244 nomi: 8 stratores, 5 cornicularii, 3 optiones, 2 imaginiferi, 3 equites, 13 decorati donis donati. Il numero dei soldati congedati appare elevato rispetto all’insieme dei legionari. La gran parte dei soldati arruolati nel 169 erano originari di Mesia Superiore[441].
A Scupi in Macedonia (Skoplje) L. Jovanova presenta un dec(urio) coh(ortis) II Aur(eliae) Dard(anorum) interfectus a Costobocos, attorno al 170 d.C.: un testo che testimonia un attacco dei Costoboci nello spazio danubiano e balcanico, prima che Scupi costruisse le sue fortificazioni volute da Marco Aurelio[442].
Segnalerei proprio a Kostolac-Viminacium in Serbia il diploma di Commodo con la XVIII potestà tribunizia, la ottava acclamazione e il settimo consolato, relativo a 5 alae e 10 coorti in Pannonia Inferiore sotto il governatore C. Pomponio Basso (Terenziano), in precedenza governatore di Licia e Pamfilia, datato da B. Pferdehirt all’11 agosto 193[443]. La data è ovviamente da rettificare così come per gli altri due diplomi studiati da Eck che fissa ovviamente il terminus del 31 dicembre 192 anche per il congedo dell’ex pedite cohortis I Montanorum equitatae originario di Bassiana (municipio poi colonia tra Sirmio e Taurunum). I consoli L. Iulius Messalla Rutilianus e C. Aemilius Severus Cantabrinus non sono datati; per Eck è possibile che il diploma sia stato emesso in ritardo.
F. Matei-Popescu ha studiato le truppe ausiliarie della Mesia, con attenzione alle provenienze nel corso dell’età imperiale degli ausiliari delle coorti e delle alae, al ruolo della flotta del Danubio[444]. Lo stesso autore si è occupato specificamente dell’esercito della Mesia Inferiore, le legioni V Macedonica a Troesmis (a Oescus dopo l’abbandono della Dacia e la nascita della Dacia ripensis, fine III-IV secolo), I Italica, XI Claudia a Oescus e Durostorum, 10 alae, 32 coorti, 4 numeri e la classis Flavia Moesica[445]: conosciamo avvenimenti militari, vexillationes, legati, tribuni, tribuni ausiliari, centurioni, signiferi veterani[446], discens mensor, cornicularii praefecti, immunes[447], imag(iniferi)[448], milites[449], salariari[450].
Tra i campi legionari, si segnala la presenza ad Oescus già sotto Augusto della legio XX Valeria Victrix prima di essere trasferita nel 4 d.C. in Illirico e Pannonia, sostituita dalla legio V Macedonica nel 44[451]; il villaggio abitato dalle famiglie dei legionari poi fu promosso Colonia Ulpia Oescensium, costruito da Augusto, ricostruito nel 71, occupato fino al 106 con canabae e vicus. La costruzione dell’accampamento di Porolissum non è più attribuita ad Antonino Pio ma ad Adriano[452].
Possediamo ora una storia delle ricerche archeologiche e epigrafiche nell’accampamento legionario di Novae (oggi Svištov) a partire dal 1700 fino ai giorni nostri, con numerosi articoli di T. Derda, P. Dyczek, J. Kolendo: il campo fu distrutto sotto Teodosio nel 392 (legio I Italica di Novae)[453]. Sono state recentemente pubblicate le are del valetudinarium, l’ospedale militare costruito in occasione della I campagna militare di Traiano contro i Daci con la legio I Italica, abbandonato verso il 230; il sacellum ha funzionato fino ad Aureliano[454]; sono attestate anche la legio I Minervia p.f. e la legio XI Claudia p.f. Possediamo una lista di ufficiali e sottuficiali della legio I Italica distaccata dal 68 all’età di Gallieno a Novae. Ancora a Novae nei principia del campo vengono ricordate le statue imperiali dedicate a Godiano III il 13 agosto 241[455] e quelle in vulto Dionisi tra il 428 e il 431, opera dei primipilares civili ex provincia Elisponto oppure ex pro[v(incia)] Insulanea: si tratta di statue di Teodosio II, della sua sposa Eudocia e di sua sorella Pulcheria erette secondo T. Sarnowski di fronte ad un personaggio di nome Dionysus, forse Flavius Dionysus, console del 429, poi comes et magister utriusque militiae per Orientem[456]; Z. Gočeva pensa ora più correttamente al dio Dioniso, sulla base di una nuova dedica greca, più esplicita, della prima metà del IV secolo[457].
Per la Dacia, dobbiamo rinviare all’opera di C.C. Petolescu, Auxilia Daciae. Contribuţie la istoria militară a Daciei romane, Bucarest 2002, che calcola 15 alae, 46 cohortes, 16 numeri. Per Potaissa in particolare vd. ora il catalogo sulle iscrizioni del campo legionario curata da M. Bărbulescu, con un centinaio di iscrizioni relative all’accampamnento della legio V Macedonica a Turda.[458] A. Oniţiu ha recentemente fornito l’elenco dei militari caduti in Dacia sul campo di battaglia, di cui ci rimangono gli epitafi[459]. Tra le coorti della Dacia va espunta la cohors III Dacorum e sostituita con la cohors III Campestris, di stanza a Pomet presso Porolissum a partire dall’età dei Severi[460]. Tra le alae, ad Arcobadara in Dacia è stata ripresa la dedica a Filippo l’Arabo da parte dell’ala Fr[onto]nian[a Phi]lippia[na][461].
L’esercito danubiano partecipò a numerose expeditiones anche in terre lontane. Sotto Vespasiano, un personnagio che ha partecipato alla guerra civile in Italia L. Cassius Cla(udia) Maximus (centurio) legionis VI ferratae, pone al rientro le dediche postume dal castello inferiore di Celje con un nuovo frammento inedito studiato da M. Lovenjak: una base associa a Diana la diva Iulia la figlia di Tito[462]; una seconda è posta a Domitia Augusta, la sposa di Domiziano[463]. Agli stessi anni risalgono a Seggau le decorazioni militari per la conquista di Gerusalemme assegnate a T. Cassius Secundus[464]. Un diploma rinvenuto nella Dobroudja meridionale ricorda nel 156 d.C. i distaccamenti trasferiti dalla Mesia Inferiore (governata da T. Pomponius Vitrasius Pollio) in exp[editione Mauretaniae Tin]gitan(ae) nell’età di Antonino Pio[465]. Un personaggio di altissimo livello originario di Celeia onorato più volte è T. Varius Clemens, che ha guidato la spedizione in Mauretania Cesariense[466], ricordato a Celeia da amici della provincia africana, in relazione alla procuratela del 151, arrivato al livello di ab epistulis e infine entrato in senato; già nella Tabula Banasitana compare come membro del consilium principis nel 154 d.C.[467]. La sua carriera è riportata in vari diplomi degli stessi anni[468].
Ora ben conosciuto è il caso del [M.] Mulviu[s—] domo Iudaeus [ne]gotians, grossista o banchiere, con 5 altri familiari o liberti che secondo F. Beutler e A. Konecny hanno seguito dopo la I guerra ebraica la legio XV Apollinaris a Carnuntum[469]: si tratta di un’espressione che non indica un’identità religiosa o etnica, ma semplicemente un’origo, una provenienza geografica, dalla Giudea a Canuntum[470].
Negli studi in onore di Mihai Bărbulescu si ricostruiscono le campagne di Traiano in Dacia, che avrebbero coinvolto 30.000 effettivi per G. Cupcea e F. Marcu[471]. È stata studiata la partecipazione di truppe ausiliarie dalla Mesia alle guerre daciche. Conosciamo il reclutamento di Daci nell’esercito di Traiano[472] e la partecipazione di truppe della Dacia alla spedizione di Traiano contro i Parti: legio I Adiutrix, vexillatio della legio XIIII Gemina, tre alae, una coorte[473].
Un diploma del I marzo 152 rinvenuto a Wels, Ovilava nel Norico, ci informa su tre alae dell’esercito del Norico che hanno partecipato con singole vexillationes alle operazioni di Antonino Pio contro i Mauri[474].
Un praepositus vexillationis dell’esercito della Mesia sembra esser stato a capo del contingente che accompagnò Severo Alessandro dal Danubio contro i Persiani nel 233[475]; l’esercito della Dacia ha partecipato alle campagne di Gordiano III e di Valeriano in Oriente[476].
Da Preslav in Mesia C.C. Petolescu presenta un nuovo ampio commento dell’epigrafe che ricorda un tiro, arruolato nel 210 per il bellum Bosporanum, sano e salvo multis periculis in barbarico liberatus, forse con riferimento alle razzie di Goti sconfitti dagli eserciti romani assieme a Rescuporide III alla foce del Danubio[477].
L’aspetto più significativo è rappresentato dall’origo orientale di molti soldati. La testimonianza più antica (25 d.C.) da Hardomilje in Dalmazia è studiata da R. Dodig e riguarda un Valerius ve(teranus) leg(ionis) VII, domo Icon(io), oggi Konya in Turchia[478] o un veteranus domo Sinope dal Ponto[479]: nella legione VII tra le altre dieci iscrizioni di soldati fin qui note, ben 7 ricordano legionari dalle province orientali. Wilkes ha affrontato il tema delle origini e relazioni familiari dei veterani installati in Dalmazia in epoca giulio-claudia[480].
Se passiamo alle altre coorti ausiliarie, a Salona I. Matijević pubblica l’epitafio di C. Iulius Mara veter(anus) coh(ortis) II Cyrrestar(um), domo Berea, originario di Berea in Siria alla metà del I secolo[481], come il commilitone di Burnum[482]. La coorte reclutata da Augusto fu inviata durante la rivolta in Illirico.
Da Sotin (Cornacum) proviene il diploma del 6 dicembre 157 concesso all’ex [ped]ite Valerius Mar[c]i f. Fronto, Anaz(arbus), originario dalla Cilicia[483].
J. Beszédes presenta il reclutamento della legio X Gemina di stanza a Carnuntum alla metà del I secolo d.C., a proposito del dilectus citato da Tacito (Ann., 16, 13) in Gallia Narbonese; altri soldati sembrano arruolati nel 65 in Illiria, Africa e Asia[484].
In Mesia, a Storgosia (Pelovo), Severo raddoppia il numero degli equites singulares alloggiati nei castra priora e castra nova. Il beneficiario del diploma del 13 marzo 205 rinvenuto a Pelovo è l’eques singularis C. Valerius Dolentis fil. Valens originario di Serdica in Tracia[485]. Due anni dopo, il 20 ottobre 207, viene congedato un altro eques singularis M. Valerius M. fil. Apolli[naris] Antiochia ex Syria[486]. Ancora da località incerta della Mesia Inferiore (tra i fiumi Iskar e Ogosta) provengno due altri diplomi relativi ad ausiliari[487]; al 14 giugno 92 risale il diploma di Cataloi (dipartimento di Tulcea) dell’età di Domiziano, relativo ad un eques della cohors VII Gallorum, Macrionus Acresionis f. Apamen(us), con i figli Macer, Saturninus e Augusta[488].
A Novae oggi Svišhtov J. Kolendo ha pubblicato l’epitafio di un soldato di origine ispana da Clunia, ora studiato da S. Perea Yébenez, che legge: legio I (prima) I(talica) F. R., con una titolatura inconsueta nel corso della guerra civile successiva alla morte di Nerone[489] . Si tratta della stele del soldato originario di Clunia che ha servito in una coorte ausiliaria prima di essere attribuito alla legio I Italica. Segue l’elenco degli ausiliari di Clunia e sul trasferimento dagli auxilia in legione nella guerra civile 68-69.
14. Miniere e dogane.
In Dalmazia a partire dall’età augustea le miniere di oro e di ferro e le saline, controllate da procuratori imperiali, risultano in piena attività. La riscossione dell’imposta fondiaria (il tributum soli) era affidata al locale procurator fisci. L’imposta doganale era riscossa nell’ambito delle stazioni adriatiche del publicum portorii Illyrici, che comprendeva un distretto molto ampio, fino al Norico, alla Pannonia, alla Mesia ed alla Tracia. L’unitarietà del territorio balcanico emerge dai lavori di Claudio Zaccaria indirizzati a ricostruire il sistema doganale romano, il complesso sviluppo dei portoria (da Aquileia all’Illyricum) fondati su stationes, sui portitores, sui porti[490]. Cinque iscrizioni studiate da M. Hainzmann ci fanno conoscere lo schiavo Fortunatus, poi liberto, incaricato della riscossione dei diritti doganali alle frontiere del Norico come contrascriptor e vilicus per 15 anni sotto M. Aurelio: il personaggio appare alle dipendenze del conductor publici portorii, del conductor ferrariarum, del praefectus vehiculorum et conductor publici portorii, e di altri funzionari imperiali, a meno che non si tratti di persone diverse[491].
Da un punto di vista fiscale il Norico rientrava nel publicum portorii Illyrici, una circoscrizione doganale che terminava al confine con la Rezia, dove si iniziava a riscuotere la quadragesima Galliarum. Proprio Zaccaria ha di recente commentato la dedica a Mitra da Camporosso in Valcanale (Saifnitz im Kanaltal) effettuata ex voto da un Telesphorus C. Antoni Rufi servus, publici portorii vilicus; proprio a Camporosso si ipotizza una stazione del publicum portorii Illyrici, la Statio Bilachiniensis. Il patrono di Telesphorus, C. Antonius Rufus, conductor della circoscrizione doganale, poi procurator publici portorii Illyrici verso il 174 d.C., praefectus vehiculorum, è ben conosciuto[492]. La Statio Enensis (a Mühlthal am Inn) del publicum portorii Illyrici in Norico sulla riva destra dell’Inn è nota anche per la dedica alla metà del II secolo di un Mitreo, con iscrizioni collocate da schiavi vic(arii) di un conductor e di un vil(icus) imperiale[493]. Ad Aquincum in Pannonia Inferiore è stato ritrovato cinquanta anni fa un sigillo in bronzo che attesta il pagamento della tassa sulla liberazione degli schiavi, con l’indicazione della circoscrizione territoriale: P(ublicum) XX lib(ertatis) (per) Raet(iam) Nor(icum) Dalm(atiam) Pan(n)oni(as) II, Concord(iam) Aq(uileiam) Histr(iam) Lib(urniam) anno III[494].
Emerge un mondo di scambi e di commerci animato da tanti protagonisti; è documentata una notevole presenza di negotiatores, impegnati in vivaci scambi commerciali verso Aquileia da un lato e con i territori transdanubiani dall’altro. Tutto ciò determinò una profonda romanizzazione delle città del Norico, dove sono attestati immigrati dalla pensola italica[495], mentre le campagne ed in particolare le vallate dell’interno mantennero tradizioni locali ed una cultura ancestrale, che sopravvisse per tutta l’età imperiale e che ebbe specifiche manifestazioni nella sfera religiosa. L’interesse del territorio, oltre che militare, fu soprattutto economico, legato allo sviluppo dell’attività mineraria (ferro, piombo, salgemma) affidata ad un procuratore apposito, che controllava le società di conductores. Conosciamo a Tiffen in Carinzia un immunis e un frumentarius impiegati nell’amministrazione delle miniere tra Caracalla e Massimino il Trace, 211-235[496] ed uno schiavo del conductor ferrariarum Noricarum[497].
Alcune novità possediamo sulle miniere in Pannonia: a Bölcske T. Karinius Iuliacen[sis domo] Arelate ex provin[cia] Narbonensi b(ene)f(iciarius) co(n)s(ularis) leg. II Ad(iutricis) p(iae) f(idelis) il 23 maggio 191 dichiara orgogliosamente il suo cursus honorum, a cavallo tra funzioni amministrative e funzioni militari nel campo di Acimincum, che sembra iniziare con la responsabilità sugli argentaria Pannonica et Delmatica: sta[ti]ones habui arg(entariarum) Pan(nonicarum) et Del(maticarum) [498].
S. Dušanić presenta un altare dedicato a Giove trovato presso il ponte sul fiume Dravus, ad Osijek, dove si menziona la statio del procuratore delle miniere unite e non di due stationes distinte: si tratta di una dedica I.O.M. [p]ro salute C. Iul(ii) Agathopi c(onductoris) f(errariarum) Pannoniar(um) itemq(ue) provinciar(um) transmarinar(um), posta dall’ark(arius) Gamicus, intendendosi per province trasmarine quelle del Ponto e della Bitinia[499].
Dopo la pubblicazione del volume di S. Dušanić sull’esercito e le miniere in Mesia Superiore[500], sappiamo dell’importazione nella stessa provincia a Viminacium di pesi in piombo dal Ponto e dalla Bitinia nel 236 nell’età di Massimino il Trace, sotto il governatore L. Ranius Optatus[501]. Le legioni di Singidunum e Viminacium erano incaricate di proteggere i distretti minerari. A Scupi (Skopje in Macedonia) conosciamo un coactor argentarius agli inizi III sec.[502]; in un epitafio è citato un Ennius Silo proc(uraror) vilicus argentariarum Dardanicarum[503].
Compresa nel publicum portorii Illyrici, la Pannonia (come la Mesia e la Dalmazia e più tardi anche la Dacia) poteva contare su una serie di stazioni doganali che immettevano in Italia partendo dal Danubio. Il distretto doganale si estese poi in Dacia: da Porolissum proviene l’altare dedicato I.O.M. pro salute di M. Aurelio e Commodo et Genio p(ublici) p(ortorii) vectigal(is) Illyr(ici) procurante Pompeio Longo proc(uratore) Aug(usti) per opera di un vilicus, tra il 175 e il 177[504]; analogo il caso dei vilici di Ampelum studiato da I. Piso[505].
Da Ad Mediam, L. Mihăilescu-Bîrliba ha studiato la dedica effettuata il 10 dicembre 157 ad Ercole Augusto, da un Felix, schiavo di un Iulius Saturninus c(onductor) p(ublici) p(ortorii) t(ertiae) p(artis) ex priv(atis) stationis Tsiernen(sis)[506].
In Dacia le miniere aurifere del bacino di Alburnus Maior (Roşia Montană) sono ora meglio conosciute grazie alle sette iscrizioni pubblicate da R. Ardevan e C. Crāciun che ricordano tra Traiano e Caracalla i Sardiates di Dalmazia, riuniti in un collegium Sardiatarum[507]. Dobbiamo a P. Damian il recente bilancio sulle ricerche nelle gallerie[508], che per Livio Zerbini sembrano rimaste in piena attività ben oltre le guerre contro i Marcomanni, almeno fino a Gordiano III[509]. Come è noto, C. Timoc aveva ipotizzato significative ripercussioni delle guerre marcomanniche, sulla base dell’ara di Ampelum dedicata alla [V]ictoria Commodi[510]. Sulla vita religiosa dei minatori è utile sempre ad Alburnus Maior la dedica Apollini Piruneno, epiclesi del fuoco delle miniere Apollo che protegge le aurariae nel II sec.[511]; ci sono noti diversi procuratori e praepositi delle aurariae, come quelli residenti ad Ampelum nell’età di Commodo[512].
Abbiamo vari documeti relativi all’importazione di metalli in Dacia: a Sarmizegetusa gli scavi del 1994 nel forum vetus hanno restituito lingotti studiati da I. Piso, con la scritta Imp(eratoris) Tr(aiani) me(talla) Ulp(iana) e C(oloniae) Ulp(iae) D(acicae) S(armizegetusae)[513]. Si tratta di un’importazione dai metalla Ulpiana della Mesia Superiore, di proprietà di Traiano. Proprio in Mesia Superiore, a Sočanica (Municipium Dardanorum), conoscimo i coloni arg[entariarum Dardanicarum] curante Thelesph[oro], un liberto imperiale che tra il 136 e il 137 fa ricordare l’eroe Antinoo[514].
L’amministrazione delle saline in Dacia è studiata da D. Benea, con attenzione per il ruolo dell’esercito e l’organizzazione degli appaltatori, i conductores pascui et salinarum[515]; informazioni ulteriori possediamo ora su Ursio servus actor verna, che ci è noto per la statua posta in onore del conductor salinarum, impegnato a Micia nelle miniere di sale in Dacia[516].
15. La vita religiosa.
Nelle province danubiane appare davvero pervasivo il culto di Giove (associato a Giunone Regina, Minerva e altri dei), i suoi riti (l’epulum Iovis) e con le dediche Iovi Optimo Maximo[517], con vari attributi: Aeterno, Cohortali[518], Conservatori[519], Paterno[520], Propulsori[521], Depulsori[522], forse Bussumarius[523]. A Crkvina in Serbia occidentale è stata effettuata la recente scoperta di un altare dedicato il 4 settembre di un anno del III secolo I.O.M. Ful(guratori) oppure Ful(minali) oppure Ful(minatori); la data coincide con l’inizio dei Ludi Romani[524]. Nella Mesia Superiore a Ratiaria (= Arčar, Vidin) ricorrono dediche I.O.M. Fulgurali[525]. In Dacia R. Ardevan riesamina l’altare perduto segnalato alla metà del XVI secolo presso Sarmizegetusa, con la dedica I(ovi) O(ptimo) M(aximo) [F]u[lg]ur[a]tor[i], offerto il 6 giugno 237 da due decuriones coloniae Aequi, uno dei quali è flam(en) aedil(is)[526]. Nel Lapidarium Savariense è conservato il puteale con l’espressione F(ulgur) d(ivum) c(onditum) del II secolo, ritrovato presso l’agger delle mura meridionale di Savaria, connesso con il culto di Giove[527]. L’attributo Culminalis a Petronell ha fatto pensare ad un dedicante originario del Sud del Norico[528]. Da Varvaria (oggi Bribirska Glavica) in Dalmazia, ci rimane la dedica di inizio I secolo d.C. Iovi Tan(aro), con epiclesi celtica[529]. Un importante studio di I. Piso è dedicato al santuario di Pfaffenberg presso Carnuntum e al culto di I(upiter) O(ptimus) M(aximus) Karnuntinus; significativa la data della prima inaugurazione del primo capitolium in Pannonia, un 11 giugno, giorno che coincide con la festività di Giove Teutanus del colle di Gellért ad Aquincum. Sono affrontati i temi dello statuto delle canabae intra leugam, cioè a breve distanza dal campo legionario, del collegio dei magistri montis, addetti al culto imperiale e di Giove Karnuntinus; dei cives delle canabae hanno un’associazione con al vertice quattro magistri montis[530]. Le dediche arrivano all’età di Giulia Domna, con l’incerta titolatura di [mater A]ug(ustorum) e di mat[er] cast[rorum], con il nome di Plautilla Augusta eraso[531]. Il tempio II di Pfaffenberg per M. Kandler in realtà sarebbe dedicato non alla triade capitolina ma a Iupiter Dolichenus[532] . Ancora a Carnuntum in Pannonia Superiore, Giove è venerato di frequente con l’attributo di Heliopol(itanus) Aug(ustus)[533]. Più precisamente a Bad Deutsch-Altenburg, nella parte orientale delle canabae, è stato individuato il temenos di Iupiter Optimus Maximus Heliopolitanus, con l’ex voto di un centurione della legione XIII G(emina) M(artia) V(ictrix)[534].
Un dio particolarmente venerato è poi Sivanus Domesticus[535], Silvanus Custos, Silvanus Antecessor (in quanto precede le Silvanae), Silvanus Silvester, talora associarto a Magula o alle Silvanae come a Carnuntum e a Siscia[536]; proprio a Carnuntum in Pannonia Superior, il piccolo santuario del Tiergarten secondo H. Stiglitz ha restituito nove altari, sei iscritti con ex voto a Giove, inoltre Silvano Domestico sacrum, Deo invicto, Dibus et Deabus, [Qua]drub(i)s et Silvani[s][537]. Ad Aquincum la dedica Silvano Sancto Pant(h)e[o][538] o anche Teo Silvano Domestico[539]. Per una visione di sintesi sul culto di Silvano nelle province danubiane, possediamo ora il recente volume di M.L. Dészpa[540]. I. Piso ha ripreso la dedica I(ovi) Optimo) M/aximo) et Silvano ceterisque dieis deab(u)sq(ue) Conservator(ibus) effettuata nella colonia Aurelia Napoca da un procuratore finanziario[541]. In parallelo si svolge il culto per le Matronae.
L’oppidum celtico di Lentia nel Norico (Linz) fu invece la sede del culto della dea Epona, che ritroviamo raramente in Dacia, ora studiato da T. Lobüscher[542]. Vd. anche in Pannonia Inferiore ad Aquincum la dedica Epon[ae] sacrum o Epone Reginae[543]. Altre divinità celtiche, come Taranis e Vocretanus sono documentate nel Norico (ma anche in Pannonia)[544]; forse allo stesso ambito appartiene l’Ollodeuos di Virunum in Norico[545]. Ma sui culti gallo-romani in Rezia e in Norico abbiamo ora l’ampio censimento di A. Forster[546].
Da Tragurium in Dalmazia (oggi Trogir) proviene la rara dedica Salaciae Aug(ustae), l’arcaica dea delle acque, studiata da D. Demicheli; uno studio frontale sulla dea, che andrebbe avvicinata al dio Salaecus di Cartagena[547] e testimonierebbe un impegno diretto degli imperatori del III secolo per una rivitalizzazione dei culti più arcaici in Illirico, si deve a G. Alföldy [548].
Un altare fu eretto ad Ercole, eponimo del Pagus Herculius a Budaörs in Pannonia Inferiore, da parte degli abitanti di alcuni vici, uno dei quali quello degli Anar[tii] della pianura ungherese[549]; analoga una dedica Terr(a)e Matri per la salvezza dei Filippi tra il 247 e il 248[550]. Proprio a Budaörs Z. Mráv ha studiato la nuova dedica Herculi Aug(usto) da parte di IIvir coloniae Aquincensium [551], che conoscevamo per un’altra dedica a Terra Mater[552]. In Pannonia Superiore a Scarbantia una dedica Herculi Aug(usto) fu effettuata da un M. Sat(ellius) Eros, con un raro gentilizio che compare anche in un altare ancora inedito[553]. In Dacia a Gherla, è il legato provinciale dell’età di Commodo Marc(us) Veracilius Verus a effettuare una dedica Herculi sancto, per iniziativa di Tannon(ius) Maximus pr(a)ef(ectus) eq(uitum)[554]; ad ambiente militare rimanda la dedica Herculi di Gilău, effettuata dall’eq(ues) Apro[555]. Sempre in Dacia, ad Alba Iulia, a breve distanza dalle mura della Colonia Aurelia Apulensis fu consacrata all’inizio del III secolo l’ara Terrae matr(i) da un liberto Augustalis che aveva ottenuto gli ornamenta dec(urionalia) col(oniae Apul(ensis)[556]; lo stesso personaggio compare con una seconda ara nel santuario di Asclepio[557].
Il contatto con il culto imperiale è ampiamente documentato ad es. dalle dediche dis deabusq(ue) Genioque loci, come quella per la salvezza di Gallieno in[v]ictus per iniziativa del legato della Pannonia Inferiore M. Aur(elius) Valentinianus[558]. Á. Szabó e B. Lőrincz presentano la dedica effettuata ad Aquincum da un legato imperiale ad un dio Augusto ceterisque dis huisque loci[559].
Ad Aquincum esisteva un un tempio di Ercole, restaurato a fundamentis nel corso del 216, come risulta dalla dedica He[rculi Aug(usto)], invocato per la salvezza e l’incolumità di Caracalla (con il cognome di Severus) e Giulia Domna. E come è noto Ercole è il genius loci di Leptis Magna assieme a Liber Pater[560].
Non è possibile citare per esteso le altre divinità: Liber Pater[561], Libera, Venus, Nettuno, Ade, Persefone, Proserpina, Plutone[562], Giano Gemino, Mercurio con i suoi cultores[563], Fortuna Respiciens, Marte Gradivus e Ultor: ad Aquincum Mars ultor è associato al Genius Augusti[564]; i m(agistri) m(artiales) sono frequenti in Dalmazia, a Vid-Narona, secondo M. Mayer, assieme ai VIviri Aug(ustales)[565]. Si veda anche la dedica Marti Victoriae Fortunae Red(uci) posta dal legato della Pannonia Inferiore per la salvezza dei Filippi durante la spedizione del 247 contro i Carpi[566]. Le dediche a Marte di difficile interpretazione sono state discusse da M. Hainzmann, come quella di Seggauberg nel Norico (Flavia Solva) con i dativi: Marti Latobio Marmogio Sinati Toutati Mog[et]io, in un ex voto. Non si tratteberebbe propiamente di sei distinti tenonimi, ma vengono associati alcuni dei e i loro rari epiteti, con possibili diverse varianti[567]. Il culto del Marte celtico in Dacia è studiato in un articolo di R. Ciobanu[568]. Vd. anche l’unica dedica conosciuta in Dacia Marti Toutatico effettuata ex voto nel municipium Aurelium Apulense (colonia di Commodo, oggi Alba Iulia) da C. Valerius Hermes[569]. Infine un Mars Campester di origine celtica associato ad Epona è venerato in Mesia Superiore[570].
Il ruolo dei santuari di Apollo e Diana a Montana in Mesia Inferiore appare nella singolare dedica effettuata nel 161 d.C. dal legato della legione I Italica, con un riferimento all’insula vagans, l’isola sacra di Delos[571]. A Potaissa (oggi Turda) significativo il compleso monumento dedicato forse a Deo For[ti Phoebo Apollini Parthico] per la salvezza dell’imperatore e di un sacerdos III Daciarum: S. Nemeti ha avvicinato il dio a quell’ Azizos, il cui tempio proprio a Potaissa fu inaugurato attorno al 257: ancora una volta si sottolinea il contatto con il culto imperiale organizzato in un concilium provinciae che appare perfettamente vitale nella seconda metà del III secolo[572]. In Mesia Inferiore a Krivina (Iatrus) segnalerei l’ara con dedica Apollini Auluzelo effettuata da T. Salvius Chresimus ex imperi(o) p(osuit), con la raffigurazione di un cavaliere trace; l’epigrafe è a destra e sinistra della gamba del cavallo. Non sappiamo come intendere l’epiteto Apollo Aulezelus, davvero un unicum, da confrontare con Aulusademus, Aulosades, Aularchenus[573].
La dedica quattuor ventis et Bono Ev[e]ntus è studita in Mesia inferior da P. Lungarova[574], che ha descritto il variegato culto dei Genii in Bulgaria, con riferimento al Genius provinciae, ai Genii delle unità militari, ai Genii loci[575]. A Szombathely è stata rinvenuta la rara dedica Diis itin[erariis] meglio itine[ris] utriusque viae, nel senso di andata (itus) e ritorno (reditus)[576].
Nella regione danubiana sono frequenti le dediche Domino, connesse con il culto di una dea lunare e di un dio o eroe solare illirico vicino al cavaliere danubiano[577]. Il cavaliere trace con la lira compare spesso in Dacia: non si tratta di un culto indigeno, ma introdotto da coloni arrivati dalla riva destra del Danubio. di Oppermann, con omissioni, ora ripreso in questa sede da Enio Biondi di Besançon[578]. A Szombathely una dedica Ituno e[t] Itunae, ex voto di un Quartus e di una Fl(avia) Iulia[579]. A Parndorf nel Burgenland in Pannonia Superiore, sulla c.d. via dell’ambra, abbiamo la dedica Nutri[ci(bus)] finora attestate solo a Poetovio[580].
In quello che è il primo documento di Belenus in Slovenia, conosciamo questo dio onorato a Celeia (Spodnji Grad) nel Norico da L. Sentius Forensis di Aquileia[581]. Un dio locale potrebbe essere il Mibricus evocato dall’ala I Scu(b)ulorum in Stiria, a Wildbald Einöd[582]. Unica è la dedica alla dea greca Ananca per un voto effettuato dal padre per la salute del figlio Val(erius) Licinianus a Doclea in Montenegro[583]. Ercole Augusto è menzionato a Sankt Michael am Zollfeld, Herculi Aug., in una dedica effettuata da Gemellus Biraconi(s f.)[584].
A Tiffen nel distretto di Feldkirchen in Carinzia, alla fine dell’età severiana possiediamo la prima attestazione delle dee Senae, divinità collettive analoghe a divinità femminili della Britannia: la dedica Sena[bos] Aug(ustis) è stata effettuata nella prima metà del III secolo da C. [—] Firmi[nus] imm(unis) li[br(arius) leg(ionis)] II Ital(icae) [p(iae) f(idelis) Sev(erianae)] et Cl(audius) Se[cundus fr]um(entarius), impiegati nell’amministrazione delle miniere del Norico[585].
Il tempio di Fortuna nella colonia di Oescus in Mesia Inferiore (oggi Gigen) è stato scavato da T. Ivanov[586]. Da Topusko in Croazia proviene la dedica di un altare alla Fortun(a) Aug(usta), effettuata da Domitia Pusilla, forse liberta di un militare originario della Mesia Inferiore, imparentato con il centurione della legio XIV Gemina noto per aver innalzato un tempio alla stessa dea a Aquae Iasae[587].
A Glamnik, in Kosovo presentano la dedica Deae Dard(anicae), posta da un b(ene)f(iciarius) co(n)s(ularis) leg(ionis) IIII Fl[aviae] nel corso del III secolo[588]. Per la salvezza dei Severi sono collocate le are Dis deabusque Campestribus[589].
Se passiamo alla vita religiosa, nel Norico[590], arricchita dal recente studio di R. Wedenig sui graffiti su oggetti di culto che menzionano dediche alle divinità[591], la dea madre che personificava la provincia è rappresentata da Noreia, studiata da P. Scherrer[592]; importanti risultati provengono dagli scavi nel santuario di Iside Noreia ad Hohenstein in Carinzia e dagli scavi effettuati da H. Dolenz in territorio di Virunum in Norico, presso l’anfiteatro di St. Michael am Zollfeld, Maria Saal, nel riempimento costantiniano, che hanno messo in luce il santuario di Nemesi entro l’anfiteatro costruito da Adriano, restaurato da Commodo, rifatto dopo un incendio da Settimio Severo[593]. Ci rimane il ricordo dei lavori di restauro e le dediche pro salute dei Severi da parte di C. Mar(ius) Luc[ani]us Max[imianus IIvir] i(ure) d(icundo) muros amp[hiteatri] tectorio oper[e renovavit] et picturis [exornavit], con una rara erasione del nome di Caracalla[594]. Egli ha fatto rifare l’opus tectorium, il rivestimento in stucco dei muri dell’anfiteatro con pitture murali tra il 198 e il 199, lavori ripetuti verso il 230[595]. Conosciamo pure il padre Priscus, anch’egli un IIvir e la madre Cominia Q.f. Celsinio[596]. Il 15 marzo 237 C. Cassius Honoratus per la salvezza di Massimino il Trace e di suo figlio dedicano le opere effettuate: murum longitudinis p(edum) XXXX ruina conlapsum a solo restituit et podium amphit(h)eatri opere tectorio cum pictura muneris sui exornavit et portam novam fecit[597]. Sempre dal Nemeseum di Virunum provengono gli altari di fine II secolo Nemesi Augustae sacrum collocati da parte di un [Mar]tialis [ve]nator, cacciatore nell’ambito delle venationes[598]. Al secolo successivo si riferiscono le dediche Nemesi Reginae Augustae e agli dei Campestres, divinità protettrici degli equites singulares e dei cavalieri della prima ala di Traci[599]. Gli altari del santuario di Nemesi furono salvati, nascosti in età costantiniana, protetti e coperti di terra[600]. Possediamo ora una lista di I. Weber-Hiden delle dediche a Diana Nemesis Augusta a Carnuntum[601].
Ancora a Virunum, H. Dolenz ha pubblicato le iscrizioni del santuario di Ercole Augusto, che ricordano offerte anche alla dea Rosmerta[602]. Sulla riva destra della Sava presso Podkraj nel Norico, rimangono i resti del santuario delle divinità fluviali Savus e Adsalluta, che M. Šašel Kos ha collegato al culto di Magna Mater[603].
Da Bedaium in Baviera M. Hainzmann presenta undici altari votivi del dio Bedaios, talora associato alle Alounae, dee madri, nel corso del II-III secolo d.C, culti apparentemente introdotti nel Norico dai Romani[604]. Il dio Aesus è documentato nell’iscrizione votiva di Dellach in Carinzia su una statuetta di bronzo offerta a Aesus da Adginnos Vercombogi filius [605].
A Ratiaria in Mesia Superiore, una dedica Deae Placidae fu effettuata nel II secolo da un Ael(ius) Heculanus lapida(rius)[606].
A Sarmizegetusa in Dacia esisteva un tempio dedicato Dis Maiorib(us) Domno et Domnae, distrutto nell’età di Marco Aurelio, durante l’attacco di Sarmati[607].
A parte i numerosi culti salutari di Diana (pure invocata come dea degli inferi)[608], Asclepio, Hygia, Ninfe[609], se in questa sede ci concentriamo sui culti orientali, abbiamo numerose dediche Deo invicto Mithrae, come quella da Akmačići, regione di Zlatar in Serbia occidentale Invicto S(oli) M(itrhae) O(mnipotenti)[610]. Il culto di Mitra in Pannonia è stato studiato frontalmente da I. Tóth[611], che si sofferma sulle sue origini e specificità, sull’iconografia e sacerdoti mystes di Intercisa. Lo stesso autore ha presentato il Mitreo di Fertőrákos nel territrorio di Scarbantia (oggi Sopron)[612]. Il culto di Mitra in Mesia Inferiore è affrontato da V. Bottez, con riferimento ai mithraea e ai gradi d’iniziazione[613].
Iside in Dalmazia è studiata da L. Bricault, in RICIS [614], associata talora a Serapide Magnus[615]. A Scarbantia ci rimane una rarissima dedica ad Osiride che si accompagna al culto di Iside all’inizio del II secolo: è recente la pubblicazione effettuata da G. Gabrieli di un’epigrafe incisa su una lastra di calcare scoperta a Sopron nel corso degli scavi del 1996, [Os]iri Aug(usto) effettuata dall’[Isi]dis sacerd(os) [P. ?] Domatius Ingenu(u)s[616]: si tratta di un commerciante originario della Dalmazia con interessi a Cipro, che praticava il rarissimo culto di Osiride tra il I e il II secolo, con rapporti col mondo egiziano[617]. Possediamo un unico altro confronto nell’impero, a Colonia, in un testo dedicato Deo Osiri pubblicato nel 1987[618]. Rarissimo nelle province danubiane e nell’impero[619] è anche il culto della dea egizia Bubastis, come ancora a Sopron (Scarbantia)[620], testimoniato dalle epigrafi del santuario di Iside[621]. A Smiljanovac in Dalmazia un bambino di nove anni, Aur(elius) Satrius (sepolto assieme alla sorella di sei anni Aur(elia) Maxima), è rappresentato sull’acroterio di un coperchio di un sarcofago mentre riceve l’iniziazione isiaca[622]. M. Bărbulescu ha studiato complessivamente i culti egizi a Potaissa in Dacia, oggi Turda, attraverso i monumenti e le iscrizioni[623]. Dubbio è il caso della dedica al dio egizio Toth (Deo Totovitioni) effettuata da un soldato della legio IIII Fl(avia) catara(tarum) stationis Dianae in Mesia superiore, forse con l’evocazione di un dio della Tracia[624].
Tra le divinità orientali si segnala a Salona nella collezione Matijević, in Varia Salonitana di Marsic e Matijević la dedica di un tempio Matri deum Magnae: aedem cognatio fecit ex nummis conlatis solo suo[625]. La vita religiosa in Mesia Inferiore si è arricchita con la scoperta a Balčik (Dionysopolis) nel 2007 della dedica Matri deum da parte dell’imperatore Licinio, nel tempio della Meter Theon Pontia: quod ex donariis in templo eius repertum est simulacrum argenteum numini eius in libris septem et uncis octo fieri iussit et consecrari, con l’intervento del preside della Scizia il perfettissimo Aurelius Speratianus, che si occupò materialmente della realizzazione della nuova statua argentea, che doveva sostituire quella perduta a seguito di un’incursione[626]. Nella stessa provincia soprende la vitalità dei culti geto-daci riflessi dall’onomastica studiata da D. Dana[627].
I culti orientali in Dacia sono studiati da J.R. Carbó García, che presenta un catalogo di ben 322 iscrizioni, riferite a 52 diverse divinità, con una prevalenza di dediche mitraiche[628]. I culti orientali in Dardania nell’impero sono illustrati nell’ articolo di Z. Mirdita[629].
Di grande interesse storico è la dedica rinvenuta a Székesfehérvár in Ungheria e proveniente da Gorsium piuttosto che dal castellum di Intercisa in Pannonia Inferiore (odierna Dunaújváros) al [Deo So]li Elagab[alo sac]r(um) per la salvezza di Severo, Caracalla, Geta Cesare, da parte dei [mil]ites cohort(is) I [(milliariae) Antonin(ae)] Hemesenorum[630], che anticipa al 198-199 sotto il governo in Pannonia Inferiore del legato Tiberius Claudius Claudianus l’arrivo da Emesa del culto del Dio Sole Elagabalo, ben prima delle numerose attestazioni del culto ad Intercisa successive alla visita della famiglia imperiale nelle province pannoniche nel 202 (HA, Sept. XV-XVII): solo in quella data il tribuno Q. Mod(ius) Q. f(ilius) Quirina Ru<f>inus edificò proprio ad Intercisa il tempio Deo [So]li Aelagabalo[631]; più tardi possediamo la dedica del 23 agosto 214, dopo la vittoria germanica di Caracalla effettuata deo patrio Soli Elagabalo[632]. Solo sotto il principato di Antonino Eliogabalo i soldati della legio I Adiutrix pongono a Brigetio in Pannonia Inferiore la dedica Deo Soli Alagabalo Ammudati, con un epiteto davvero singolare[633]. Ad Aquincum abbiamo varie dediche Soli Deo, Soli Soccio, Soli Socio sacrum per la salvezza di Elagabalo[634]. A Sarmigezetusa è significativa la dedica [Deo So]li inv[icto Belo —]? Mal[a]gbel(i) Hie[robolo deis Palmyrenis? ] per la salvezza di Severo Alessandro e Mamea tra il 222 ed il 235[635]; allo stesso periodo potrebbe risalire l’elenco dei cult[ores dei Solis ? Ma]lagb[eli][636]. I. Piso ha studiato il Forum vetus di Sarmizegetusa, con l’epigrafe che ricorda il tempio dei [Solis Ierh]abolis posta da un tribuno, per ricordare il dio di Palmira.[637]. Occorre sottolineare la prossimità del tempio al foro nuovo, dove si sono svolti gli scavi del primo Campidoglio della provincia Dacia costruito alla metà del II secolo[638]. Il contatto tra la Dacia e Palmira passa ovviamente attraverso le truppe, come testimoniano anche alcune iscrizioni bilingue (palmireno-latino) di Tibiscum[639].
A Svištov (Novae) N. Markov ha richiamato l’attenzione su una dedica I.O.M. Dolicheno ubi ferrum nascitur, una formula abituale per indicare il dio commageno, invocato nell’età di Adriano dal siriano P. Aelius Benivolus dec(urio) alae Commagenorum[640]. La prima menzione dell’ala nel campo di Tulln sul Danubio in Norico risale al 104 e all’età di Traiano, anche se sulla pietra il reparto riceve sotto Caracalla l’epiteto di Antoniniana (Comagenis)[641]. A Karataš (Cataractarum Diana) ci rimane la dedica I(ovi) O(ptimo) M(aximo) Dolicheno per la salvezza di Caracalla e Giulia Domna posta da L. Marius Perpetuus (Aurelianus) c(onsularis), governatore della Mesia Superiore sotto Caracalla tra il 212 e il 213[642]. Nella stessa provincia a Viminacium, V.P. Petrović ha studiato la dedica I.O.M. D(olicheno) effettuata nella prima metà del III secolo da Aur(elius) Iulianus Iuliani (filius) sac(erdos) eiusdem dei ex pr(ovincia) Syr(ia) Coel(e) reg(ione) Cyrr(h)ens(i) vico Capersina[643]. Secondo M. Popescu, il culto di Giove Dolicheno (documentato in Dacia presso le miniere nell’età di Settimio Severo)[644], sarebbe rinato sotto Gordiano, come testimoniano le iscrizioni di Ampelum, Samum, Certiae, Porolissum[645]. C.C. Petolescu ha studiato in particolare il rapporto tra i sacerdoti di Iupiter Dolichenus e l’esercito di Dacia a Drobeta, Apulum, Ampelum, Porolissum[646]. Proprio a Porolissum I. Piso ha riesaminato le iscrizioni del tempio di Giove Dolicheno: I(ovi) O(ptimo) M(aximo) [D(olicheno)] pro salute et [incolu]mitate di Gordiano III et coh(ortis) III Camp(estris) da parte di un IIIIvir m(unicipii) S(eptimii) P(orolissensis), di un veterano e di un decurione del municipio vegesi[m]a[r(ius)], percettore dell’imposta del 5%, la vigesima hereditatium: [t]emp[l(um) cum] tabernis (a)ere suo feceru[nt][647].
In Mesia Inferiore, a Novačene (Pleven) è documentato il culto del Draco, più precisamente a Glycon di Abonuteichos, nel corso del III secolo[648].
Ancora a Salona in Croazia dalla chiesa S. Nicola proviene un testo apparentemente neutro, che ripropone la regola aurea comune a tutte le tradizioni religiose, il rispetto per la sepoltura e la garanzia di securitas per il defunto: chi voglia violare questa tomba abbia la vendetta degli dei, [sepultu]ram si qui[s de]asciare voluerit, habe[at ir]ata numina: chiunque venerino, romani, giudei o cristiani, rispettino i Mani, in un periodo che va collocato nella prima metà del IV secolo[649].
A Salona un sarcofago del diacono, Flavius Iulius zaconus e di sua moglie Aurelia Ianuaria, datato con anno consolare al 2 novembre 358, ricorda la Aeclesia Salon(itana), beneficiaria dei possibili proventi derivanti dai violatori della tomba: si quis post nostram pausationem hoc sarcofagum aprire voluerit inferit aeclesiae Salon(itanae) argenti libras quinquaginta[650].
Per il cristianesimo, a Veliki Krčimir in Mesia Superiore ci rimangono brani di citazioni bibliche ed evangeliche in una lunga versione latina, un salmo da Girolamo, dalla Lettera ai Filippesi, dal Vangelo Matteo; il documento è stato collegato da V. Nedeljković alla costruzione della vicina basilica[651].
16. Le articolazioni e le festività del culto imperiale.
Come si è osservato in tutte le province romane il culto imperiale sembra procedere in simbiosi con i culti locali: così ad esempio in Rezia, se a Lauingen (Baviera) il legato imperiale [- Statil(ius) Dio]nysius dedica il [sigillum d]ei Apollinis Granni in onore di Elagabalo, sicuramente in connessione con le precedenti politiche del divus Magnus Antoninus[652].
Il culto di Roma e di Augusto in Dalmazia, nei tre conventus di Scardona, Salona e Narona, già a partire dall’età di Tiberio è studiato da I. Jadrić-Kučan: il culto del Divus Iulius ha incluso il culto della Dea Roma e poi si è travasato nel culto imperiale, con testimonianze monumentali molto risalenti a Pola, Oneum, Aequum, municipium Bistuensium, Doclea[653].
Gli ultimi tempi hanno visto un approfondito studio del culto imperiale in Dalmazia nel suo sviluppo fino alla piena età severiana, come dimostrato nel recentissimo volume su L’Augusteum di Narona, con gli Atti del Convegno promosso da Cinzia Bearzot e da Andrea Giardina presso l’Istituto Italiano per la Storia Antica a Roma il 31 maggio 2013[654]. Il culto imperiale a Salona è stato studiato da J. Jeličić-Radonić[655]. È da rettificare l’edizione della dedica cosmocratica di Klis, in territorio di Salona a Giuliano [vic]tori ac [trium]fatori t[otius]q(ue) orbis [Augusto], datata da D. Demicheli agli anni 361-3[656]. Molti Seviri augustales compaiono nel catalogo di 40 iscrizioni di Narona oggi Vid pubblicato da I. Rodá.[657]
Ad Epidaurum in Croazia (oggi Cavtat) P. Aelius Osillianus ottiene la cittadinanza da Adriano ed è onorato con statua con un decreto dell’ordo dei decurioni, pagata dalla madre e dalla nonna, che nell’occasione offrono sportulae ai decurioni, Augustales e seviri con uno spettacolo di pugilato, pugilum spectaculo[658].
La vita religiosa in Pannonia è studiata nel volume di Á. Szabó, che elenca la documentazione relativa ai sacerdotes, artistes, augures, flamines, pontifices, con attenzione per il culto imperiale e le assemblee provinciali[659]; a Szombathely ad esempio una rilettura del basamento della statua di Traiano, ha consentito di dimostrare che la dedica fu effettuata nell’ambito del culto imperiale dai [pont(ifices) a]ugur(es) sacer[dot(es) f]l(amines ?) ex colonia [S]avaria[660]. Conosciamo auguri cittadini come a Mursa in Croazia[661]. Il culto della Dea Roma secondo Á. Szabó sarebbe stato introdotto in Pannonia Inferiore molto tardi, nell’età di Caracalla, ad opera del XV vir sacris faciundis L. Cassius Marcellinus[662]. H. Zabehlicky ha studiato i santuari privati nelle Pannonie specie a Carnuntum[663].
Z. Mráv studia l’uso in onore degli imperatori, i patroni e le divinità che innalzano statue di cui ci rimangono le basi inscritte[664]; frequente l’associazione del culto imperiale e del culto di Iupiter, come nella dedica di Budakalász in Pannonia Inferiore, studiata da Á. Szabó, d riferire a Caracalla e Geta nel 211-212 d.C.[665]
Il culto imperiale nella Pannonia Inferiore è legato alla sede dell’Ara Augusti ad Aquincum-Budapest e non a Gorsium: conosciamo sacerdotes, sacerdotales, attività. D. Fishwick presenta un nuovo commento per la dedica dell’età di Caracalla che ricorda un dec(urio) col(oniae) Aquin(ci) it(em) dec(urio) m(unicip)i [Sin]g(idun)i IIvir flam(en) sacerdos arae Aug(ust)i n(ostri) p(rovinciae) P(annoniae) Infer(ioris) nymp(haeum) pec(unia) sua fecit et aquam induxit[666].
A Savaria conosciamo molte feste e appuntamenti del culto imperiale, durante i quali avveniva un’ampia distribuzione di crustula[667]. Proprio a Szombathely è attestato forse durante il regno congiunto di Caracalla e Geta un dec(urio) [c(oloniae) C(laudiae) Sav(ariae) (?), contemporaneamente dec(urio? c(oloniae) S(eptimiae) Karn(unti) [IIvir equo p]ublic(o) [sacerdos ar]ae Aug(ustorum duorum), onorato a quanto pare con una statua equestre dal [conc(ilium) provinc]iae P(annoniae) s(uperioris): ne risulta che il sacerdozio provinciale era tenuto da cavalieri, con il titolo di sacerdos provinciae e poi di sacerdos arae Augusti dopo Settimio Severo[668].
La dedica di Aquincum Concordiae Augg. Feliciter, normalmente riferita a Marco Aurelio e Lucio Vero (161-169), va più probabilmente attribuita a Caracalla e Geta tra il 211 e il 2012[669].
Il culto imperiale nelle Mesie è stato studiato da D. Aparaschivei, con attenzione ai flamini municipali[670], come a Viminacium, Oescus, Troesmis (municipio di Marco Aurelio e Commodo); anche assieme a sacerdotes provinciae e flaminicae[671]. Vd. anche V. Bottez, che ha studiato il culto imperiale in Mesia Inferiore durante i primi tre secoli[672].
Il culto imperiale è documentato a Ratiaria dall’epitafio di C. Iulius Tib. [f.] Saturnin[us], IIviral(is) col(loniae) Ra[ti(ariae)], flamini prim[o] municip(i) Aelian(i) sotto Adriano, quindi flamine anche nel municipio di Viminacium[673].
Gli Augustales della Pannonia e della Dacia sono studiati da L. Mihăilescu-Bîrliba, con riferimento specifico allo stato giuridico, prevalentemente libertino[674]. In particolare in Dacia conosciamo 119 Augustales, tutti immigrati; solo una decina di bambini potrebbero essere nati in Dacia[675].
17. Conclusioni.
Consentitemi in chiusura di esprimere l’ammirazione per le tante imprese internazionali in corso, per gli scavi e le indagini dalle quali ci aspettiamo veramente nuova luce su un mondo che amiamo davvero, fin dai tempi lontani del IX congresso AIEGL di Sofia nel 1987, in una Bulgaria tanto diversa da quella di oggi.
Concludendo vorrei per un attimo tornare indietro a due secoli fa e richiamare la colorita vicenda delle 17 iscrizioni della Dacia perdute nel 1723, sommerse nel Tibisco in piena a Seghedino, l’attuale Szeged in Ungheria al confine con la Serbia, nell’età di Carlo VI: una vicenda che qualche anno fa è stata ricostruita per noi da Gian Paolo Marchi e da Alfredo Buonopane, partendo dagli scavi di Weissenburg in Transilvania e dall’attività del capitano Giuseppe Ariosti, utilizzando il Codice dedicato Carolo VI, restitutori Daciarum e restauratori Pannoniae. Attraverso Ludovico Antonio Muratori e Scipione Maffei sappiamo in dettaglio della “disgrazia della barca affondata” e del salvataggio delle altre 46 lapidi, conservate oggi a Vienna nella Prunksaal dell’Österreichische Nationalbibliothek. La drammatica vicenda del naufragio nel fiume in piena ci racconta moltissimo della fragilità dei monumenti antichi, del rischio continuo di perdite irreparabili, della responsabilità di tutti noi, dell’impegno che dobbiamo garantire per la salvaguardia del patrimonio[676].
[1] A. Mastino, Conclusioni, in Roma e le province del Danubio, Atti del I Convegno Internazionale, Ferrara-Cento, 15-17 ottobre 2009, L. Zerbini ed., Catanzaro 2010, pp. 489-495 (vd. anche pp. 11-18 e AE 2010, 1106).
[2] Culti e religiosità nelle province danubiane. Atti del II Convegno internazionale (Ferrara, 20-22 novembre 2013), L. Zerbini ed., Bologna 2015. Sul tema, vd. Religion in public and private sphere: Acta of the 4th International Colloquium “The Autonomous Towns of Noricum and Pannonia”, I, Lazar ed., Koper 2011.
[3] Die Römischen Provinzen. Begriff und Gründung (Colloquium Cluj-Napoca, 2. September-1.Oktober 2006), I. Piso ed., Cluj-Napoca 2008.
[4] Una prima sintesi in R. Ardevan, L. Zerbini, La Dacia romana, Rubbettino, Catanzaro 2007; vd. poi C.C. Petolescu, Dacia. Un mileniu de istorie, Bucarest 2010. Ma dovremmo citare molti altri; per tutti desidero ricordare il volume donatomi in un’occasione ufficiale da M. Munteanu, Provincia Dacia: istorie politică şi numismatică, Editura Mediamira, Cluj-Napoca 2010. Particolarmente significaivi gli scavi condotti da alcune Università italiane: lasciatemi citare l’accordo di collaborazione tra l’Istituto di ricerche Eco-Museali di Tulcea e l’Università di Sassari per la città romana di Ibida o Libida in Scizia Minore.
[5] Vd. I. Piso, in La naissance de la ville dans l’Antiquité, M. Reddé, L. Dubois, D. Briquel, H. Lavagne, F. Queyrel edd. (De l’archéologie à l’histoire), Paris 2003, pp. 285-298. Per l’area del basso Danubio: AE 2010, 1107 (D. Aparaschivei).
[6] Vd. R. Cîrjan, Statute citadine privilegiate în provinciile dunărene ale Imperiului Roman (sec. I-III) (Bibliotheca Ephemeris Napocensis, 7), Cluj-Napoca 2010.
[7] Un quadro generale del rapporto tra esercito e urbanizzazione nell’insieme delle province danubiane è stato presentato in occasione del colloquio svoltosi ad Alba Iulia tra l’8 e il 10 ottobre 1999: Army and Urban Development in the Danubian Provinces of the Roman Empire (Bibliotheca Musei Apulensis, 15), H. Ciugudean, V. Moga edd., Alba Iulia 2000.
[8] Ad esempio in Mesia Superiore, vd. AE 2011, 1101 (D. Mladenović). Vd. già E. Mancini, L’evergetismo municipale in Dacia, in Roma e le province del Danubio cit., pp. 331-342.
[9] AE 1987, 867. Vd. ora 2011, 844 e 1120 (J. Kolendo).
[10] Premessa, in Limes, a cura di Giancarlo Susini, Bologna 1994, pp. 5-6.
[11] AE 2008, 1115 (P. Kovács). Per il limes della Pannonia inferiore vd. ora il quadro complessivo fornito da N. Gudea, AE 2013, 1250.
[12] AE 2009, 968.
[13] The Roman and Late Roman City: the International Conference, Veliko Tărnovo 26-30 July 2000, L. Ruseva-Slokoska, V. Dinchev edd., Sofia 2002.
[14] Roma sul Danubio. Da Aquileia a Carnuntum lungo la via dell’ambra, M. Buora, W. Jobst edd., Udine Roma 2002.
[15] Zwischen Region und Reich. Das Gebiet der oberen Donau im Imperium Romanum, P. Herz, P. Schmidt, O. Stoll edd. (Region im Umbruch, 3), Berlin 2010.
[16] Kulturaustausch und Wirtschaftsbeziehungen in den Donauprovinzen des römischen Kaiserreiches, con gli Atti del Convegno di Varna e Tulcea del 2008.
[17] Sul dibattito in corso da un decennio, vd. F. Buscemi, Processi di contatto e interazione culturale nel mondo romano, per un riesame delle posizioni teoriche, in Ricerche e attività del corso internazionalizzato di archeologia, Catania, Varsavia, Konya 2009-2012, P. Militello – M. Camera edd. (Syndesmoi 2), Palermo 2012, pp. 141-151. Restano convincenti le posizioni di G.A. Cecconi, Romanizzazione, diversità culturale, politicamente corretto, “Mefra”, 118,1, 2006, pp. 81-94.
[18] AE 2005, 1137; 2011, 947.
[19] AE 2012, 1054.
[20] P.es. AE 2007, 1211 in Ucraina (A. Ivantchik, O. Pogorelets, R. Savvov); AE 2012, 1188 (Sándorfalva, comitato di Csongrád) (G. Lassányi).
[21] AE 2010, 1239, Andautonia in Pannonia Superiore (I. Knezović). Vd. anche AE 2010, 1141 (M. Šašel Kos) e AE 2008, 1080 (F. Marco Simón, I. Rodà De Llanza).
[22] AE 2012, 1122 (A. Rendić-Miočević).
[23] AE 2011, 1007. Per le divinità fluviali in Rezia e nel Norico, vd. AE 2013, 1165 (A. Forster).
[24] AE 2009, 988 (C. Farka) = 2010, 1142 (G.E. Thüry) = 2012, 1076 (M. Hainzmann, P. De Bernardo Stempel). L’ultimo commento è di E. M. Ruprechtsberger, Archaeologische Forschungen (1983-2014) im Nordwesten der Provinz Noricum, Linz 2015. M. Hainzmann e P. De Bernardo Stempel pensano ad una divinità fluviale (Iuvavus) associata a Giove, che ricalca il nome della città (Iuvavum), nella seconda metà del II secolo: analogo appare l’attuale rapporto oggi tra il toponimo della città di Salzburg e il nome del fiume Salzach. Per la toponomastica in Dacia Porolissensis, con specifico riferimento ai fiumi, vd. AE 2013, 1276 (D.-A. Deac).
[25] AE 2009, 1002.
[26] Vd. G. Alföldy, Dall’Adriatico al Danubio, L’Illirico nell’età greca e romana, Atti del Convegno internazionale Cividale del Friuli 25-27 settembre 2003 (I convegni della Fondazione Niccolò Canussio, 3), G. Urso ed., Pisa 2004, pp. 207-220.
[27] AE 2002, 1250.
[28] L. Mrozewicz, Palaeography of Latin Inscriptions from Novae (Lower Moesia) (Coll. The Poznan Society for the Advancement of the Arts and Sciences, Section of History and Social Sciences, Publications of the Historical Committee, 67), Poznán 2010. Vd. AE 2009, 1199, partendo da ILGNovae di J. Kolendo del 1997 (AE 1999, 1338); 2010, 1408-10.
[29] Ad es. a Brigetio in AE 2004, 1126 (L. Borhy), in Rezia in AE 2005, 1144 (C. Flügel, T. Schmidt, ma già A.U. Stylow), nel Magdalensberg in Norico in AE 2005, 1161-62 (G. Piccottini, H. Grassl); a Linz (Lentia) ancora nel Norico in AE 2005, 1180 (E.M. Ruprechtsberger); AE 2008, 993 (R. Wedenig); a Iuvavum in AE 2007, 1083 (A. Krammer), a Rannersdorf in AE 2007, 1080 (B. Schrettle, S. Tsironi) e a Frauenberg in Stiria in AE 2008, 1013 (I. Kitz); a Schölgen in Alta Austria in AE 2005, 1181 (E. Herzog); vd. anche AE 2006, 1059-71 a Carnuntum; 2008, 1027, Lauriacum in Norico (H. Nowak); 2002, 1077-79 = 2011, 847 e 2002, 1077 = 2011, 848 in Rezia (M. Scholz); sempre in Rezia, a Pförring in Baviera: AE 2012, 855 (H. Wolff).
[30] AE 2008, 1184, Novae in Mesia Inferiore: si tratta del restauro effettuato da Marco Aurelio e Commodo di un tempio [ve]tustate conlabsu[m] per iniziativa del governatore e del legato legionario (E. Bunsch, L. Mrozewicz). Per altri esempi di tituli picti sull’instrumentum, vd. ad esempio AE 2007, 1082, Iuvavum in Norico (G.E. Thüry); 2008, 1077, Buckneudorf in Pannonia Superiore (H. Zabehlicky). Per Novae: AE 2002, 1245.
[31] Ad es. in AE 2006, 947 (M. Vomer Gojković, V. Perko).
[32] Ad es. quelle di Carnuntum: AE 2012, 1131 (I. Weber-Hiden, E. Weber); quelle di Scupi in Mesia Superiore: M. Šašel Kos, A Glimpse into Stonecutters’ Workshops in Scupi, Upper Moesia, in L’officina epigrafica romana in ricordo di Giancarlo Susini, a cura di A. Donati, G. Poma (Epigrafia e antichità, 30), Faenza 2012, pp. 507-524. Per le arae e i picci della Liburnia: AE 2010, 1150 e 1151 (A. Kurilić).
[33] Un caso davvero straordinario è quello studiato da P. Kovács, da Aquincum, dove conosciamo un Clodius Celsinus, che effettua una dedica Marti Gradivo in occasione del suo viaggio presso la legio VII Cl(audia) effettuato ad eradendum nomen saevissimae dominationis degli h(ostes) p(ublici), probilmente Filippo l’Arabo e suo figlio nel 249, AE 2008, 1145; e l’erasione doveva essere effettuata [de vexillis et can]tabris. Per l’erasione su 11 iscrizioni di Novae, vd. AE 2010, 1411 (L. Mrozewicz). Un’erasione del nome del senatore Cn. Cornelius Lentulus Augur è documentata tra il 9 e il 6 a.C. a Callatis in Mesia Inferiore, AE 2013, 1341 (A. Avram, M. Ionescu).
[34] Ad esempio ad Intercisa in Pannonia Inferiore, AE 2010, 1274, con inesattezze nella titolatua di Commodo e in quella di Caracalla (Z. Mráv).
[35] Ad es. in Dacia: H.W. Müller, I. Piso, N. Schwaighofer, M. Benea, Der Marmor im Römischen Dakien, Cluj-Napoca 2012.
[36] AE 2003, 1536 (T. Ivanov), per il territorio della Mesia Inferiore.
[37] AE 2005, 1198 (D. Gabler, A. Márton). Per le Mesie: AE 2005, 1309. Vd. anche il lavoro di M. Matuszewska sui mattoni di Novae in Mesia Inferiore (AE 2006, 1204). Per la ceramica sigillata di importazione, in particolare vasi arretini ed italici, vd. Shkodra in Dalmazia in AE 2007, 1091 (B. Lahi). Per le figlinae imperiali in Pannonia, AE 2007, 1134, 1146-47 (B. Lőrincz). Per Faviana nel Norico: AE 2008, 1024 (I. Hackhofer). Per Locus Felicis oggi Wallsee in Bassa Austria conosciamo un soldato della cohors I Aureli(a) Brit(tonum) magister [fi]gulinae Loco [Felice] Sabinianae, in AE 2008, 1026 (H. Ubl). I bolli sui mattori delle fortificazioni della Dacia Ripensis: AE 2009, 969 (N. Gudea). Naturalmente imponente è il capitolo relativo ai bolli legionari, come a Lauriacum nel Norico per la legio II Italica, AE 2009, 992 (H. Ubl); in Dalmazia per la legio VII Claudia Pia Fidelis dopo il 42 d.C., AE 2011, 888 (D. Tončinić); a Trimammium in Mesia Inferiore per la legio I Italica, AE 2010, 1414 (S. Torbatov); oppure a Novae in AE 2011, 1122 (M. Duch), 1123 (P. Dyczek), 1124 (J. Kolendo, T. Kowal).
Si può passare alle lucernae: ad es. AE 2006, 1055, Carnuntum (I. Žundálek, B. Žundálekova); 2007, 1157, dal campo legionario di Carnuntum (G. Musil, C. Gugl, R. M. Mosser); da Vindobona in Pannonia Superiore in AE 2007, 1160-61, dell’età di Nerone e di Galba (B. Lőrincz). Per la Dacia: AE 2006, 1120 (D. Benea); per la Mesia Superiore: AE 2006, 1183 (A.N. Crnobrnja); per la Mesia Inferiore: AE 2009, 1195 (L. Oţa). Per il Norico: AE 2007, 1081 (A. Puhm, S. Tiefengraber). E poi i vetri, ad es. AE 2007, 1066, Rezia (A. Rottloff); le anfore: ad es. AE 2007, 1075, Rezia (P. Gamper); 2000, 1154-68 (G. Piccottini) e 2008, 1009 nel Magdalensberg in Norico (H. Dolenz): [o]lei Histric[i flos]; 2011, 892, Lissos in Dalmazia (B. Lahi). I mortai: ad es. AE 2007, 1135 in Pannonia (R. Mladoniczi). Le gemme e i cammei: ad es. a Lauriacum nel Norico, in Pannonia AE 2001, 1626 (A. Kovács in CIGP), a Brigetio, AE 2007, 1150-51 e nel Museo di Carnuntum AE 2011, 1002 (G. Dembski), a Intercisa AE 2013, 1270 a-c (T. Gesztelyi); infine in Dacia AE 2002, 1220 (S. Nemeti); gli anelli: ad es. AE 2007, 1150-53, Brigetio in Pannonia Superiore (L. Borhy). Per gli anelli, ad es. quelli conservati al Museo Nazionale Ungherese, vd. AE 2011, 950 (Á Szabó). Solo il III volume dei TitAq curato da B. Fehér contiene mezzo migliaio di bolli da Aquincum, vd. AE 2011, 1020-58; vd. anche 2013, 1261.
[38] AE 2000, 1868 = 2013, 1168 (S.F. Pfahl), Vallatum in Rezia.
[39] Ad es. AE 2013, 1183, Ovilava in Norico (G.E. Thüry): veni cito amica pia. Alcuni anelli hanno dediche a divinità, come nel caso della dedica Sil(vano) sanc(to) v(otum) PVT di AE 2013, 1222, Scarbantia (Z. Mráv); analogo il caso di AE 1979, 478.
[40] AE 2013, 1174, a-.c (G. Piccottini), Magdalensberg, età di Tiberio.
[41] M. Hainzmann, R. Wedenig, Testimonia Epigraphica Norica (TENOR), Instrumentum domesticum Austriae Superioris, Indices, Graz 2002; vd. AE 2002, 1997 e 2007, 1073. Vd. ora il magnum opus sulle 1123 tesserae iscritte di piombo provenienti da Siscia (Sisak in Croatia) in Pannonia superiore: I. Radman-Livaja, Tesere iz Siska. Olovne tesere iz Siscije / Plombs de Siscia: Tekst / Texte e Katalog / Catalogue (Musei Arch. Zagrabiensis Catalogi et Monographiae 9/1 e 9/2), Zagreb 2014.
[42] AE 2013, 1207 (L. Lučić).
[43] Ad es. AE 2004, 1555-56, Augusta Vindelicum in Rezia (U.Ehmig, B. Liou, L. Long).
[44] AE 2004, 1206, Alburnus Maior (I. Piso).
[45] Ad es. AE 2005, 1188, Salona (N. Gauthier), 1196 (M.T. Boatwright), Pannonia; AE 2006, 964, Norico (E. Pochmarski); 2009, 1182 (C. Ciongradi), per 110 monumenti funerari inscritti di Alburnus Maior in Dacia. Per Novae in Mesia inferiore vd. AE 2011, 1121 (J. Kolendo).
[46] Ad es. in Rezia, in Norico, nella Pannonia Superiore (AE 2007, 1061), in Alta Austria (AE 2008, 996 (C. Hemmers, S. Traxler), in Dacia, a Sarmizegetusa, AE 2005, 1297 (M. Mărgineanu-Cârstoiou, V. Apostol, Ş. Balici, C. Meşter).
[47] Ad es. a Celeia in AE 2007, 1079 (J. Visočnik).
[48] Vd. oltre i miliari di Settimio Severo del 201 riutilizzati da Caracalla nel 214, AE 2004, 1085 (M. Lovenjak).
[49] Ad es. AE 2004, 1130 e 2005, 1227 e 2008, 1092; 2011, 842 e 1003, Carnuntum; 2012, 1082, Traismauer (Augustianis), secondo E. Weber; 2008, 1092, Carnuntum, secondo P. Scherrer.
[50] A. Ştefănescu: doppi epigrafici in Dacia (Alburnus Maior, Samum, Micia, Apulum); vd. però V. Rădeanu in AE 2006, 1105.
[51] Ad es. L. Zerbini, Scritture latine nella Dacia romana. Status quaestionis e proposte di ricerca, in L’officina epigrafica romana cit., pp. 525-531.
[52] Ad es. h(ic) i(ille ?) s(itus) e(st), in AE 2003, 1344, in Pannonia (P. Kruschwitz).
[53] AE 2005, 1276 (D. Benea, I. Hica).
[54] P. Cugusi, M. T. Sblendorio Cugusi edd., Studi sui carmi epigrafici: Carmina latina epigraphica Pannonica, Pàtron Bologna 2007 (adde H. Grassl, AE 2010, 1263-64); Carmina Latina Epigraphica Moesica, Carmina latina epigraphica Thraciae, Pàtron Bologna 2008; Carmina Latina Epigraphica non-bücheleriani di Dalmatia (CLEDalm), Edizione e commento, con osservazioni sui carmi bücheleriani della provincia (Epigrafia e antichità, 36), Fratelli Lega, Faenza 2015. Vd. anche diversi interventi su singoli testi, come per l’epigramma di Noviodunum in Mesia Inferiore P. Cugusi, in Res Publica Litterarum. Studies in the Classical Tradition, 23, 2000 (In memory of Scevola Mariotti), pp. 73-103; il poema di Ratisbona (Castra Regina in Rezia) studiato da W. Pfaffel, in AE 2005, 1148 = 2006, 961 (P. Cugusi, M.T. Sblendorio Cugusi); vd. ora AE 2007, 1070 (O. Raith). Infine il poema della via delle tombe di Carnuntum in Pannonia Superiore, rivisto da H. Grassl, che ritiene riguardi un defunto di origine italica, un lixa (valletto dell’esercito), con il rammarico espresso a suo nome dai fratelli per la morte lontana dalla patria, nei primi tempi dell’occupazione romana (AE 2008, 1099 = 2009, 1049):
O utinam Italiae potius mea fata dedissent
quam premeret cineres barbara terra meos.
[55] AE 2008, 1168 = 1993, 1345 (J. Velaza).
[56] AE 2004, 1266 (S. Conrad).
[57] AE 2009, 1201 (V. Nedeljković).
[58] AE 2001, 1732.
[59] M. Mirković, Les inscriptions du Djerdap et la politique romaine sur le Danube de Tibère à Trajan, in Roma e le province del Danubio cit., p. 175-195.
[60] Ad es. Funeraria Daco-Romana, M. Bărbulescu ed., Cluj-Napoca 2003.
[61] Ad es. in Pannonia Inferiore, AE 2004, 1159 (Vereb, Comitato di Fejér): cui vita parva, mors valde citata fuit, quem flentes doleunt miserique parentes, per la morte dei tre piccoli figli di Septimia Decorata.
[62] Particolarmentre acuta l’analisi di R. Selinger sul vocabolario erotico in Pannonia Superiore: l’aggettivo Fututor di un epitafio di Carnuntum non sarebbe un indizio di rapporti omossessuali tra il medico defunto L. Iulius Optatus e il dedicante L. Iulius Faustus: forse solo un cognome, AE 2006, 1058. Viceversa esplicito contenuto erotico hanno le iscrizioni di Solva (oggi Esztergom in Pannonia Superiore), dove ci restano numerosi graffiti con l’espressione dal contenuto erotico: Pidico qui tacunt, AE 2008, 1083 (B. Lőrincz); analoga espressione da Dunakeszi (Pannonia Inferiore), raccolta da Z. Mráv: [Q]ui ta[gunt ?] pidi[co ?], AE 2011, 1059, IV secolo. A Lentia nel Norico conosciamo un [do]minus fartor, un allevatore che ingrassava i volatili, in un’epigrafe dal contenuto erotico, AE 2004, 1092 (G.E. Thüry). Infine l’espressione Dizzo Ebctasiaque atamo del valetudinarium del campo militare di Novae in Mesia Inferiore andrebbe intesa come una dichiarazione d’amore di un trace (Dizzo) verso una donna con nome greco (Euctasia), dove atamo è da intendersi adamo (sono innamorato), AE 2011, 1125, T. Płóciennik, J. Żelazowski. Per il Norico, vd. la fibula di Wels (Ovilava) in AE 2013, 1184 (S[pe]s [a]more si m[e am]as), con un repertorio delle iscrizioni analoghe della Rezia e delle Pannonie (G.E.Thüry). In Dalmazia,vd. le rappresentazioni di un fallo in un’iscrizione funeraria, ad es. in AE 2013, 1194, a-c, Salona (N. Cambi, I. Matijević).
[63] Un’anticipazione è in W. Eck, La loi municipale de Troesmis, Données juridiques et politiques d’une inscription récemment découverte, « Revue historique de droit français et étranger », 91,2, 2013, pp. 199-213. Vd. ora Id., in Integration in Rome and in the Roman World. Proceedings of the Tenth Workshop of the International Network Impact of Empire (Lille, June 23-25, 2011), G. De Kleijn, S. Benois edd., Leyda, Boston 2014, pp. 75-88; vd. AE 2013, 1345.
[64] AE 2013, 1307, Apulum (S. Armani). Per nepos/neptia, vd. AE 2007, 1201 = 2008, 1167 = 2013, 1311, Alburnus Maior (N. Mathieu).
[65] Vd. Epigraphica II. Mensa rotunda epigraphie Daciae Pannonicaeque. Papers of the 4th Hungarian Epigraphic Roundtable, Sarmizegetusa 24-26 ottobre 2003 (Hungarian Polis Studies, 11), G. Németh e I. Piso edd., Debrecen 2004.
[66] AE 2005, 1199; 2007, 1137 e 1139.
[67] AE 2013, 1321,
[68] E. Beu-Dachin, The Latin Language in the Inscriptions of Roman Dacia. Editura Mega, Cluj-Napoca, Romania, 2014.
[69] Ad es. in Scizia Minore, AE 2005 (A. Barnea) oppure in area pontica, AE 2012, 1279 e 2013, 1329 (A. Avram); per una prosopografia al femmiile in Mesia Inferiore, AE 2013, 1330 (R.-G. Curcă).
[70] AE 2006, 945 (L. Mihăilescu-Bîrliba); 2013, 1162 (I. Weber-Hiden).
[71] AE 2008, 986.
[72] AE 2004, 1048 (L. Mihăilescu-Bîrliba).
[73] AE 2002, 1217.
[74] AE 2006, 1141 (F. Beutler).
[75] AE 2004, 1186 (A. Stănescu).
[76] Vd. ad es. per il Norico A. Kakoschke, Die Personennamen in der römischen Provinz Noricum, Hildesheim, Zurich, New York 2012 (Alfa-Omega, Reihe A, 262). Per l’onomastica greca in Dacia, vd. AE 2013, 1275 (M. Dragostin).
[77] Ad es. in Dacia, AE 2005, 1281 (D. Dana); 2007, 1183 (R. Varga); in Mesia Inferiore, AE 2006, 1197 (R.G. Curcă); S. Loma ritiene che in Mesia Superiore l’onomastica sia prevalentemente dalmato-pannonica: AE 2010, 1395. Per la trasmissione dei gentilizi in Rezia, nel Norico e nelle Pannonie: AE 2006, 944 (N.G. Brancato). I nomi preromani in Norico: A. Kakoschke, Die Personennamen in der römischen Provinz Noricum (Alpha-Omega, Reihe A, 262), Hildesheim, Zürich, New York 2012; vd. AE 2004, 1090 (J. Stern). Per la Rezia, vd. AE 2010, 1113 (A. Kakoschke). Per i nomi celtici: AE 2005, 1195 (W. Meid); integrazioni di G. Alföldy in AE 2002, 11745. Vd. anche AE 2004, 1120 (D. Stifter), AE 2012, 1192 (M. Dragostin). Per la Dalmazia sud-orientale e la Dardania, vd. AE 2007, 1060 (M. Mirković). Per il conventus Naronitanus in Dalmazia, vd. AE 2011, 920 (R. Comes). Per l’onomastica femminile in Liburnia, AE 2008, 1032 (A. Kurilić). Naturalmente sono state studiate singole città, come Celeia, AE 2010, 1140 (J. Visočnik). Mi piace citare in questa sede il rarissimo cognome Matera: Aur(elia) Matera di AE 2004, 1169 documentato a Várpalota in agro Poetovionensi, da avvicinare alla Ulp(ia) Matera di ILJug. 164 da Príjedor in Bosnia e alla Matera di Turris Libisonis in Sardegna (AE 2002, 632, F. Manconi; 2005, 689, A. Mastino; P. Ruggeri, in Isole e terraferma nel primo cristianesimo, XI Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana, Roma 2015, p. 529). I nomi geografici in Pannonia: P. Anreiter, Die vorrömischen Namen Pannoniens (Archaeolingua, Serie Minor, 16), Budapest 2001.
[78] Vd. AE 2011, 843 (B. Rossignol).
[79] Per le gemme magiche della Dacia, vd. AE 2002, 1220 (S. Nemeti); altri testi magici dalla Dacia e dalla Mesia Inferiore in AE 2013, 1277 (S. Nemeti); vd. anche AE 2013, 1260, Aquincum (B. Fehér).
[80] Ad es. in Pannonia: AE 2007, 1136 (P. Zsidi, G. Németh). Ad Aquincum conosciamo in età severiana un Marc(ius ?) Marcellus, med(icus), in una dedica di un ex voto ad Esculapio ed Hygia, AE 2008, 1123 (Á. Szabó); vd. anche AE 2009, 1169. Per i medici della Mesia Inferiore, vd. AE 2010, 1407 (D. Aparaschivei) e 2013, 1322 (D. Grbić, S. Drča): quest’ultima ricorda un medico della cohors I Dardanorum in una dedica Asclepio Hygia in età severiana (si noti la rara reincisione di titoli imperiali di Caracalla sul nome di Geta eraso).
[81] Ad es. AE 2009, 1169, Aquincum (A. Barta, G. Lassányi); ad Abusina in Rezia, AE 2011, 860 (B. Steidl); ad Apulum in Dacia, AE 2013, 1308 (G.V. Bounegru, G. Németh, S. Nemeti). È stata effettuata una revisione di una complessa defixio proveniente da Sisak in Pannonia Superiore, riferibile all’età di Traiano, dove si invoca il dio-fiume Savus, assiene a Muta Tagita, certamente la più nota Tacita Muta della tradizione laziale, con l’invito a ridurre al silenzio gli avversari odiati (AE 2008, 1080, F. Marco Simón, I. Rodà De Llanza).
[82] Ad es. AE 2008, 1181, per la popolazione femminile della Mesia Inferiore (V. Piftor).
[83] AE 2009, 1212 (O. Bounegru). Vd. ora F. Matei-Popescu, in Poleis în Marea Neagră. Relaţii interpontice şi producţii locale, Atti del colloquiio di Bucarest del 27-28 settembre 2012, F. Panait-Bîrzescu, I.. Bîrzescu, F. Matei-Popescu, A. Robu edd., Bucarest 2013, pp. 202-233.
[84] Ad esempio nel Norico, a Feldkirchen an der Saalach, AE 2006, 991 (G.E. Thüry): un tinctor.
[85] Ad es. sul Danubio, AE 2006, 946 (O. Bounegru); sul fiume Mureş in Dacia in AE 2006, 1121 (C. Timoc). Lietta De Salvo ha saputo ricostruire un mondo complesso, per la parte fluviale intorno ai nautae, ai naukleroi, agli utricularii dei porti fino al Mar Nero, con i loro culti, le loro concezioni religiose, le loro abilità tecniche, le loro barche, i loro contatti culturali con le popolazioni barbariche (Circolazione e commercio per via d’acqua nelle province danubiane, in Roma e le province del Danubio cit., pp. 79-94). I traffici commerciali potevano usufruire di alcune importanti vie d’acqua: il basso Danubio come via di comunicazione, la navigazione sui grandi fiumi dei Balcani, le navi, i corpora naviculariorum, gli armatori, i marinai, i trafficanti, il loro rapporto col potere nel libro di O. Bounegru (Trafiquants et navigateurs su le Bas Danube et dans le Pont Gauche à l’époque romaine, Wiesbaden 2006).
[86] Ad es. a Carnuntum nell’età dei Severi, AE 2006, 1057 (M. Kandler).
[87] AE 2009, 1032 = 2012, 1108 (M. Buovac). La legio XX era però presente dall’età di Augusto, AE 2010, 1228 (S. Bekavac).
[88] AE 2005, 1182 (Z. Buljević). S. Pastor studia 13 urne di gladiatori rinvenute a Nord dell’anfiteatro di Salona, una con il nome di Leo secu[tor] (AE 2011, 928-929).
[89] Il IIviro quinquennale del municipium Brigetionensium L. Veratius Iulianus realizza per l’anfiteatro il podium cum suis spectaculis p(edum) LXX leg(ioni) I Adi(utrici) p(iae) f(ideli) Sever(ianae). Dunque sotto Severo Alessandro uno dei duoviri del municipio fa costruire la parte dell’anfiteatro lunga 70 piedi (21 metri) con i posti prestigiosi riservati ai militari della legione. Conosciamo altri interventi che vanno collocati nell’epoca dei Severi: un vet(eranus) leg(ionis) I Ad(iutricis) è citato in un epitafio posto da un dec(urio) mun(icipii) Brig(etionensium), AE 2006, 1049 (L. Borhy).
[90] AE 2013, 1243 (F. Beutler).
[91] AE 2013, 1264 (L. Borhy).
[92] AE 2000, 1240; 2004, 1207.
[93] Molto animata la discussione su una iscrizione che secondo I. Tóth e T. Grüll sarebbe ebraica, dedicata Deo M[agno] Aeter[no], che potrebbe ricordare una [synago]ga col titolo di pr[oseucha], AE 2008, 1089-90; contra: D. Gáspár e L. Berger (vd. AE 2005, 12).
[94] Ad Aquincum in Pannonia Inferiore la popolazione di origine siriaca ed ebraica è studiata da T. Budai Balogh: i primi orientali sarebbero giunti con la legio II Adiutrix nel corso delle spedizioni partiche di Traiano e Lucio Vero, poi durante la guerra marcomannica di Marco Aurelio, inviati in Pannonia Inferiore (AE 2011, 1017).
[95] AE 2001, 1701 (N. Gudea).
[96] AE 2009, 970 (A.E. Felle).
[97] Ad es. a Novae in Mesia Inferiore, AE 2006 1203 (J. Kolendo).
[98] AE 2008, 1162 (A. Voloşciuc).
[99] G. Alföldy, in Römische Städte und Festungen an der Donau. Akten der regionalen Konferenz, Beograd, 16-19 Oktober 2003, M. Mirković éd., Belgrado 2005, pp. 23-38. Ma vd. una sintesi dell’intero volume in AE 2005, 1137.
[100] RGDA 30. W. Eck, Die Donau als Ziel römischer Politik: Augustus und die Eroberung des Balkan, in Roma e le province del Danubio cit., pp. 19-33; adde: M. Šašel Kos, Appian and Illyricum (Situla 43), Ljubljana 2005, con un dettagliato commentario della conquista di Illirico (Dalmatia, pp. 393-471), Raetia e Norico (pp. 473-488), Moesia (pp. 489-516).
[101] AE 2008, 984.
[102] AE 2011, 837.
[103] D. Gabler, La campagna progettata contro Maroboduo e le sue conseguenze, in Roma e le province danubiane cit., pp. 125-152.
[104] AE 2010, 1237. Vd. ora la importante sintesi di P. Kovács, A History of Pannonia during the Principate (Antiquitas Reihe 1, 65), Bonn 2014.
[105] AE 2000, 1182. Per la nascita della Pannonia solo sotto Vespasiano, vd. AE 2010, 1237 (M. Šašel Kos).
[106] AE 2008, 1010.
[107] AE 2000, 1152.
[108] AE 2000, 1153.
[109] Vd. AE 2013, 1159. Non tutta la serie è su “Tyche”: vd. ad es. Annona epigraphica Austriaca 1993-1998, in Akten des 7. Österreichischen Althistorikertages, H. Taeuber ed., Vienna 2001, pp. 49-127. Altri numeri sono su “Römisches Österreich”, ad es. 37-38, 2014-15, pp. 195-208 e 209-217.
[110] I miliari di Cetium in Norico sono in AE 1025 (R. Risy).
[111] AE 2005, 1138 (G. Winkler); AE 2006, 948 (E. Weber). Per il campo di Boiodurum in Baviera (oggi Passau), vd. AE 2013, 1170 (M. Boier). Sulle strade romane della Rezia e del Norico, vd. J. Stern, Römerräder in Rätien und Noricum. Unterwegs auf römischen Pfaden (RÖ, 25), Vienna 2002.
[112] 572 in AE 2012, 1083.
[113] E. Weber, I lavori di riedizione del CIL III (Pannonia) : problemi e risultati, in Roma e le province del Danubio cit., pp. 197-208, vd. AE 2010, 1236.
[114] Studia Epigraphica Pannonica (SEP), 3, P. Kovács, B. Fehér, Á. Szabó edd., Budapest 2011; Studia Epigraphica Pannonica (SEP), 4, In memoriam Barnabás Lőrincz, P. Kovács, B. Fehér edd., Budapest 2012; Studia Epigraphica Pannonica (SEP), 5, P. Kovács, B. Fehér edd., Budapest 2013. Vd. anche AE 2008, 1072; 2009, 1038; 2011, 948; 2013, 1200.
[115] AE 2007, 1127-28.
[116] AE 2007, 1128: P. Kovács, Corpus Inscriptionum Graecarum Pannonicarum CIGP, Editio III Aucta (Hungarian Polis Studies, 15), Debrecen Budapest 2007; per la seconda edizione del 2001, vd. AE 2001, 1626.
[117] AE 2008, 1077 (A. Lange, H. Taeuber).
[118] J. Martinović, Antički natpisi u Crnoj Gori. Corpus inscriptionum Latinarum et Graecarum Montenegri, Kotor 2011, con le osservazioni di AE 2011, 883. Vd. ulteriori sette iscrizioni greche (apparentemente arivate nella baia di Kotor, Boka Kotorska, Montenegro, durante la dominazione veneziana) in A. Łajtar, J.J. Martinović, « Palamedes », 76, 2012, pp. 81-107; AE 2012, 1084. Per la storia delle scoperte a Risinium, Butua, Catharum, Antibarium, Olcinium, vd. ancora J. Martinović (AE 2011, 890 e 2013, 1188).
[119] S. Anamali, H. Ceka, É. Deniaux, Corpus des inscriptions latines d’Albanie, Collection de l’École Française de Rome, 410, Roma 2009; U. Ehmig, R. Haensch, Die lateinischen Ischriften aus Albanien (LIA), Bonn 2012.
Il punto di partenza sono evidentemente Le iscrizioni latine di Albania di P.C. Sestieri, Roma 1943.
[120] Un elenco in questa sede è impossibile, vd. RMD, V: p.es. AE 2000, 1213 (Sirmium), 2001, 1725 = RMD, II, 106 (Novae); AE 2004, 1256 (R. Petrovszky per il diploma di Ruse datato al 13 marzo 105, relativo al congedo di un gregalis dell’Ala II Hispanorum et Aruacorum; allo stesso reparto è riferito il beneficiario del diploma frammentario del 138-140 d.C. di Carnuntum AE 2013, 1246, pubblicato da F. Beutler), AE 2004, 1259 (Abrittus con il diploma relativo all’armata del Norico, datato sotto Tito 8 settembre 79, relativo a un gregalis dell’ Ala I Thracum), 2009, 993-995, Stein nel Norico (H. Ubl); AE 2008, 1195 (da Slava Rusă, Ibida, diploma studiato da L. Mihăilescu-Bîrliba del 14 agosto 99, che ci informa sull’esercito della Mesia Inferiore sotto Traiano); 2008, 1116 = 2009, 1075, Putinci in Serbia; 2009, 1185 (Mesia). 2010, 1262, Carnuntum in Pannonia Superiore (F. Beutler); 2010, 1272, Siófok in Pannonia Inferiore (Z. Mráv, I. Vida; W. Eck, A. Pangerl).
[121] AE 2008, 1172.
[122] AE 2003, 1324.
[123] RMD IV, 303 = AE 2002, 1182 (nella edizione di Z. Visy). Altre pseudo-tribù: ad esempio Fl(avia) attribuita ad un veterano della legio II adiutrix in AE 2010, 1285, Aquincum in Pannonia Inferiore. Altri pretorianni congedati sono noti, come dal diploma di Sremska Mitrovica in Pannonia Inferiore, AE 2013, 1252 b, originario di Mursa, data 7 gennaio 245 (Z. Mráv, I. Vida); vd. i Salonitani di AE 2013, 1189 (D. Demicheli).
[124] AE 2000, 1214.
[125] AE 2001, 1606-21.
[126] AE 2010, 1168-1215; 2011, 924; 2012, 1095.
[127] AE 2006, 1007.
[128] Vd. già la sintesi di N. Gauthier al XIV Congresso internazionale di archeologia cristiana di Vienna, in AE 2006, 1006.
[129] AE 2011, 924. Le iscrizioni cristiane di Salona erano state già studiare da J. Janssens e J. Dukić, vd. AE 2008, 1039.
[130] AE 2010, 1189.
[131] AE 2005, 1194.
[132] AE 2008, 1073.
[133] AE 2001, 1298-1561b; AE 2002, 1175; AE 2003, 1132 (B. Lőrincz), 1133 (G. Alföldy).
[134] Tituli Aquincenses (TitAq). Volumen I. Tituli operum publicorum et honorari et sacri, P. Kovács, Á. Szabó edd., Budapest 2009; Volumen II, Tituli sepulcrales et alii Budapestini reperti, P. Kovács, Á. Szabó edd., Budapest 2010.
[135] AE 2011, 1020-58.
[136] AE 2006, 1024.
[137] Vd. già AE 2000, 1224-31.
[138] AE 2005, 1192-93.
[139] Budapest 2010. Vd. AE 2011, 1011. Il supplemento del Corpus Signorum Imperii Romani dedicato a Carnuntum nel 2012 a firma di G. Kremer presenta 772 monumenti utili per conoscere il rapporto tra esercito e vita religiosa, G. Kremet et alii, Götterdastellungen Kult- und Weihedenkmäler aus Carnuntum (Corpus Signorum Imperii Romani. Österreich. Carnuntum, Supplement 1), Vienna 2012. Vd. anche sui monumenti funerari del Norico: G. Kremer, Antike Grabbauten in Noricum. Katalog und Auswertung von Werkstücken als Beitrag zu Rekonstruktion und Typologie (Österreischisches Archäologisches Institut, Sonderschriften, 36), Vienna 2001. Per i 71 monumenti funerari di Lauriacum e Lentia ancora nel Norico, vd. AE 2009, 990 (S. Traxler).
[140] AE 2007, 1138; per il primo volume vd. AE 1997, 1233.
[141] AE 2007, 1129.
[142] B. Lőrincz, O. Harl, Führer zum romischen Lapidarium Bastion VI Komárno, Vienna 2002.
[143] AE 2006, 1043.
[144] AE 2004, 119.
[145] AE 2007, 1140.
[146] E. Tóth, Lapidarium Savariense. Savaria római feliratos kőemlékei (LapSav) (Savaria, 34,2), Szombathely 2011.
[147] AE 2006, 1054. Vd. anche 2013, 1239 (I. Weber-Hiden), un veterano originario di Verona.
[148] AE 2005, 1275.
[149] AE 2000, 1232.
[150] AE 2013, 1271; 2012, 1189. Vd. ad es. AE 2004, 1178.
[151] D. Bondoc, D.R. Dincă, Inscripţii şi piese sculpturale. Muzeul Romanaţiului Caracal, Craiova 2002.
[152] AE 2004, 1179 (D. Bondoc).
[153] AE 2004, 1208. Vd. Monumente din piatră de la Micia în colecţiile Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei. In: M. Crînguş, S. Regep-Vlascici, A. Ştefănescu (eds.), Studia Historica et Archaeologica in honorern Magistrae Doina Benea, Timişoara 2004, 9-19.
[154] AE 2007, 1189.
[155] Le forum vetus de Sarmizegetusa, I,1, I. Piso ed. (Colonia Dacica Sarmizegetusa, 1), Bucarest 2006.
[156] AE 2009, 1205.
[157] AE 2011, 884.
[158] AE 2011, 885.
[159] AE 2009, 1040.
[160] AE 2011, 873 (S. Karl, G. Wrolli).
[161] AE 2004, 1182 (P. Forisek).
[162] AE 2003, 1293.
[163] Vd. ad esempio per la Bassa Austria e in particolare per Carnuntum AE 2008, 985, con gli Atti del convegno di Tulln an der Donau del 5-8 luglio 2004.
[164] AE 2006, 962.
[165] AE 2007, 1071.
[166] AE 2008, 995; 2009, 975.
[167] AE 2007, 1092-5.
[168] AE 2004, 22 e 1181.
[169] AE 2011, 22.
[170] AE 2010, 1104.
[171] AE 2004, 1180.
[172] AE 2007, 1181.
[173] AE 2010, 1356.
[174] AE 2011, 1061.
[175] From Polites to Magos, Studia György Németh sexagenario dedicata, Á. Szabó ed., Budapest-Debrecen 2016.
[176] Studia epigraphica in memoriam Géza Alföldy, W. Eck, B. Fehér, P. Kovács edd., Antiquitas 61, Bonn 2013.
[177] AE 2011, 1062.
[178] AE 2009, 1173.
[179] AE 2009, 1193.
[180] AE 2010, 1103; per il il secondo volume con 23 contributi dedicati ai soprannomi imperiali delle unità, ai diplomi militari, bolli e alla prosopografia vd. AE 2011, 839.
[181] AE 2010, 1118.
[182] AE 2008, 1031 (I. Jadrić).
[183] AE 2000, 1181.
[184] AE 2010, 1148. Per i governatori dell’Illirico Superiore tra il 42 e il 68 d.C., vd. AE 2011, 886.
[185] AE 2008, 1035 (M. Glavičić).
[186] AE 2011, 921.
[187] AE 2003, 1332.
[188] AE 2003, 1333, Ćalići (Brgud in Dalmazia). Carattere differente ha il cippo dell’Isola di Brač in Dalmazia in AE 2013, 1197, con una delimitazione, deter(minavit) di un’area sacra ad Ercole (N. Cambi).
[189] AE 2006, 1004.
[190] AE 2005, 1155.
[191] S. Demougin, S. Lefebvre, “REA”, 104, 2002, pp. 185-209; AE 2007, 1072.
[192] AE 2011, 886.
[193] AE 2000, 1182.
[194] G. Piccottini, “Archaeologia Austriaca”, 84-85, 2000-01, pp. 373-385.
[195] AE 2004, 1082, C. Domergue, G. Piccottini (piombo da Cartagena).
[196] AE 2001, 1592 a, Celje.
[197] Vd. M. Šašel Kos, The early urbanization of Noricum and Pannonia, in Roma e le province del Danubio cit., pp. 209–230.
[198] AE 2008, 985 (J. Rageth). Vd. poi il miliario del 201 da Veldidena di Settimio Severo, Caracalla e Geta, con il nome del fratello minore eraso e quello del fratello maggiore parzialmente reinciso in rasura dopo il 212: [S]everus pius pate[r] (patriae): non fondate le perplessità di R. Frei-Stolba in AE 2002, 1085.
[199] Quattro tribù preromane della Rezia sono documentate anche sui diplomi militari: Runicates, Cattenates, Licates, Calucones, vd. AE 2004, 1053-54 (K. Dietz). Un Vindel(icus) in AE 2006, 960, Celeusum in Rezia (B. Steidl).
[200] CIL IX 3044.
[201] D. Faoro, Praefetctus, procurator, praeses. Genesi delle cariche presidiali equestri nell’Alto Impero Romano, Le Monnier, Firenze 2011, pp. 90 ss.; sui fasti provinciali della Rezia, vd. anche AE 2005, 1142 (B. Steidl) e 2007, 1065 e 2008, 988 (D. Faoro).
[202] AE 2007, 1131.
[203] AE 2004, 1242.
[204] IRTrip. 541.
[205] AE 2007 1224 (L. Fezzi).
[206] AE 1937, 232 e 158.
[207] AE 2006, 1105.
[208] AE 2006, 1106.
[209] AE 2006, 1107.
[210] AE 2005, 1163-64 (G. Piccottini), vd. ILLPRON 234-6.
[211] AE 2004, 1267.
[212] AE 2007, 1130.
[213] S. Perea Yébenez, La legione XII e il prodigio della pioggia sotto M. Aurelio, Madrid 2002. Vd. anche AE 2005, 1196; 2006, 1025; 2008, 1074 (P. Kovács);
[214] AE 2006, 1026 (Cibalae); 2009, 1039. Per la realizzazione di acquedotti nell’età di Settimio Severo, vd. AE 2006, 1092 = 2013, 1253, Cibalae in Pannonia Inferiore (Z. Mráv): [extruxerunt bal]ne[um et] Cib[alensi]bu[s aquam per[duxerunt]; per inciso è improbabile che la titolatura di Caracalla non avesse l’indicazione della terza potestà tribunizia; analoga la dedica AE 2004, 1135 = 2013, 1254: [Ci]ba[lensibus aquam per]dux[eru]nt. Sulla politica di Settimio Severo nel medio Danubio, vd. Z. Mráv, in Studia epigraphica in memoriam Géza Alföldy, W. Eck, B. Fehér, P. Kovács edd., Bonn 2013 (Antiquitas. Reihe 1, Abhandlungen zur alten Geschichte, 61), pp. 205-240; AE 2013, 1160 e 1199 (per la politica edlizia di Severo in Pannonia ad Aquincum, Brigetio, Cibalae, in rapporto alle promozioni istituzionali).
[215] AE 2011, 961.
[216] AE 2008, 1126 (Á. Szabó).
[217] AE 2007, 1170 (Z. Mráv).
[218] AE 2004, 1141 = 2009, 1168 (O. Láng, Z. Mráv); 2010, 1276 (L. Chioffi). Vd. anche AE 2010, 1282, che ricorda un M. Aemilius Ter(etina) C<a>mpanus domo Viminaci(o), adiutor princi(pis) praetori(i) della legio II Adiutrix ad Aquincum.
[219] AE 2006, 1001.
[220] AE 2003, 1325 (F. Steffan).
[221] AE 2004, 1085 (M. Lovenjak).
[222] CIL XVII, 4, 155 a, vd. AE 2005, 1167.
[223] AE 2004, 1136.
[224] AE 2007, 1133.
[225] AE 2004, 1143 Budaörs, Aquincum (Z. Mráv, K. Ottományi); 2005, 1264, 2006, 1100 (H. Ubl).
[226] Z. Mráv, “Communicationes Archaeologicae Hungariae”, 20, 2000, pp. 67-97.
[227] J. Fitz, “Accademia d’Ungheria in Roma, Quaderni di documentazione”, 2, 1961, pp. 5-21. Vd. ora P. Kovács, “Acta Archaeologica Hungarica”, 63, 2012, pp. 383-394,
[228] AE 2007, 1131.
[229] AE 2010, 1288 = 2013, 1263 (M. Németh).
[230] G. Winkler, in AE 2002, 1113 (per IBaivariae Romanae 484).
[231] Roma e le province del Danubio cit., pp. 231-248.
[232] AE 2008, 1200 (F. Matei-Popescu).
[233] AE 2008, 1076. Per la lues, la peste del 182, vd. CIL III 5567 Mauerkirchen in Baviera (M.G. Schmidt). Vd. anche AE 2000, 3 (un falso per Hameter); AE 1994, 1334.
[234] AE 2008, 1018.
[235] RIU 6, 1301; AE 2002, 1186, vd. l’articolo di V. P. Petrović, in questo volume.
[236] AE 2003, 1455 Aquincum (A.R. Facsády). Treboniano Gallo adottò poi il figlio cadetto di Decio Ostiliano e lo nominò Cesare ante il 9 giugno (anche se nel nostro testo compare come Augusto). A Roma la notizia della morte arrivò tra il 9 e il 23 giugno. Il Senato innalzò Ostiliano ad Augusto, divinizzò Decio ed Erennio Etrusco, il 24 giugno compaiono certamente come divi. Dopo il 23 giugno Treboniano adottò Volusiano come Cesare. Dopo la morte per peste di Ostiliano Volusiano fu nominato Augusto e dispose la damnatio dei due Deci. La doppia erasione risale per Ostiliano a dopo la morte del 251; per Treboniano Gallo a dopo l’uccisione nell’agosto 253, vd. AE 2003, 1415.
[237] AE 2003, 1416, Museo di Szekszárd (Z. Mráv).
[238] Vd. H. Petrovitsch, Legio II Italica, Linz 2006.
[239] AE 2011, 1007.
[240] AE 2010, 1268 (P. Kovács).
[241] AE 2001, 1592 c.
[242] AE 2011, 948.
[243] Fontes Pannoniae Antiquae in aetate Constantini, P. Kovács ed., Budapest 2012 (in ungherese); 2013 (in tedesco).
[244] AE 2005, 1194.
[245] AE 2008, 1143 (Á. Szabó).
[246] AE 2008, 1073; vd. 2004, 1134, per i governatori della Pannonia Inferiore tra 106 e 213 (B. Lőrincz). Per il periodo 54-166 d.C., vd. AE 2004, 1118.
[247] AE 2007, 1212.
[248] AE 2008, 1174.
[249] D. Boïadjiev, Les relations ethno-linguistiques en Thrace et en Mésie pendant l’époque romaine, Sofia 2000, pp. 134 s. n. 63 ; AE 2000, 1268.
[250] AE 2009, 1194. Ulteriori legati in AE 2012 1259 (C.C. Petolescu).
[251] AE 2007, 1217; l’opera fa seguito ad un analogo lavoro dello stesso autore del 2001.
[252] AE 2004, 1238, Gigen, vd. IGBulg. 13.
[253] AE 2004, 1184. Vd. anche C.C. Petolescu, “Dacia”, 43-45, 1999-2001, pp. 231-233. Inoltre, per l’epigrafia della Dacia, in particolare per gli ufficiali equestri vd. I. Piso, Fasti provinciae Daciae II. Die ritterlichenn Amtsträger, Bonn 2013 (Antiquitas, I, 60), vd. AE 2013, 1273 (il primo volume: AE 1993, 1318).
[254] AE 2005, 1318.
[255] AE 2004, 1052.
[256] AE 2004, 1053 (K. Dietz).
[257] AE 2012, 1106 (I. Glavaš).
[258] AE 2012, 1109 (M. Glavićić).
[259] AE 2006, 1022 (V. Paškvalin).
[260] In AE 2002, 1115.
[261] M. Mirković, Municipium S(—). A Roman Town in the Central Balkans, Komini near Pljevlja, Montenegro (BAR, International Ser., 2357), Oxford 2012; Ead., Municipium S. Rimski grad u Kominima kod Pljevalja, Belgrado 2012.
[262] AE 2005, 1183.
[263] AE 2002, 1117.
[264] AE 2007, 1099.
[265] AE 2010, 1153-63 (S. Loma).
[266] AE 2010 1217 e 2012, 1106 (I. Glavaš).
[267] Le iscrizioni del Museo e del parco archeologico di Aguntum sono studiate da E. Walde, G. Grabherr, vd. AE 2008, 997-1000.
[268] The Autonomous Town of Noricum and Pannonia [Die autonomen Städte in Noricum und Pannonien], M. Šašel Kos, P. Scherrer edd. I (Situla, 40), Ljubljana 2002; II, (Situla 41-42), Ljubljana 2003-04. AE 2002, 1088; 2003, 1345; 2005, 1233-34.
[269] AE 1997, 1209 (R. Wedenig); 2003, 1322 (H. Grassl).
[270] AE 2003, 1323 (H. Grassl).
[271] AE 2006, 998.
[272] AE 2004, 1093.
[273] AE 2001, 1597.
[274] AE 2003, 1320.
[275] AE 2005, 1233-34.
[276] Il municipio è attestato ancora nell’ultimo anno di Commodo, R[omanus Hercules], vd. AE 2013, 1267, Budakalász (Á. Szabó), completamente da rettificare.
[277] AE 2003, 1445.
[278] RIU 6 1340 = AE 2002, 1204.
[279] AE 2011, 1012.
[280] AE 2005, 1240.
[281] AE 2010, 1270 (M. Bulat).
[282] AE 2000, 1190; 2011, 964.
[283] AE 2011, 964 (E. Tóth). A proposito di aetona, vd. anche la dedica effettuata da un sacerdote provinciale, un cavaliere, sempre a Savaria in AE 2011, 962 (E. Tóth): arcum aeto[namque marmore]am valvis et co[lumnis].
[284] AE 2007, 1158. Vd. anche AE 2013, 1219, Scarbandia (Z. Mráv), un epitafio di Q. Lurius Q.f. Pup(inia) Maxumus vet(eranus) leg(ionis) XV, originario da Tergeste, morto prima del 43 d.C.
[285] RIU II, 502; vd. AE 2009, 1047 e 2013, 1199 (Z. Mráv).
[286] AE 2007, 1144 (Z. Mráv).
[287] AE 2008, 1079 (M. Buzov). Un Aug(ustalis) col(oniae) Sept(imiae) Sisci(ianorum) è in AE 2013, 1205 (P. Prohaszka).
[288] AE 2003, 1352.
[289] AE 2003, 1354 (G. Alföldy). Il numero totale delle arae funerarie non è noto: 7 Tiberi Claudii, 4 donne, una figlia di un Claudius.
[290] AE 2003, 1362.
[291] AE 2006, 1038. Per l’onomastica della Pannonia meridionale, vd. ora I. Radman-Livaja, in The Archaeology of Roman Southern Pannonia. The state of research and selected problems in the Croatian part of the Roman province of Pannonia, B. Migotti ed., Oxford 2012 (BAR International Series, 2393), pp. 137-158.
[292] AE 2013, 1204.
[293] AE 2003, 1349 (E. Tóth).
[294] AE 2003, 1375, Környe (Z. Mráv).
[295] M. Kronberger, Siedlungschronologische Forschungen zu dem canabae legionis von Vindobona. Die Gräberfelder (Monografien der Stadtarchäologie, 1), Vienna 2005.
[296] H. Hubl, Waffen und Uniformen des römischen Heeres der Prinzipatsepoche nach den Grabreliefs Noricums und Pannoniens, Vienna 2013 (Austria Antiqua, 3); AE 2013, 1161.
[297] AE 2004, 1125 (H. Belloc, P. Moreau).
[298] Vd. ad es. AE 2005, 1265.
[299] AE 2013, 1201 (P. Kovács)
[300] AE 2011, 1063.
[301] AE 2013, 1272.
[302] AE 2008, 1171; 2010, 1389.
[303] Ad es. in Pannonia e Mesia: AE 2004, 1049 (M. Kirković).
[304] AE 2003, 1462.
[305] AE 2003, 1515 (R. Étienne, I,. Piso, A. Diaconescu); vd. già IDR III, 2, 135.
[306] Tra il 111 e il 114 in AE 2006, 1139, dove A. Diaconescu esclude che l’epigrafe AE 1998, 1084 faccia riferimento alla data di fondazione della colonia; ma si vedano le osservazioni contrarie di I. Piso anche in AE 2007, 1203. Per Sarmizegetusa vd. il recente citato volume di I. Piso e R. Varga, Trajan und seine Städte.
[307] AE 2006, 1140; vd. AE 2006, 1688 = A. Ibba, in Uchi Maius 2, pp. 147 ss. nr. 44.
[308] AE 2006, 1142.
[309] AE 2006, 1144.
[310] AE 2006, 1152.
[311] AE 2006, 1154.
[312] AE 2003, 1516.
[313] AE 2003, 1517 ss.
[314] IGBulg. I 320.
[315] AE 2011, 1101.
[316] AE 2004, 1226 = ILJug. 2, 511, Sočanica.
[317] AE 2009, 1188 (M. Šašel Kos). Vd. il culto di Antonoo anche a Carnuntum, AE 1994, 1396.
[318] AE 2010, 1107 (F. Feraudi-Gruénais, D. Spasić-Đurić).
[319] AE 2010, 1255; nulla a che fare con Forum Hadriani in Germania Superiore, come supposto da A. Mócsy.
[320] AE 2005 1324.
[321] Incarico già documentato in ILBulg. 16.
[322] AE 2005, 1325 (R. Ivanov). Vd. AE 2008, 1182 (J. Bartels).
[323] A. Suceveanu, SCIVA, 52-53, 2001-02, pp. 157-172.
[324] A. Suceveanu, M. Zahariade, F. Topoleanu, G. Poenaru Bordea, Halmyris, 1. Monografie arheologică, Cluj 2003, pp. 115-126; AE 2003, 1550 ss.
[325] AE 2011, 1140.
[326] AE 2011, 1137 (G. Atanasov).
[327] AE 2011, 1138 (M. Bărbulescu, L. Buzoianu, T. Cliante).
[328] AE 2013, 1339.
[329] AE 2012, 1262.
[330] AE 2004, 1231, vd. IScM I, 2207 e III, 99-100.
[331] AE 2007, 1218.
[332] AE 2010, 1421 (G. Radoslavova, G. Dzanev).
[333] AE 2011, 838 (B. Steidl).
[334] E. Szabó, Epigraphica I, Studies on Epigraphy, G. Németh, P. Forsisek edd. (Hungarian Polis Studies, 6), Debrecen 2000, pp. 131-149 (a proposito di RIU 5, 1066), vd. AE 2000, 1222.
[335] AE 2002, 1176 (J. Fitz).
[336] AE 2001, 1692. Vd. la dedica a Intercisa in Pannonia Inferiore [Genio] templ(ensium) da parte di un soldato della III coorte di Batavi, sacerd(os) tem(pli) divi Marci effettuata il I maggio 211. AE 2009, 1087 (G. Alföldy).
[337] AE 2003, 1408-52 (J. Beszédes, Z. Mráv, E. Tóth); 2005, 1241 e 1251 (P. Kovács).
[338] AE 2003, 1408-52.
[339] AE 2013, 1163, con le osservazioni di I. P(iso).
[340] IIt. XIII,3, 91.
[341] AE 2004, 1153.
[342] AE 2005, 1250. Vd. anche 1265, Aquincum.
[343] AE 2005, 1265.
[344] AE 2008, 1111.
[345] AE 2002, 1148.
[346] AE 2001, 1640.
[347] Vd. A. Mastino, Natione Sardus, Unus color, una vox, una natio, “Archivio Storico Sardo”, L, 2015, pp. 141-181.
[348] AE 2012, 1086.
[349] ILJug. 3, 1924.
[350] Apamea di Siria: AE 2008, 1523; Anazarba in Cilicia AE 2006, 1553; Adana in Cilicia, AE 1991, 1555; Roma: CIL VI 2746, 2758, 2673, 3156-7, 3184, 3214, 3300, 3289, 37224; AE 1954, 79 e 81; 1983, 48; Ravenna: CIL XI 39; Nemausus, CIL XII 3020; Mogontiacum CIL XIII 7247.
[351] CIL III 8730 .
[352] TitAq-2, 682
[353] CIL XIII 11869.
[354] CIL VI 3295, 32805, 32814, 32822, 33036; AE 1948, 68; 1993, 165; 2011, 140; EDCS 12200400.
[355] CIL VIII 9391.
[356] Ravenna: CIL XI, 71; provincia incerta: AE 1988, 1138; Napoli: AE 1892, 140; Prusia ad Hypium in Ponto-Bitinia AE 1954, 231.
[357] CIL VI 3224, 32480, AE 1973, 52.
[358] CIL VI 13233.
[359] AE 2013, 1189 (D. Demicheli).
[360] AE 2008, 1115 (P. Kovács).
[361] AE 2007, 1205 (M.F. Petraccia).
[362] AE 2001, 1728 (M.F. Petraccia).
[363] AE 2008, 1179, vd. IMS IV, 39 e CLEMoes., 54.
[364] AE 2010, 1283, Aquincum, un centurione originario nel II secolo da Lucus Aug(usti), forse Lugo in Hispania Citerior più che Luc-en-Diois in Narbonense.
[365] K. Królczyk, Tituli veteranorum. Veteraneninschriften aus den Donauprovinzen des römisches Reiches (1.-3. Jh. n. Chr.) (Xenia Posnaniensia, Monografie, 6), Poznań 2005. AE 2005, 1140 e 2008, 967.
[366] AE 2009, 1074. Per Intercisa, N. Agócs ha studiato l’origine orientale di militari e civili, vd. AE 2013, 1268.
[367] AE 2000, 1262.
[368] AE 2005, 1218. Vd. anche le due dediche a Giove per la salvezza di Settimio Severo nel 197 che ricordano il prefetto dell’Ala I Thracum veterana M. Gongius Paternus Nestorianus domo Sufibus ex Africa, nato a Sufes in Proconsolare (AE 2003, 1432). Vd. la revisione di I. Piso di AE 2003, 1433 in 2013, 1256 (198-199).
[369] AE 2010, 1240 (M. Lubšina Tušek).
[370] AE 2011, 957.
[371] AE 2005, 1319.
[372] SEP, 3, 2011, pp. 31-38. Vd. anche FPA VI, pp. 164-191; AE 2011, 948.
[373] A. Mastino, T. Pinna, Negromanzia, divinazione, malefici nel passaggio tra paganesimo e cristianesimo in Sardegna: gli strani amici del preside Flavio Massimino, in Epigrafia romana in Sardegna. Atti del I Convegno di studio, Sant’Antioco, 14-15 luglio 2007 (Incontri insulari, I), a cura di F. Cenerini e P. Ruggeri, Carocci Roma 2008, pp. 41-83.
[374] Vd. già AE 2010, 1357, soprattutto sulle origini geografiche dei rappresentanti dell’élite municipale della Dacia.
[375] AE 2004, 1205 (R. Ardevan); 2008, 1154 (E. Dobruna-Salihu).
[376] AE 2008, 1155 (C. Onofrei).
[377] AE 2008, 1156 (C.H. Opreanu).
[378] AE 2008, 1164 (C. Onofrei), per Napoca.
[379] Vd. B. Sanna, R. Zucca, I praetoria del cursus publicus nelle province danubiane, in Roma e le province danubiane cit., pp. 95-111.
[380] AE 2002, 1221; 2006, 1126.
[381] AE 2012, 1247.
[382] AE 2013, 1323 (V. Petrović).
[383] AE 2008, 118-19 (Z. Mráv).
[384] AE 2013, 1269 (Z. Visy), diversamente J. Fitz.
[385] AE 2003, 1529, vd. M. Mirković, Römer an der mittleren Donau. Römische Strassen und Festungen von Singidunum bis Aquae, Belgrado 2003.
[386] AE 2010, 1426.
[387] Vd. i diplomi di età adrianea da Pfatter in Baviera AE 2005, 1149-1150 (B. Steidl) o quello da Straubing in AE 2005, 1153, Straubing (H. Wolff). Eppure la l(egio) III, la l(egio) X e la l(egio) XII (fulminata) sono menzionate alla fine dell’età repubblicana sui proiettili di fionda in piombo in Rezia (AE 2003, 1286 a-c; 2007, 1067-69; 2008, 987; 2009, 971 a-b (J. Rageth); 2011, 845 (J. Rageth, W. Zanier, S. Klein).
[388] AE 2003, 1290 (A. Kolb). Aquae Phoebianae e non Castra Phoebiana, vd. AE 2009, 973, Faimingen in Rezia (H.U. Nuber, G. Seitz).
[389] AE 2011, 849 (L. Bakker).
[390] Per il culto di Mercurio Caisonius in Rezia, importato dalla Germania Superiore, vd. AE 2009, 972 (G. Zahlhaas). Con maggiore approfondimento, a proposito dei numerosi aspetti del culto del Mercurio gallo-romano, vd. anche AE 2013, 1165 (A. Forster).
[391] CIL III 5793, vd. G. Alföldy, in Humanitas. Beiträge zur antiken Kulturgeschichte. Festschrift für Gunther Gottlieb zum 65. Geburtstag, P. Parceló, V. Rosenberger edd., con la collaborazione di V. Dotterweich, Monaco di Baviera 2001, pp. 9-27; dubbi di AE 2001, 1560.
[392] AE 2001, 1567.
[393] P.es. H. Wolff, Ostbairische Grenzmarken, 43, 2001, pp. 9-12; AE 2001, 1568 (156-161 d.C.).
[394] AE 2012, 1062 a-b (S.F. Pfahl). Vd. Anche AE 2013, 1169 (K. Matijević), Caracalla e Geta il I dicembre 2011.
[395] AE 2007, 1064 (M. Reuter).
[396] AE 2006, 999 (H. Petrovitsch).
[397] AE 2000, 1150.
[398] AE 2007, 1232 (C.C. Petolescu, A.-T. Popescu). Per un diploma di Antonino Pio ottenuto tra il 145 e il 147 da un soldato di Mesia Inferiore, vd. AE 2007, 1233.
[399] AE 2006, 1009 (S. Ivčević).
[400] AE 2013, 1193 (I. Matijević).
[401] AE 2012, 1085.
[402] AE 2012, 1094.
[403] AE 2006, 1013 = 2010, 1167.
[404] B. Lőrincz , Die römischen Hilfstruppen in Pannonia während der Prinzipatszeit, I, Die Inschriften (Wiener Archäologische Studien, 3), Vienna 2001. Un ulteriore catalogo dello stesso autore riguarda l’instrumentum.
[405] AE 2013, 1258 (J. Beszédes).
[406] Ad es. AE 2013, 1206, Odra, presso Zagabria in Pannonia Superiore (A. Rendić-Miočević): ve[te](aranus) emeritus coh(ortis) I[I] Va[r(cianorum)].
[407] Ad es. un c(ustos) a(rmorum) leg(ionis) s(upra) s(criptae) nel II secolo, in AE 2016, 1294 ad Aquincum.
[408] Ad esempio AE 2004, 1167 per la Pannonia Inferiore.
[409] Alcuni soldarti erano originari dell’area, come il signifer domo Mur(sa) nell’età di Elagabalo AE 2008, 1139.
[410] Il titolo compare anche nele alae, ad esempio a Napoca in Dacia, AE 2013, 1293 (I. Piso, T. Tecar).
[411] AE 2000, 1217.
[412] AE 2012, 1260 (D. Aparaschivei, per la Mesia Inferiore).
[413] AE 2010, 1287.
[414] AE 2005, 2003, 1431 = 2005, 1242.
[415] AE 2010, 1299 b.
[416] AE 2000, 1223.
[417] AE 2009, 1078 (A. Rendić-Miočević).
[418] Ad es. AE 2002, 1168-72 (Vindobona); AE 2002, 1150-56; 1159-60; 1161 (Carnuntum), ecc. Vd. AE 2011, 949 (S. Ferjančić). Per l’origo dei suoi soldati, prevalentemente dalle Pannonie ma non solo, vd. AE 2013, 1202 (I. Acrudoae).
[419] M. Mosser, Die Steindenkmaeler der legio XV Apollinaris, Vienna 2003. M. Mosser et alii, Die römischen Kasernen in Legionslager Vindobona. Die Ausgrabungen am Judenplatz in Wien in den Jahren 1995-1998, (Monografien der Stadtarchäologie Wien, 5), Vienna 2010.
[420] AE 2010, 1261 = 2013, 1244 (E. Weber), vd. G. Alföldy in CIL II2, 14, 2, E 4.
[421] AE 2002, 1150.
[422] AE 2009, 1050.
[423] Per un veterano della legio IIII F(lavia) F(elix) originario di Vienna in Narbonense alla fine del I secolo d.C., vd. AE 2013, 1214 (Z. Mráv); la legione è ben documentata in Dacia, vd. AE 2013, 1274 (G. Cupcea).
[424] AE 2003, 1366.
[425] K. Dietz, in Zwischen Rom und dem Barbaricum. Festschrift für Titus Kolnik zum 70. Geburtstag (Archaeologica Slovaca, 5, Communicationes), K. Kuzmova, K. Pieta, J. Rajtar edd., Nitra 2002, pp. 79-83.
[426] AE 2008, 1086 (L. Borhy, E. Számadó).
[427] AE 2013, 1234 (P. Kovács- S. Petényi) e 1233 (P. Kovács). Della stessa legione conosciamo sempre in Pannonia Superioree a Győr-Ménfőcsanak, una dedica a Giove effettuata da un b(ene)f(iciarius) co(n)s(ularis), AE 2013, 1235 (Á. Szabó).
[428] B. Lőrincz, Die römischen Hilfstruppen in Pannonien während der Prinzipatszeit, I, Die Inschriften, Vienna 2001; vd. Id., in AE 2005, 1200 (con numerose novità).
[429] AE 2011, 972 e 984, quest’ultima dell’età di Caracalla (P. Kovács, B. Lörincz).
[430] AE 2011, 977 e 986.
[431] AE 2011, 981.
[432] AE 2011, 989.
[433] AE 2011, 990.
[434] AE 2008, 1097.
[435] AE 2013, 1203.
[436] AE 2010, 1243 (P. Kovács, B. Lőrincz).
[437] AE 2010, 1246 (P. Kovács, B. Lőrincz).
[438] AE 2013, 1319, Viminacium (B. Milovanović).
[439] AE 2013, 1320 (Z. Mráv).
[440] A. Ştefan, in Romanité et cité chrétienne. Permanences et mutations, intégration et exclusion du Ier au VIe siècle. Mélanges en l’honneur d’Yvette Duval, Paris 2000, pp. 33-54.
[441] AE 2004, 1223 (M. Mirković).
[442] AE 2005, 1315.
[443] B. Pferdehirt, Römische Militärdiplome und Entlassungsurkunden in der Sammlung des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, Mayence 2004, pp. 126-131; AE 2002, 1237 ; vd. 2003, 1534.
[444] F. Matei-Popescu, Il Mar Nero, 8, 2010-11, pp. 207-230, cfr. AE 2011, 1100.
[445] F. Matei-Popescu, The Roman Army in Moesia Inferior (CRMS, 7), Bucarest 2010, vd. AE 2010, 1404-05 (L. Mihăilescu-Bîrliba). Vd. già AE 2002, 1239 (F. Matei-Popescu). Vd. ora AE 2012, 1249 (N. Ferri).
[446] Ad es. AE 2013, 1301 da Turda in Dacia (I. Piso).
[447] AE 2002, 1240 (R. Ivanov).
[448] AE 2013, 1287, Gherla (I. Piso): ala II [P]annon[i]orum.
[449] AE 2013, 1306, Turda (I. Piso): mil(es) leg(ionis) V M(acednicae) Gor(dianae).
[450] AE 2012, 1239-40 (D. Benea) = 2013, 1310, Apulum in Dacia.
[451] Diversamente K. Strobel, Les legions de Rome sous le Haut-Empire, Y. Le Bohec ed., Lione 2000.
[452] AE 2013, 1279 (I. Piso).
[453] AE 2009, 1197. Vd. anche AE 2002, 1247 e 2008, 1189 (D. Dragoev). Sul reclutamento all’esterno della provincia: AE 2013, 1328 (L. Mihăilescu-Bîrliba). Sui primipilares di fine IV secolo d.C., vd. AE 2013, 1335 (A. Łajtar).
[454] AE 2009, 1199 (J. Recław, J. Źelazowski).
[455] AE 2013, 1336 a (T. Sarnowski).
[456] AE 2005, 1328-30 (T. Sarnowski).
[457] AE 2013, 1337 b.
[458] M. Bărbulescu, Inscriptions from the legionary camp at Potaissa, Bucarest 2014. Vd. già in rumeno in AE 2012, 1202-1236.
[459] AE 2013, 1278.
[460] AE 2013, 1280, vd. 2011, 1070 (I. Piso, contro N. Gudea); vd. ora 2013, 1291, una dedica a Iupiter Conservator da Napoca in Dacia (I.Piso).
[461] AE 2006, 1127 = 2013, 1284 (I. Piso). Vd. anche AE 2013, 1285.
[462] Vd. anche AE 2003, 1305 b (Iulia Cn. Filia Procilla).
[463] AE 2001, 1593 a-b.
[464] AE 2001, 1100.
[465] AE 2006, 1213 (C. Chiriac, L. Mihăilescu-Bîrliba, I. Matei).
[466] AE 2006, 1184, Viminacium.
[467] AE 2003, 1306-07.
[468] Ad es. AE 2001, 1568, Neustadt. Vd. anche il diploma di Viminacium che ricorderebbe a spedizione in Mauretania Cesariense di alcuni reparti della Mesia Inferiore, AE 2006, 1184 (P. Holder).
[469] AE 2009, 1051. Vd. 2013, 1240 (F. Beutler, G. Kremer), Carnuntum e F. Beutller, “Acta Carnuntina”, 5,2, 2015, p. 42: due defunti della gens Aemilia do(mo) Iud(a)ei, alla fine del I secolo d.C.
[470] D.R. Schwartz, Judeans and Jews. Four Faces of Dichotomy in Ancient Jewish History, Toronto 2014.
[471] AE 2006, 1109.
[472] AE 2006, 1112 (D. Dana, F. Matei-Popescu).
[473] AE 2008, 1153 (D. Benea).
[474] AE 2012, 1079 (H. Ubl). Vd. B. Pferdehirt, RGZM, 32 e 33; AE 1975, 951.
[475] AE 2008, 1200.
[476] D. Dana, S. Nemeti, “Acta Musei Napocensis”, 38, 2001, pp. 239-257.
[477] AE 1991, 1378. Vd. 2011, 1142.
[478] AE 2003, 1330.
[479] AE 2000, 1174.
[480] AE 2000, 1171.
[481] AE 2009, 1015.
[482] AE 2009, 1034.
[483] AE 2009, 1079 (M. Ilkić).
[484] AE 2006, 1056.
[485] AE 2003, 1543, con varie irregolarità nella titolatura imperiale di Severo, Caracalla e Geta.
[486] AE 2003, 1544.
[487] AE 2003, 1546-47.
[488] AE 2003, 1548 (C. C. Petolescu, A.-T. Popescu).
[489] S. Perea Yébenez, “Aquila legionis”, 2, 2002, pp. 93-99 (vd. AE 1999, 1333; 2001, 1735; 2002, 1246).
[490] Cl. Zaccaria, Dall’’Aquileiense portorium’ al ‘publicum portorii Illyrici’: revisione e aggiornamento della documentazione epigrafica, in Roma e le province del Danubio cit., pp. 53-78
[491] AE 2008, 994.
[492] AE 2013, 1257, Aquincum (I. Piso).
[493] AE 2008, 1020 e 1019 (B. Steidl).
[494] AE 2013, 1262 (H. Havas).
[495] Ad es. AE 2010, 1136 (G. Piccottini): P. Lepidius P.f. Priscus domo Vicetia.
[496] AE 2004, 1069.
[497] AE 2010, 1124 (G. Piccottini).
[498] AE 2003, 1426 (G. Alfödy, S. Dušanić).
[499] AE 2006, 1094.
[500] S. Dušanić, in Kaiser, Heer und Gesellschaft in der römischen Kaiserzeit. Gedenkschrift für Eric Birley, G. Alföldy, B. Dobson, W. Eck edd., Stuttgart 2000, pp. 343-363.
[501] AE 2005, 1314 (M. Mirković; R. Haensch, P. Weiss).
[502] AE 2002, 1238.
[503] AE 2006, 1189.
[504] AE 2005, 1289 (I. Piso).
[505] AE 2013, 1313: il servo imperiale sembra essere un procurator publici portorii e non un procurator aurariiarum.
[506] AE 2010, 1385.
[507] AE 2003, 1478.
[508] AE 2003, 1480.
[509] L. Zerbini, Le miniere d’oro della Dacia: appunti sulla loro cronologia, “Apulum”, 47, 1, 2010, pp. 241-247.
[510] AE 2007, 1182.
[511] AE 2003, 1502 (C. Crăciun, A. Sion).
[512] AE 2013, 1314-15 (I. Piso).
[513] AE 2005, 1300 a-b e c-d.
[514] AE 2009, 1188 (M. Šašel Kos). Vd. il culto di Antinoo anche a Carnuntum, AE 1994, 1396.
[515] CIL III 1549 = IDR III,1 145 (Tibiscum), Per Porolissum, vd. ora: AE 2008, 1157 (D. Benea) e 2013, 1281, età di Commodo (I. Piso).
[516] AE 2005, 1296. Il salariarius di Apulum in Dacia non ha nulla a che fare con le saline, ma si tratta di un militare congedato che riceve il salarium: AE 2012, 1239-40 (D. Benea) = 2013, 1310.
[517] AE 2001, 1604 (R. Zotović), Prijepolje e Plevlja in Serbia; AE 2013, 1235-36, Győr-Ménfőcsanak in Pannonia Superiore (Á. Szabó).
[518] Vd. ad es. AE 2009, 1007, Seljane in Serbia (S. Loma).
[519] Vd. ad es. AE 2013, 1291, Napoca (I. Piso).
[520] Vd. ad es. AE 2013, 1324, Timacum Minus in Mesia Superiore (S. Petrović, B. Ilijić).
[521] AE 2009, 1189, Mitrovica.
[522] AE 2004, 1067 (M. Hainzmann); anche in Dacia: AE 2003, 1467 (I. Nemeti, S. Nemeti). Ad un dio locale del Danubio attestato anche in Africa pensa ora A. Hilali, Hommes et dieux du Danube dans la légion IIIe Augusta. Le culte de Iupiter Depulsor, in Roma e le province Danubiane cit., pp. 461-468. Il dio è attestato anche a Savaria in Pannonia Superiore, vd. AE 2011, 963 e 964 (E. Tóth).
[523] AE 2013, 1249, Vindobona (M. Mosser): si tratterebbe di una divinità introdotta nel Norico e nella Pannonia dalla Gallia, ma vd. le perplessità di E. W(eber), che pensa ad un epitafio di un Bussumar(i)us di origine celtica.
[524] AE 2006, 1005 e 2009, 1010 (S. Ferjančić, O. Pelcer, M. Babić).
[525] AE 2008, 1166 (K. Karadimitrova). Vd. a Gorsium in Pannonia Inferiore la dedica [I.O.M. Fu]lgeral[i], AE 2009, 1089 (G. Alföldy).
[526] AE 2004, 1211.
[527] AE 2011, 953 (E. Tóth). Per analoghe dediche africane, M. Khanoussi, A. Mastino, Nouvelles découvertes archéologiques et épigraphiques à Uchi Maius (Henchir ed-Douâmis, Tunisie), “RAI”, 2000, pp. 1312 ss.
[528] Vd. anche AE 2012, 1142 (G. Kremer) e la dedica AE 2009, 1084 Rácalmás in Pannonia Inferiore: I.O.M. Cul(minali) et G[e]nio h(uius) loci (A. Buza, T. Keszi). Vd. ora le puntuali osservazzioni di M. Hainzmann, che non pensa ad una divinità del panteon celtico preromano (AE 2013, 1164).
[529] AE 2010, 1225 (M. Sinobad).
[530] I. Piso, Das Heiligtum des Jupiter Optimus Maximus auf dem Pfaffenberg/Carnuntum. I. Die Inschriften, W. Jobst ed., Vienna 2003. AE 2003, 1381-1400.
[531] AE 2003, 1389.
[532] AE 2004, 1131.
[533] AE 2003, 1401 (M. Kandler).
[534] AE 2005, 1233 (M. Kandler).
[535] Anche in Dacia, a Napoca: AE 2003, 1469 = 2013, 1292 (I. Piso).
[536] AE 2005, 1232 (M. Kandler e H. Zabehlicky); 2011, 999.
[537] AE 2008, 1100-05.
[538] AE 2011, 1019 (B. Fehér).
[539] AE 2009, 1129.
[540] M.L. Dészpa, Peripherie-Denken. Transformation und Adaptation des Gottes Silvanus in den Donauprovinzen (1.-4. Jahrhundert n. Chr.), Stuttgart 2012. Per i 160 documenti del culto di Silvano in Dalmazia, vd. AE 2012, 1087 (D. Džino). Vd. anche AE 2007, 1090 (A. Rendić-Miočević).
[541] AE 2013, 1289.
[542] AE 2001, 1703 (T. Lobüscher).
[543] AE 2008, 1141, vd. TitAq 993. AE 2009, 1110-11.
[544] AE 2004, 1051 (P. Scherrer).
[545] AE 2007, 1077 (M. Hainzmann, P. de Bernardo Stempel).
[546] AE 2013, 1165.
[547] AE 2010, 754.
[548] AE 2007, 1103; 2011, 1007 (per la posizione di G. Alföldy, vd. AE 2011, 840).
[549] AE 2005, 1265.
[550] AE 2005, 1265 (Z. Mráv).
[551] AE 2005, 1266.
[552] AE 1962, 26.
[553] AE 2009, 1045 = 2013, 1212 (Z. Mráv).
[554] AE 2013, 1286 (I. Piso).
[555] AE 2005, 1292 = 2013, 1298(I. Piso).
[556] AE 2004, 1201 (V. Moga, R. Ciobanu).
[557] IDR III, 5, 199.
[558] AE 2008, 1142 (Á. Szabó).
[559] AE 2008, 1135.
[560] AE 2008, 1146 (B. Lőrincz).
[561] Ad es. AE 2013, 1336 b, Novae in Mesia Inferiore ([Cons]ervator Augg(ustoum) et [Cae]ss(arum nn(ostrorum) dopo il 293 d.C.: dedica effettuata da un primipilarius [ex p]rov(incia Foenice (T. Sarnowski).
[562] AE 2009, 1128, Aquincum.
[563] AE 2009, 981 = CIL III 5196 (M. Kandler).
[564] AE 2007, 1171.
[565] AE 2004, 1096; 2010, 1164. .
[566] AE 2008, 1129 (Á. Szabó).
[567] AE 2006, 986 = 2011, 881.
[568] AE 2006, 1122.
[569] AE 2004, 1204 Drâmbar (R. Ciobanu).
[570] AE 2013, 1325, Timacum Minus (V. Petrović).
[571] AE 2012, 1262.
[572] AE 2007, 1194.
[573] AE 2003, 1538 (Z. Goćeva).
[574] AE 2005, 1320.
[575] AE 2006, 1200.
[576] AE 2000, 1191.
[577] Ad es. AE 2006, 1052, Quadrata, in Pannonia Superiore (E. Szőnyi, P. Tomka).
[578] AE 2000, 1238 (S. Nemeti); vd. anche AE 2006, 1123 (M. Oppermann).
[579] AE 2000, 1192.
[580] AE 2006, 1075.
[581] AE 2003, 1303.
[582] AE 2013, 1175-76 (J. Eitler, con il commento di F. Glaser).
[583] AE 2013, 1187 (M. Šašel Kos).
[584] AE 2010, 1132 (H. Dolenz).
[585] AE 2004, 1069 (H. Dolenz, P. de Bernardo Stempel).
[586] AE 2006, 1202.
[587] AE 2008, 1078 (B. Migotti).
[588] AE 2011, 1113 (E. Dobruna-Salihu).
[589] AE 2003, 1434 (B. Lőrincz).
[590] E. Hudeczek, Die Römersteinsammlung des Landesmuseums Joanneum, Graz 2004; S. Groh – H. Sedlmayer (Hrsg.), Forschungen im römischen Heiligtum am Burgstall bei St. Margarethen im Lavanttal (Noricum), Wien 2011.
[591] R. Wedenig, in Instrumenta inscripta III, Manufatti iscritti e vita dei santuari in età romana, G. Baratta, S.M. Marengo edd., Macerata 2012, pp. 289-307.
[592] AE 2007, 1074.
[593] H. Dolenz, in Virunum: Das römische Amphitheater. Die Grabungen 1998-2001, R. Jernej, C. Gugl edd., Klagenfurt 2004, pp. 269-322. Vd. anche AE 2006, 963 (M. Hainzmann). Un altro incendio sotto Settimio Severo durante la legazione di P. Catius Sabinus in Norico è ricordato a Iuvavum in AE 2013, 1179 (Z. Mráv).
[594] AE 2001, 1587; 2002, 1094. Per l’erasione di Caracalla: AE 2004, 1070.
[595] AE 2004, 1071.
[596] ILLPRON 436.
[597] AE 2004, 1072.
[598] AE 2004, 1073-74.
[599] AE 2004, 1075-79.
[600] Per il culto di Nemesi nelle province balcanichee e danubiane, vd. AE 2011, 841 (S. Pastor).
[601] AE 2008, 1096.
[602] AE 2005, 1157-60.
[603] AE 2010, 1141.
[604] AE 2006, 992.
[605] AE 2002, 1090 = AE 19967, 1210.
[606] AE 2010, 1393.
[607] AE 2010, 1383 (M. Fiedler, C. Hoepken).
[608] Nel 292 sotto Diocleziano e Massimiano ad Aquincum una schola in ruin[a collapsa] fu reintegrata, come sede del collegium funeraticium che comprendeva anche tombe femminili a cura di Lic(inius) Gaudentius Papi[as] devoto di Diana originario della colonia apula di Lypiae (oggi Lecce): AE 2008, 1150 = 2009, 1165 (P. Kovács, M. Németh). Una nuova dedica da Rattenberg in Stiria (Norico) è in AE 2013, 1177 (E. Steigberger). Per il culto di Diana e di Diana Nemorensis in Dalmazia e un riferimento all’altare sull’Aventino, vd. AE 2013, 1186 (K.A. Giunio).
[609] Vd. ad esempio AE 2013, 1208 e 1209 a, Aquae Iasae presso Poetovio in Pannonia Superiore (L. Lučić).
[610] AE 2012, 1111 (S. Loma). Una dedica D(eo) M(ithrae) è ora segnalata in Carinzia a St. Kathrein da R. Wedenig (AE 2013, 1173, P. Gleirscher).
[611] I. Tóth, Mithras Pannonicus (Specimina nova Universitatis Quinqueeclessiensis, prima pars, 17), Budapest-Pécs 2004.
[612] AE 2007, 1148.
[613] AE 2006, 1201.
[614] L. Bricault, Recueil des inscriptions concernant les cultes Isiaques (RICIS), Paris 2005.
[615] Dalla Dardania del Kosovo (regione di Peć) proviene la dedica Magno numini et conservatori Serapi per un ex voto; Serapide è attestato a Suvi Lukavac come conservator, a Dresnik con l’attributo invictus, AE 2011, 1115 (N. Ferri).
[616] AE 2006, 1041 (G. Gabrieli) = 2011, 970 (Z. Mráv, G. Gabrieli).
[617] RICIS 613/0602.
[618] RICIS 610/0112.
[619] Ma vd. la più antica attestazione in RICIS 519/0302 del 35 d.C., Turris Libisonis in Sardegna.
[620] RICIS 613/0601.
[621] AE 2008, 1082 (G. Gabrieli). Dal municipio flavio di Scarbantia conosciamo anche alcune dediche di statue di divinità dal Capitolium, AE 2013, 1210 (Á. Szabó); vd. anche 1211 per il [cha]lcid[icum]. Per la condizione di municipio flavio, vd. anche 1218 (A. Mráv).
[622] AE 2006, 1010 (S. Ivčević).
[623] AE 2006, 1137.
[624] AE 2003, 1531 = 2013, 1318, Karataš (D. Grbić).
[625] AE 2001, 1606.
[626] AE 2010, 2442.
[627] AE 2013, 1332.
[628] J.R. Carbó García, Los cultos orientales en la Dacia romana. Formas de difusión, integración y control social e ideológico (Colección Vitor, 265), Salamanca 2010.
[629] AE 2001, 1724.
[630] AE 2009, 1085. Vd. ora l’articolo di E. Badaracco, Il culto del Deus Sol Elagabalus presso il castellum di Intercisa:la devozione degli ausiliari della cohors Hemesenorum, in Culti e religiosità nelle province danubiane cit., pp. 235-245, con l’ipotesi di un “ponte” culturale con Calceus Herculis in Numidia.
[631] RIU V 1104. Vd. anche 1106, 1107, 1230.
[632] RIU V 1139. La coorte degli Hemeseni compare ad esempio con Commodo (AE 2010, 1274) e poi, nel 216 (AE 2010, 1273), con la titolatura di Caracalla gravemente lacunosa e alcune inesattezze di edizione anche nel nome del reparto.
[633] RIU II, 473.
[634] AE 2009, 1140-42.
[635] AE 2011, 1084 (I. Piso, O. Ţentea).
[636] AE 2011, 1085 (I. Piso, O. Ţentea).
[637] AE 2004, 1216; I. Piso, in Le forum vetus de Sarmizegetusa, I. Piso ed., 1, Bucureşti 2006.
[638] AE 2012, 1245. Un epulum Iovis è citato in IDR III,2 242.
[639] AE 2004, 1218 (T. Kaizer).
[640] AE 2008, 1187.
[641] AE 2003, 1318 (H. Ubl).
[642] AE 2003, 1532 (M. Mirković).
[643] AE 2005, 1313. Capersana è un villaggio citato da Ammiano (XVIII, 8,1).
[644] AE 2008, 1160.
[645] AE 2006, 1124.
[646] AE 2006, 1125. Vd. anche AE 2001, 1707, Porolissum; 2004, 1222, Drobeta (C.C. Petolescu); 2012, 1196-97 (I. Boda).
[647] AE 2001, 1707 (N. Gudea, D. Tamba).
[648] AE 2008, 1183 (V. Gerasimova).
[649] AE 2005, 1187 (F. Prévot).
[650] CIL III 2654 e 8652 = AE 2009, 1016 a-b (D. Demicheli).
[651] AE 2004, 1225.
[652] AE 2008, 989 (F. Speckhardt). Ad Aquincum in Pannoinia inferioree ci rimane una dedica Iovi Gran(no) Apollini, effettuata da un optio della legio II Adiutrix nel 190 d.C. (AE 2009, 1108).
[653] AE 2011, 889 e 2012, 1088.
[654] L’Augusteum di Narona, a cura di G. Zecchini, Atti della giornata di studi Roma 31 maggio 2013, “L’Erma” di Bretschneider, Centro ricerche e documentazione sull’antichità classica, Monografie 17, Roma 2015. In particolare l’articolo di M. Mayer i Olivé, La epigrafia y el Augusteum de Narona, pp. 19-41. Vd. già M. Mayer in AE 2004, 1097. Vd. ora P. Gros, E. Marin, M. Zink (eds.), Auguste, son époque et l’Augusteum de Narona (Actes du colloque organisé par l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres et l’Université catholique de Croatie (Zagreb)). De Boccard, Paris 2015.
[655] AE 2007, 1098.
[656] AE 2009, 1018 a.
[657] AE 2011, 919.
[658] AE 2009, 1011 (M. Glavičić).
[659] A. Szabó, Pannoniciani sacerdotes, Pécs 2006, vd. AE 2006, 1028.
[660] AE 2006, 1040.
[661] AE 2006, 1093 (Á. Szabó).
[662] AE 2006, 1088.
[663] AE 2008, 1075.
[664] Sul culto imperiale in Pannonia Inferiore, a Vinkovci, Cibalae: AE 2004, 1137 a-b (L. Leleković); a Sopron, AE 2009, 1046 = 2010, 1242 (Á. Szabó): una dedica [Divo] Commodo del 195 d.C., da rettificare.
[665] AE 2013, 1266, l’edizione va emedata.
[666] CIL III 10496, vd. ora AE 2000, 1220 (D. Fishwick); AE 2004, 1139.
[667] Ad es. AE 2004, 1137.
[668] AE 2001, 1696 e 2003, 1367 (Á. Szabó).
[669] AE 2010, 1277, vd. A. Mastino, L’erasione del nome di Geta dalle iscrizioni nel quadro della propaganda politica alla corte di Caracalla, “Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia, Univ. Cagliari”, II = XXXIX, 1978-79 (1981), pp. 47-81.
[670] AE 2006, 1181.
[671] AE 2007, 1213. Per Oescus in Mesia Inferiore, sede del concilio provinciale fino al termine delII secolo, AE 2007, 1220.
[672] AE 2009, 1196. Vd. già AE 2007, 1219.
[673] AE 2010, 1391 (K. Karadimitrova).
[674] AE 2007, 1059 (dove sono trattati anche i seviri delle Pannonie).
[675] AE 2008, 1159 (L. Mihailescu-Bîrliba).
[676] G.P. Marchi, Iscrizioni di Transilvania postillate da Scipione Maffei nel codice CCLXVII della Biblioteca Capitolare di Verona, in Roma e le province del Danubio, cit., pp. 343-348; A: Buonopane, Giuseppe Ariosti e le iscrizioni di Transilvania. Alcune considerazioni in margine al codice CCLXVII della Biblioteca Capitolare di Verona, ibid., pp. 349-373.
 Il lapidario di Rimini è stato intitolato a Giancarlo Susini (Bologna 1927-2000): il 12 dicembre scorso Angela Donati ha svolto in quella sede una breve presentazione del nostro maestro, che vogliamo ora ricordare con le parole pubblicate sui Rendiconti dell’Accademia dei Lincei nel 2003.
Il lapidario di Rimini è stato intitolato a Giancarlo Susini (Bologna 1927-2000): il 12 dicembre scorso Angela Donati ha svolto in quella sede una breve presentazione del nostro maestro, che vogliamo ora ricordare con le parole pubblicate sui Rendiconti dell’Accademia dei Lincei nel 2003.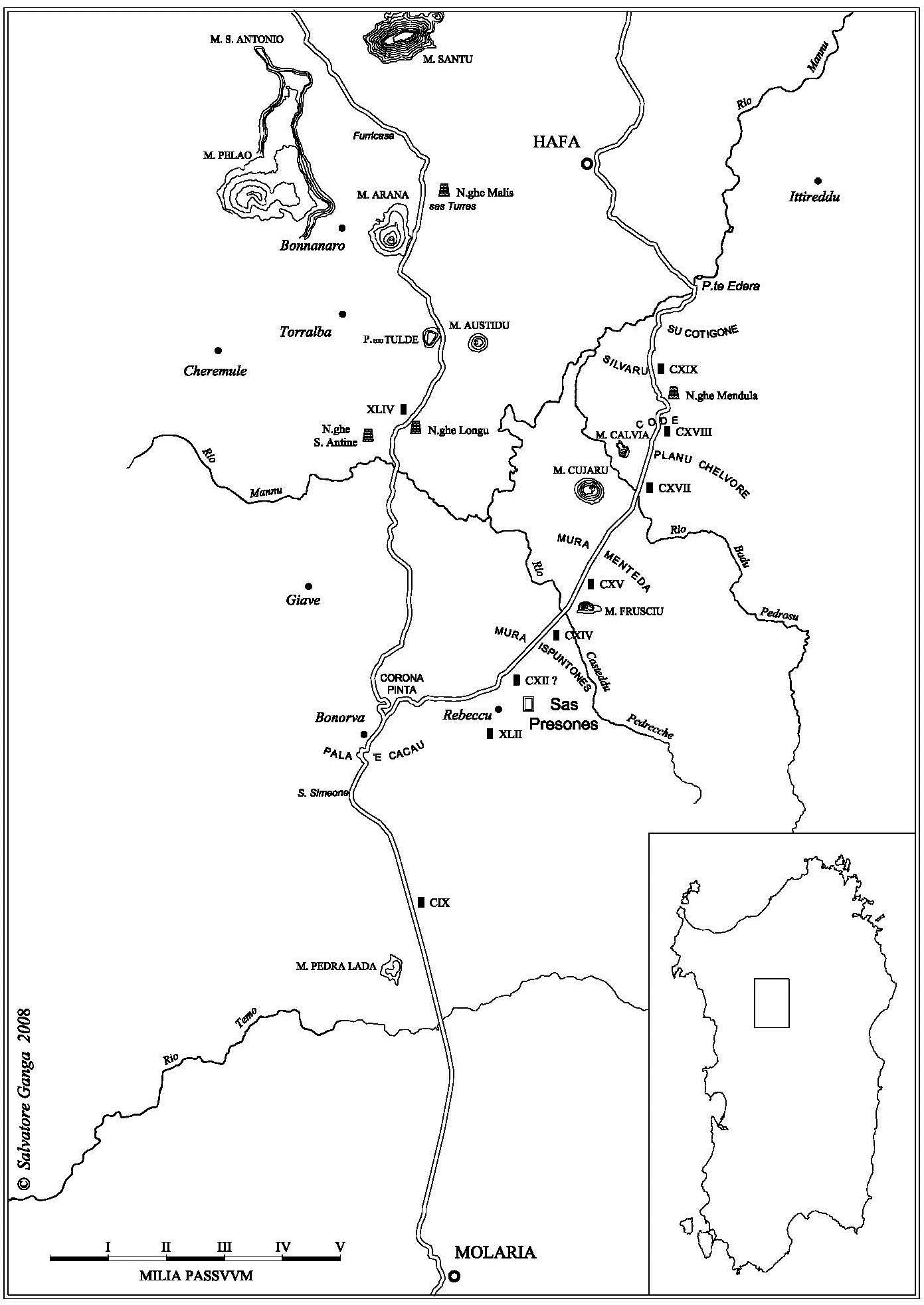


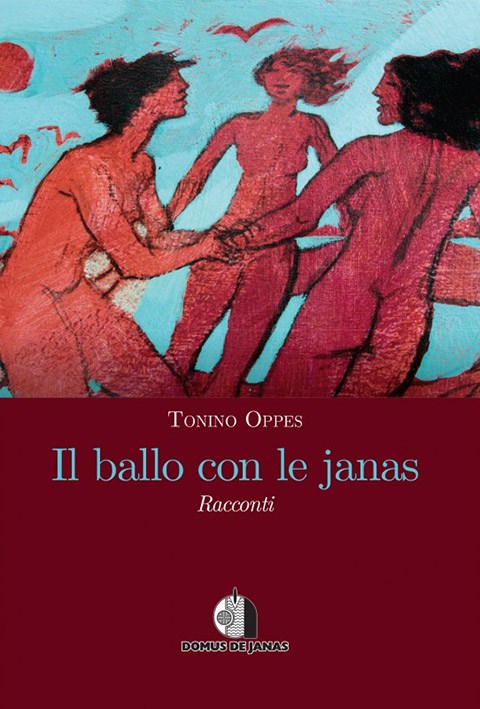
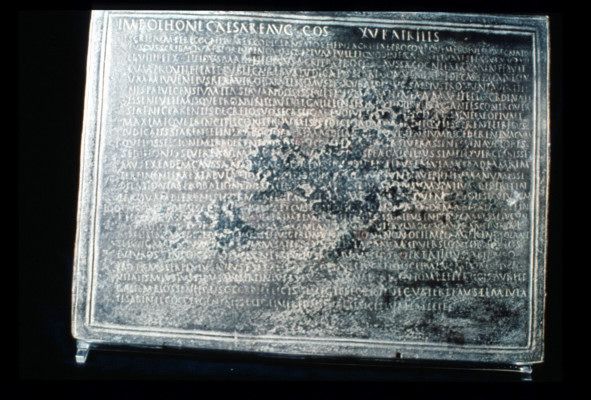
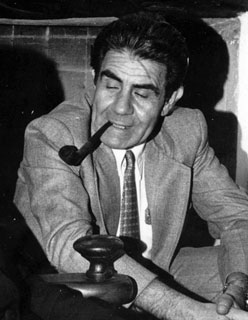

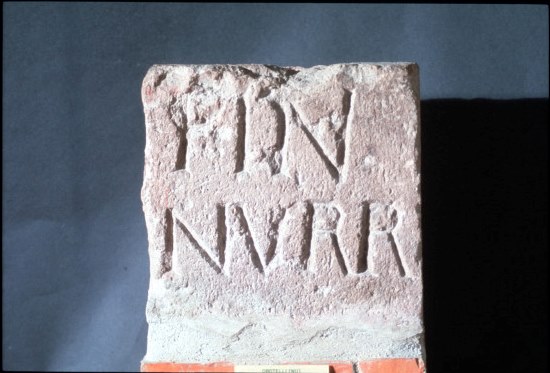 Vindice Lecis negli ultimi ci ha abituato ad un nuovo genere di romanzo storico, dedicato alla Sardegna: Le pietre di Nur nel 2011; Buiakesos, le guardie del Giudice nel 2012; il Condaghe segreto nel 2013; Judikes nel 2014.
Vindice Lecis negli ultimi ci ha abituato ad un nuovo genere di romanzo storico, dedicato alla Sardegna: Le pietre di Nur nel 2011; Buiakesos, le guardie del Giudice nel 2012; il Condaghe segreto nel 2013; Judikes nel 2014.
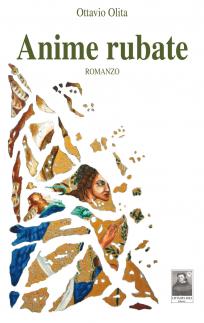 La cronaca di questi ultimi mesi rinnova una ferita, quella del più noto esponente della criminalità e del banditismo sardo compatito o addirittura esibito come campione della “sardità”, “balente”, testimonial in concorsi letterari come in Costa Smeralda o anche oggetto di curiosità morbosa da parte di turisti, villeggianti, autorità di passaggio.
La cronaca di questi ultimi mesi rinnova una ferita, quella del più noto esponente della criminalità e del banditismo sardo compatito o addirittura esibito come campione della “sardità”, “balente”, testimonial in concorsi letterari come in Costa Smeralda o anche oggetto di curiosità morbosa da parte di turisti, villeggianti, autorità di passaggio.