Attilio Mastino
Gli Scritti Africani di Antonino Di Vita, curati da Maria Antonietta Rizzo Di Vita e Ginette Di Vita Evrard.
Roma, Istituto Nazionale di Studi Romani, 6 ottobre 2016
 Ho letto con emozione questi due volumi di Scritti Africani di Antonino Di Vita, curati da Maria Antonietta Rizzo Di Vita e Ginette Di Vita Evrard, ritrovando luoghi che mi sono cari e scoprendo un filo rosso che unisce tanti frammenti sparsi e tante storie diverse, raccontate in quasi mille pagine, 52 articoli, 5 voci di enciclopedia, 17 tra recensioni, presentazioni e ricordi: con una vivacità che impressiona emerge una Tripolitania inedita, ma anche la Cirenaica, il Fezzan dei Garamanti, Cartagine, il teatro di Althiburos, Tipasa, Caesarea, la Numidia.
Ho letto con emozione questi due volumi di Scritti Africani di Antonino Di Vita, curati da Maria Antonietta Rizzo Di Vita e Ginette Di Vita Evrard, ritrovando luoghi che mi sono cari e scoprendo un filo rosso che unisce tanti frammenti sparsi e tante storie diverse, raccontate in quasi mille pagine, 52 articoli, 5 voci di enciclopedia, 17 tra recensioni, presentazioni e ricordi: con una vivacità che impressiona emerge una Tripolitania inedita, ma anche la Cirenaica, il Fezzan dei Garamanti, Cartagine, il teatro di Althiburos, Tipasa, Caesarea, la Numidia.
L’ho fatto però solo dopo aver sfogliato la straordinaria 40° monografia di archeologia libica pubblicata anch’essa da L’Erma di Bretschneider dedicata ai 45 anni di ricerche in Libia dell’Ateneo di Macerata: un’opera ricchissima, che attraverso tanti punti di vista, attraverso le parole dei colleghi e degli allievi, attraverso le immagini della Libia di oggi, consente di capire in profondità, di scavalcare questi decenni, di ricostruire un percorso lungo faticoso fatto di sacrifici personali, di fatiche fisiche che possiamo solo immaginare, di polemiche scientifiche, soprattutto permette di avere un quadro di quella che è davvero l’eredità lasciata da Antonino Di Vita, un gigante dei nostri studi e insieme un maestro capace di stimolare, creare curiosità e interesse tra i giovani, mobilitare risorse e forze nuove fino agli ultimi giorni, fino alla guerra sanguinosa che la Libia sta ancora vivendo in una interminabile fase post-coloniale.
Le sue grandi imprese africane testimoniano capacità organizzative e direzionali non comuni, che bene si sono manifestate negli anni in cui fu Rettore dell’Università di Macerata tra il 1974 e il 1977, quando fu nominato direttore della Scuola Archeologica Italiana di Atene al posto di Doro Levi, un incarico che sembrava assorbirlo interamente; ma questi volumi ci restituiscono lo studioso, l’archeologo colto, il filologo capace anche di pignolerie e di interventi puntualissimi su aspetti di dettaglio, come quando a Sassari nel 1989 mi aveva tormentato sui proiettori speciali che erano necessari per le sue rare grandi diapositive che accompagnavano al VII convegno de L’Africa Romana il suo intervento su Antico e tardo antico in Tripolitania: sopravvivenze e metodologie, ripubblicato in questa sede con le spettacolari immagini della tomba del defunto eroizzato di Sabratha e di sua moglie, sepolti in età giulio-claudia. Allora aveva un poco approfittato della nostra gratitudine, pubblicando nelle 16 costosissime tavole a colori i tondi dei 4 venti della villa di Tagiura, gli emblemata di Oceano e di Artemide Selene da Sabratha, l’incredibile Anfitrite tra le Nereidi e la tomba di Aelia Arisuth di Gargharesc. Ci aveva fatto scoprire un mondo colorato e emozionante, che ora ritroviamo in queste pagine nelle quali sono pubblicate tante foto a colori originali, recuperate negli ordinatissimi archivi del Centro di Macerata.
Per quanto mi riguarda personalmente, io l’avevo conosciuto per la prima volta ad Atene ai primi di ottobre del 1982, una settimana dopo la nascita di mio figlio Paolo, in occasione dell’VIII congresso internazionale di epigrafia greca e latina, dove Ginette aveva voluto presentare con molta indulgenza il mio volume su Caracalla e Geta, fresco di stampa, che le era stato passato da Claude Nicolet e che Pietro Romanelli, Guido Barbieri, Giancarlo Susini e Margherita Guarducci avevano rivisto con severità. Allora Antonino e Ginette ci avevano festeggiato, noi italiani, nella Scuola Archeologica Italiana, con un brindisi ai piedi del Partenone, che tanto ci aveva emozionato. Rileggendo il primo articolo di questa raccolta, pubblicato sul I numero della rivista “Libya antiqua” fondata da lui assieme a R. Goodchild, dedicato nel 1964 al limes romano di Tripolitania nella sua concretezza archeologica e nella sua realtà storica, credo di aver capito le ragioni di quella simpatia che ha sempre avuto nei miei confronti, soprattutto per merito di Settimio Severo e dei suoi figli. Per Di Vita fu la politica dei Severi a dare un’impronta fondamentale a Leptis Magna (basti pensare all’arco quadrifronte o all’epigrafe di Plauziano venuta alla luce nel 1964 dall’esedra del Foro Vecchio), così come a Sabratha o a tante città della Tripolitania e della Cirenaica romana; lo sosteneva in rapporto alle costruzioni in perfetta opera isodomica nel predeserto orientale tripolitano, partendo dalle premesse puniche e dalla complessità della cultura romano-africana; lo scriveva raccontando le fasi severiane della villa di Tagiura; ma soprattutto ipotizzando il piano originario del Forum Novum Severianum di Leptis, le due piazze progettate, separate dalla monumentale basilica con al margine il tempio della Gens Septimia. Soprattutto sul piano militare gli sembrava che l’opera fondamentale di Settimio Severo dovesse essere rivalutata alquanto, per la sua sistematicità strategica, per la costruzione di una linea di difesa appoggiata su forti come Bu Ngem, Gheria el-Gharbia, Ghadames: infine per lo stanziamento di gentiles-limitanei. Ne avrebbe parlato ancora nel 1996 su “Antike Welt” e nell’articolo postumo sul tesoro di Misurata. L’uomo aveva già le idee chiare e pochi anni dopo, nel 1965, la scoperta della grande iscrizione sulla fondazione del forte di Gheriat el-Gharbia confermava l’opera dei Severi tra il 198 e il 201, con l’intervento di una vexillatio della legione III Augusta negli anni del legato Q. Anicio Fausto.
Ci saremmo poi incrociati spesso in biblioteca a Roma, soprattutto ci avrebbe seguito nei convegni de “L’Africa Romana” a Sassari nel 1989, poi a Oristano nel 1992, a Tozeur nel 2002, a Rabat nel 2004, con interventi che ho potuto riscoprire con sorpresa. Proprio a Tozeur si era divertito moltissimo, assieme a Maria Antonietta, quando avevo voluto commentare un poco provocatoriamente davanti alle Autorità presenti e ad un pubblico internazionale una proposta formulata da Andrea Carandini, nel volume Giornale di scavo. Pensieri sparsi di un archeologo, pubblicato da Einaudi nel 2000, nel pieno della polemica sul rinnovo della direzione della Scuola Archeologica Italiana di Atene. Carandini proponeva la nascita a Tunisi di una scuola stabile aperta agli studenti italiani e magrebini, un progetto che è ormai maturo e che si è andato concretizzando a partire dal 22 febbraio di quest’anno, quando la Scuola è stata formalmente istituita e subito riconosciuta con personalità giuridica. Ieri abbiamo visitato i nuovi locali per la Biblioteca Sabatino Moscati a Tunisi-Montplaisir e per la SAIC al VI piano del nuovo palazzo dell’Agence de mise en valeur du patri moine et de promotion culturelle Sfogliando queste pagine si capiscono tante cose, come rileggendo l’articolo “Questioni di metodo” su Archeologia Classica del 1964, che è sostanzialmente una deliziosa ma feroce risposta al giovane ventisettenne dott. Carandini, che con qualche ragione lamentava il ritardo con il quale gli archeologi italiani pubblicavano i risultati degli scavi di Sabratha e di Leptis; ma tutto era documentato nei giornali di scavo conservati nel castello di Tripoli; lo scontro era concentrato sulla cronologia dei mosaici di Zliten, con le immagini delle stagioni che sono espressione di ateliers e di maestranze locali, che non vanno collocate in una fase troppo avanzata. Di Vita avrebbe ripreso la discussione con più garbo al VII Convegno de L’Africa Romana a Sassari nel 1989, cercando di convincere i suoi interlocutori sul sapore arcaico, “punico” dei mosaici di Zliten, con questi giganteschi occhi bovini, con le pupille dilatate, che ricordano modi espressivi di arte “popolare” . Del resto in Libia pochissimi archeologi italiani si erano visti caricati della responsabilità di studiare uno sterminato numero di monumenti antichi: l’intervento era forse indirizzato a difendere Salvatore Aurigemma (morto proprio in quel 1964), ma si può pensare a Ernesto Vergara Caffarelli, scomparso tre anni prima (ho letto il commosso ricordo su Libya Antiqua) e forse a Giacomo Caputo, che nel 1948 aveva inaugurato con le sculture di Tolemaide la serie delle Monografie di archeologia libica e proprio nel 1964 pubblicava il volume su Leptis Magna assieme a Bianchi Bandinelli); infine a Gennaro Pesce (rimasto a Tripoli fino a novembre 1945, autore del volume sul tempio di Iside a Sabrata del 1953; morto a Cagliari nel 1984). Ma c’è incombente anche la figura di Pietro Romanelli.
Tutta giocata tra archeologia e storia dell’arte, con ruoli che mi pare si siano poi ribaltati, la polemica Di Vita-Carandini che si è estesa da Tagiura a Piazza Armerina non ha impedito ai due di collaborare attivamente; del resto il dialogo col Carandini rimane sotto traccia come a proposito dell’assenza di un porto alla foce dell’uadi Lebda visto che la polis di Leptis in età ellenistica liména dè ouk echei; fu Di Vita a ritrovare prima del 1974 il porto arcaico col molo più antico, al capo Hermaion, oggi sul promontorio occidentale di Homs, ben prima del porto-canale neroniano e del gigantesco kothon severiano che così bene ora conosciamo con le sue banchine di attracco che conservano sorprendentemente intatti i modiglioni di ormeggio, per quanto l’interramento provocato dalle sabbie e dalle esondazioni del fiume abbiano progressivamente soffocato le attività portuali. Con Carandini avrebbe condotto vere e proprie missioni di topografia, come quella di Leptis Minus nel 1973, assieme a Giulio Schiemdt, con l’intervento della nave per ricerche oceanografiche Marsili del CNR. Ma già nel 1973 Di Vita assieme a Beschaouch volle Carandini direttore della missione a Cartagine e dieci anni dopo avrebbe recensito positivamente il volume sugli scavi conclusi nel 1977 nell’ambito del progetto Unesco; per non parlare della collaborazione con <<il giovane incaricato dell’Università di Siena e a capo dell’équipe del ‘cantinone’ in cui brillava già Tina Panella>> nello scavo del Castellum del Nador tra Tipasa e Caesarea di cui al volume del 1989, con l’edizione dell’iscrizione del flamine quinquennale M. Cincius Hilarinus che data una delle fasi della fattoria algerina; ne avrebbe parlato nel 2011 nelle conclusioni al volume su I Fenici in Algeria.
Del resto sappiamo che l’uomo, Nino Di Vita, era effettivamente spigoloso, coraggioso, addirittura avventato, aveva aperto altre polemiche ad esempio col Sandro Stucchi tripolitano; con Claude Lepelley sui terremoti; con J.B. Ward Perkins sullo sviluppo urbano di Leptis Magna e Sabratha in età tardo-neroniana proprio con un richiamo alla colpa comune a italiani e inglesi di non aver finora pubblicato in maniera adeguata gli scavi di Sabratha; eppure col tempo si era addolcito. Negli ultimi tempi lo avevo incontrato a Roma, a casa sua, con Maria Antonietta, a parlare del rapporto tra arte e archeologia, il tema affrontato da Ettore Janulardo nel volume su Macerata, come – per tornare al mio piccolo mondo – a proposito di Mekiorre Melis, il pittore in fuga da Tripoli liberata dagli Alleati, direttore della Scuola musulmana di arti e mestieri, all’epoca di Italo Balbo, rifugiatosi nel 1944 nel più piccolo paese della Sardegna, Modolo (dove contemporaneamente arrivava dall’Istria bambino il poeta Orlando Biddau, che parlando del padre soldato avrebbe scritto: «giunse l’uomo spezzato dalla guerra, / faceva vino cattivo, era intrattabile>>).
Se c’è una cosa che Di Vita ci ha insegnato è soprattutto questa voglia di costruire ponti, reti, relazioni con i colleghi del Maghreb; questo rispetto per la cultura araba; la piena coscienza della necessità di un approccio che si liberasse dai condizionamenti acritici contemporanei, legati alla colonizzazione e alla successiva incerta fase di decolonizzazione dei paesi africani, al tema di una romanizzazione imposta o di una resistenza affermata acriticamente senza fare i conti con i luoghi, i tempi, la profondità dei sostrati libico e punico; e poi il riconoscimento generoso del contributo individuale di ciascuno dei suoi valenti collaboratori, operai, restauratori, capi cantiere, specialisti; questa volontà di “lavorare insieme”, respingendo categoricamente la prospettiva falsamente progressista del rapporto tra culture egemoni e culture subalterne, la voglia di immaginare per la riva sud del Mediterraneo ma per noi stessi un futuro desiderabile anche senza prevederlo e, per usare un’espressione felice di Bibo Cecchini e di Ivan Blečić, di programmare una fase nuova di un mondo futuro animato da città che vorremmo antifragili, partendo dalla profondità della storia e dalla complessità delle culture diverse. Le Corbusier nel 1965 sosteneva: <<Essere moderni non è una moda, è uno stato: Bisogna capire la storia: e chi capisce la storia sa trovare la continuità tra ciò che era, che è e che sarà>>. Credo che una lezione di questo tipo nel mondo sanguinoso e violento che stiamo vivendo sia davvero preziosa, soprattutto se metteremo da parte quell’idea di “mare nostrum” che Franco Cassano ne Il pensiero meridiano considera <<odiosa per il suo senso proprietario>>: essa <<oggi può essere pronunziata solo se si accetta uno slittamento del suo significato. Il soggetto proprietario di quell’aggettivo non è, non deve essere, un popolo imperiale che si espande risucchiando l’altro al suo interno, ma il “noi” mediterraneo. Quell’espressione non sarà ingannevole solo se sarà detta con convinzione e contemporaneamente in più lingue>>.
Allora possiamo mettere da parte il volume di Macerata, che illustra l’eredità di Di Vita testimoniata dai tanti giovani studiosi ormai attivamente all’opera, come i colleghi del Politecnico di Bari e di tante altre Università, del CNR, del Dipartimento alle antichità della Libia, dell’Institut National du Patrimoine di Tunisi, temi sintetizzati nella bella mostra agli antichi forni di Macerata del marzo 2014. Oggi non possiamo certo dimenticare la crisi internazionale in atto, la nuova frontiera che come ai tempi delle Arae Philenorum separa Cirenaica e Tripolitania (un tema caro a Di Vita, che vedeva la Tripolitania proiettata attraverso il Gebel verso occidente, lungo la strada per Tacapae-Gabes), la presenza di truppe del Daesh e di eserciti contrapposti in una Libia orfana di Gheddafi e bombardata dall’aviazione occidentale, con negli occhi l’immagine della stazione aeroportuale di Tripoli completamente devastata o l’auto Wolkswaghen del colonnello sventrata nella prima sala del museo archeologico del castello di Tripoli. Di Vita era contro il terrorismo islamico, anche se ne parlava al passato a proposito ad esempio della rovinosa conquista del Maghreb ad opera dei Bani Hilal e dei Bani Suléim. <<Tale conquista, per quanto certa critica modernissima, di estrazione francese ed araba, cerchi di farla apparire come quasi pacifica e civilizzatrice, dal punto di vista archeologico è testimoniata in Tripolitania, almeno, da profonde distruzioni e gli scavi condotti dal Dipartimento libico alle antichità nella città alto-islamica di Medinet Sultan oggi Sort tra il 1963 e il 1965 sono, al riguardo, più che significativi>>. A San Leucio di Caserta all’incontro promosso da Serena Ensoli avevamo parlato del disastro libico dopo il bombardamento del marzo 2011, poche settimane prima della morte di Mu’ammar Gheddafi (avvenuta il 20 ottobre), seguita due giorni dopo da quella di Di Vita: allora avevo rievocato l’emozione del viaggio compiuto con Raimondo Zucca, Piero Cappuccinelli, Salvatore Rubino, a Cirene, Sabratha, Tripoli, l’antica Oea, Tagiura, Leptis Magna, dove rimane evidente e visibile l’orma imponente dell’imperatore Settimio Severo e dei suoi figli; in quell’occasione a Sabratha a settembre 2008 avevamo incontrato Nicola Bonacasa, purtroppo scomparso a dicembre dell’anno scorso e Rosa Maria Carra, con i loro colleghi libici e i loro allievi, che scavavano ai piedi del mausoleo punico-ellenistico B.
Sono allora tornato ai due volumi di Scritti Africani che presento aiutato da Giorgio Rocco che leggerà dall’interno le principali imprese internazionali guidate da Di Vita e ho potuto ripercorrere una strada davvero emozionante che inizia nel 1962 in Libia e che documenta lo sviluppo nel tempo di tante grandi scoperte archeologiche, partendo dal Gebel tripolitano e dai due mausolei di Sabratha appena liberati dalle macerie: gli interventi pubblicati <<spaziano – scrivono le curatrici – dalla topografia all’urbanistica e all’architettura, dalla pittura ai mosaici, dalla scultura alle produzioni ceramiche, dall’epigrafia alla numismatica, alla storia delle istituzioni>>, partendo dal dato archeologico per ricostruire anche attraverso la cultura materiale il più ampio e complesso contesto socio-economico e storico della Libia antica. Mi pare che la presentazione dei testi in ordine di pubblicazione – anche in questa sede – restituisca il senso di un continuo progresso negli studi, di una sostanziale maturazione, con non pochi ripensamenti e qualche salutare polemica tra studiosi.
Il tema ricorrente del terremoto del 21 luglio 365 compare già nel primo articolo e percorre tutti questi due volumi, dove passo passo scopriamo una riflessione sempre più profonda e radicata. Le sue rassegne “Archeological News” su Libya Antiqua che dal 1964 arrivano al V numero della nuova serie del 2010, ma anche nella voce Libia delle Appendici del 1979 e del 1993 dell’Enciclopedia Italiana: a Leptis Magna raccontano la via colonnata, il porto, il grandioso circo e l’anfiteatro quasi inedito con la piccola edicola dell’Artemide efesia del 56 d.C, sul lato meridionale, con la fondamentale scoperta dell’iscrizione neroniana pubblicata da Ginette, il Serapeo, poi studiato frontalmente nei Quaderni del 2003, con specifica attenzione per le provenienze dei marmi assieme a Lorenzo Lazzarini e Bruno Turi, soprattutto il pentelico delle statue (anche dei capitelli del foro severiano), il marmo lunense delle teste isiache, il docimio del Marco Aurelio e del Serapide nero (con il corpo in marno lesbio), il marmo greco scritto e il proconnesio; e poi le pietre colorate, tra le quali emerge per bellezza la breccia nuvolata o la breccia corallina (marmor Sagarium) delle crustae parietali, proveniente dalla Bitinia; il marmor Lucullaeum, Scireticum, Chalcidicum, Taenarium. Temi che rimandano ad una ricca committenza e alla grande importanza e prestigio del Serapeo: in questo quadro significative appaiono le numerose dediche epigrafiche a Serapide in lingua greca presentate da Ginette: tra le iscrizioni latine si segnala il donario per Serapide e Iside del cittadino romano Q. Titleis C.f. che si data alla metà del I secolo a.C. e dunque rappresenta la più antica iscrizione di Leptis; ma ad indicarci il fascio di relazioni mediterranee si aggiungono le epigrafi relative ad un personaggio alessandrino signo Doulkiti, un Aur(elius) Sempronius Serenus e(ques) r(omanus) principalis Alexandr(iae).
E poi l’arco di Marco Aurelio e quello di Settimio Severo; il tempio d’età flavia; ancora di questi primissimi anni sono le indagini a Medinet Sultan, il Gebel e il predeserto con il Gasr Laussàgia, il medio e basso Soffegin, con il gasr di età imperiale sull’Uadi Gargiuma, il mausoleo di Uadi Mesueggi o di Gasr el Banat. E poi le nuove acquisizioni del Museo di Tripoli, come il misterioso ostracon inscritto di Assenamat, il doccione di Gasr el Banat, le lucerne di Zuara; a Sabratha era in corso la redazione del volume di Elda Joly dell’Università di Palermo sulle lucerne; si ripetevano i soggiorni di Pierre Salama che studiava i miliari dioclezianei, negando con soddisfazione di Di Vita l’ipotesi di un abbandono della Tripolitania costiera durante la tetrarchia; Salama in realtà era arrivato per pubblicare, da buon numismatico, gli 8000 folles di Massenzio dall’anfora ripescata a Marsa Marcan (di cui all’articolo con Annalisa Polosa sui Quaderni del 2009, con 27000 pezzi). Dopo la guerra dei sei giorni Salama non sarebbe più potuto tornare in Libia. E poi le basiliche cristiane in area gebelica, la testimonianza di Henscir Taglissi con l’iscrizione di Emiliano che disposuit, instituit, perfecit la basilica, richiamando le laudes domino omnipotenti deo e di suo figlio Cristo; un testo dal vago sapore donatista già per Goodchild e Ward Perkins. Le aree cimiteriali cristiane con le cupae monolitiche secondo lo Gsell di lontana tradizione punica. Fu Di Vita a dare nel 1964 alle terme di Tagiura la denominazione di “Villa della gara delle Nereidi” (così ad altri monumenti come la tomba della Gorgone a Sabratha o la tomba del defunto eroizzato), anche se ancora completamente da scrivere gli sembrava la storia dei mosaici della Tripolitania. Due anni dopo lui stesso ne avrebbe dato un fondamentale acutissimo contributo, 50 pagine, nei Supplementi a Libya antiqua, nel momento in cui – scriveva nel 1966 – <<lascio la carica di Consulente presso il Dipartimento per le Antichità della Tripolitania>>; sarebbe stato l’ultimo europeo a rivestire questo incarico: il quadro rispondeva ad un’esigenza, quella di ancorare il linguaggio artistico alle fasi storiche della Tripolitania romana. Si poteva ora partire dai bolli laterizi urbani sesquipedali e bipedali delle notissime officine urbane di Domizia Lucilla, madre di Marco Aurelio, datati al 155 (Severo et Sabiniano coss.) ed al 157 (Barbaro et Regulo coss.), dunque nella piena età Antonina. Ora era possibile accertare lo sviluppo della “villa di piacere” che si affacciava sul Mare Africum con la sua complessa planimetria, le sue terme, i suoi straordinari pavimenti musivi, in particolare i mosaici figurati con le quattro Nereidi che corrono ritte sul dorso di altrettanti mostri marini, dei quali le tre perdenti eccitano il corso mentre la vincitrice della gara lo raffrena; temi che rispondono ad una concezione decisamente barocca, aperta a sviluppi futuri, ben distinti dai tondi (quelli dei 4 venti) che appaiono più tradizionali, accademici e concepiti secondo i dettami del realismo pittorico. E poi i mosaici della seconda fase, che colgono già quelle tendenze dettate dalla nuova estetica dell’età severiana, descritta ad esempio dal Picard e dal Foucher; Di Vita riconosceva nei loro confronti un debito, pur non trascurando critiche e suggestioni. Allora si poteva accertare la distruzione alla metà del IV secolo in relazione al terremoto del 365 o alla scorreria degli Austuriani collocata da Ammiano Marcellino tra il 364 e il 366. E poi la parziale riutilizzazione. Ma l’aspetto più singolare è rappresentato dall’ampio, informato e documentato quadro di confronti con altre ville di Oea e di Leptis, come la villa del Nilo o quella di Dar Buc Annérea a Zliten.
Negli anni successivi Di Vita avrebbe puntualmente pubblicato altre rassegne, come quella sull’attività a Sabratha e a Leptis nel quadriennio 1976-79 uscita sui Quaderni del 1985: l’area sacro-funeraria pagana di Sidret el-Balik, l’acquedotto di Sabratha, il tophet di Ras el-Munfah con le sue 300 stele, i due mausolei con i blocchi originali del mausoleo B all’insaputa di Di Vita <<restaurati e sottoposti ad un assemblage non privo d’errori nel nuovo museo>>. E poi il catalogo delle 1080 lucerne di Leptis studiate dalla P. Procaccini, la fattoria di Umm Mbarka, i tre miliari di Sorman, uno dei quali – il più antico della Tipolitania – si data nell’età del proconsole A. Caecina Severus, dunque attorno al 10 d.C.
Nel 1997 una rassegna di sintesi è quella pubblicata nel volume del Ministero degli Esteri sulle Missioni archeologiche italiane, La ricerca archeologica, antropologica, etnologica, dove anch’io avevo presentato i primi risultati degli scavi di Uchi Maius: emerge tra tutti il tophet di Sabratha (monete studiate da Lorenza Ilia Manfredi) e l’area sacro-funeraria di Sidret el Balik, che definiva il più esteso e importante complesso pittorico del IV secolo ritrovato finora non solo in Africa ma nel mondo romanizzato o il più grande complesso di pitture di IV secolo mai trovato in Africa, con la spaventosa difficoltà di rialzare le pareti abbattute dal terremoto de 365; area salvata proprio prima che si costruisse la strada per la nuova città; inoltre il mosaico della basilica giustinianea. E insieme le critiche all’Unesco per il mancato intervento a Leptis dopo le alluvioni del 1987-88, il nuovo museo, il foro vecchio, studiato frontalmente nel volume pubblicato nel 2005 assieme a Monica Livadotti, con i tre templi dei dii patrii e di Roma e Augusto sui quali non ha nascosto il garbato dissenso con le posizioni di Nicolò Masturzo; ma per noi è quanto mai interessante il tentativo di sintesi per definire la lenta evoluzione delle classi dirigenti e della popolazione libica e punica, attraverso gli ordinamenti cittadini, i culti, la lingua parlata e scritta, verso l’impatto della romanità e i modelli romano-italici. Temi che percorrono tutta la produzione scientifica, facendo leva sull’iscrizione relativa a quel M. Vipsanius Clemens redem(p)tor marmorarius templi Liberi Patris pubblicata da Giacomo Guidi nel 1934, IRT 275, ritrovata nell’ambiente immediatamente ad ovest della cella, che lo portano a respingere l’ipotesi di un Campidoglio già in età augustea nel tempio di Liber Pater, mentre il “lealismo” si esprimeva nel vicino tempio ottastilo di Roma e Augusto studiato da Monica Livadotti e Giorgio Rocco ispirato al tempio del divo Cesare nel foro romano.
La dimensione storica dei suoi interventi è fortemente presente nell’articolo, pubblicato sui MEFRA del 1968 sulle influenze greche e tradizione orientale nell’arte punica della Tripolitania, che poggia su alcuni punti fermi: l’improvviso sviluppo delle città autonome della Tripolitania dopo Zama, divenute civitates liberae et immunes dopo la caduta di Giugurta; l’utilizzo della lingua punica, l’attività del tophet di Oea, gli stimoli greci e alessandrini sulle maestranze puniche che hanno costruito il mausoleo B di Sabratha sotto la guida di un vero artista; più ancora di un artista che visse e lavorò in una fase non tradizionalista dell’architettura ellenistica e in pieno clima barocco, elementi tutti ben leggibili dopo la difficile anastilosi; la precocissima consapevolezza di un contatto con i mausolei regali della Numidia, penso alle ultime scoperte algerine o – sull’altro lato del Mediterraneo – con la facciata del Khazné a Petra nel I secolo a.C., un tema rimasto in sordina ma ripreso nel 1989; e poi la scultura come nella stele di Ghadamès, nella statua di divinità di Leptis Magna, nelle teste di divinità provenienti dal Museo di Tripoli, nella statua di offerente da Sabrata e nella bizzarra testa di “Dioniso”, che affermano un antropoformismo sorprendente in ambito punico; infine la pittura. Il tema è quello dell’influenza di Alessandria sul mondo punico, dell’autonomia della Tripolitania da Cartagine, pure esposta alle influenze egiziane, culturali, religiose, artistiche; anche se inaccettabile gli sembra la posizione di quegli studiosi che denunciano presso i Cartaginesi un’incapacità quasi strutturale di produrre un’arte autonoma.
Al 1968 risale (su “Orientalia”) l’articolo che chiarisce la destinazione dei tre templi del lato nord ovest del foro vecchio leptitano: ben prima dell’età romana si veneravano due divinità virili, Shadrapa e Milk’Ashtart, sui quali si sarebbe prodotto il calco dei due dii patrii di Leptis, Liber Pater-Dioniso ed Ercole, affiancati da Astarte: l’aspetto davvero da sviluppare mi pare il fecondo contatto con il culto imperiale di Roma e Augusto, documentato già nell’8 a.C. con i flamines di antiche famiglie puniche addetti alle celebrazioni previste dal calendario ufficiale. Temi che si sarebbero sviluppati enormemente sotto Settimio Severo a Roma e in tutto l’impero con Caracalla, devoto di Libero e di Eracle negli anni della “ripresa cosmocratica”.
Al 1969 risale la presentazione di un disegno acquerellato settecentesco inedito dell’arco di Marco Aurelio e Lucio Vero a Tripoli, che è senza dubbio la più antica e attenta veduta dell’arco: un documento più eloquente e originale delle successive tavole di Ferdinand Hoefer con la nota Lemaitre direxit, di Mary Wortley Montague del 1816, di A. Baumeister del 1888, che appaiono <<di ricostruzione>>, non eseguite davanti al monumento. Pochi anni dopo, nel 1975 sui Quaderni, Di Vita discuteva con accenti critici la proposta di restituzione dell’arco dei Severi a Leptis Magna presentata da Giovanni Ioppolo e da Sandro Stucchi e pubblicava la ricostruzione di Carmelo Catanuso, che sarebbe stata alla base dei restauri che conosciamo. Non possiamo non condividere l’obiezione sulla collocazione e la pertinenza dell’epigrafe dedicata ad un imperatore Divus, il che obbligherebbe a immaginare che l’arco fu costruito dopo la morte di Settimio Severo o addirittura di Caracalla. Molto acute sembrano oggi le osservazioni, a valle del saggio di scavo di dieci anni prima, sulla collocazione del monumentale tetrapilo all’incrocio tra cardo e decumanus presso la porta Augusta salutaris, con l’evoluzione presentata a Tarragona nel 1993, interrompendo il percorso dei carri nel punto più centrale della colonia Ulpia Traiana Leptis a causa della presenza di tre gradinate interne; più discusso il tentativo di retrodatare di un secolo il monumento originario, forse di età traianea, realizzato nel bel calcare grigio delle cave di Ras el-Hammam, cavato fino a Marco Aurelio usando il braccio punico, mentre nel corso della fase severiana il monumento sarebbe stato sommerso dal marmo cavato utilizzando come unità di misura il piede romano. Stucchi ironizzava a sua volta sui Quaderni del 1976 sulla possibilità che l’arco fosse stato costruito solo per assicurare refrigerio ai passanti, “a scopo umbratile”; e Di Vita rispondeva l’anno dopo con un breve e fulminante intervento di 8 pagine, con l’intento di ristabilire una verità scientifica – scriveva – duramente maltrattata; la collocazione urbanistica dell’arco all’ingresso dalla strada Oea-Alessandria e la presenza dei gradini gli sembravano portare obbligatoriamente all’età della grande dinastia leptitana. C’è sullo sfondo la necessità di difendere Carmelo Catanuso, che aveva operato con piccole risorse, <<senza aver potuto mai fruire di nessuno dei mezzi cospicui di cui fruisce da anni lo Stucchi>>. Tutta la questione è ripresa sui Quaderni nel 2003, dove viene presentata la “filosofia e prassi del restauro”, con riferimento ai pannelli dei rilievi figurati trasferiti al museo di Tripoli e riprodotti in calco nei fornici (come l’assedio di città e le due scene di sacrificio), grazie all’impegno di un restauratore dell’Università di Urbino. Ho visto che i rapporti tra i due erano migliorati nel tempo, anche se Stucchi non aveva condiviso le posizioni di Di Vita sul foro severiano. Del resto ancora sul necrologio di Sandro Stucchi pubblicato sui Quaderni del 1992, Di Vita insisteva sulla dimensione “cirenaica” degli studi del collega urbinate, di cui riconosceva i meriti, l’originalità, l’ampiezza del contributo, partendo dalla positiva recensione sulla monografia sull’agorà di Cirene pubblicata nel 1965: <<non così felici né il restauro dell’arco di Settimio Severo a Leptis né gli studi leptitani dello Stucchi, alla cui cultura e preparazione la Tripolitania rimase sostanzialmente estranea>>. Come non apprezzare oggi questa sincerità senza limiti ? A distanza di oltre un decennio il tema del tetrapilo dei Severi di Leptis ritorna nel convegno de L’Africa Romana di Rabat del dicembre 2004 e ancora su Libya antiqua nel 2010: superate le polemiche, ora viene ricostruita la storia davvero complessa del restauro del monumento dalla spedizione di Federico Halberrr del 1910, allo scavo di Renato Bartoccini del 1923-24, di Giacomo Guidi (1930-31), di Sandro Stucchi (dal 1970 al 1992) e di Lidiano Bacchielli (1992-96), la cui prematura scomparsa ancora ci commuove: di lui conservo un ricordo prezioso, il suo soggiorno in Sardegna appena concluso il concorso che lo aveva portato in cattedra ad Urbino. Un sorriso aperto e leale, una grande gioia di vivere, una serie di progetti straordinari, nei quali pensava di coinvolgerci tutti. E un grande dolore per averlo perduto, che avevamo espresso nelle conclusioni del convegno cirenaico di Roma del dicembre 1996 promosso da Lidio Gasperini. Di Vita ricorda le lunghe interruzioni nel restauro dell’arco <<una delle maggiori imprese di restauro monumentale che dopo il 1951 abbiano avuto luogo in Tripolitania>>, i marmi arbitrariamente spartiti tra i musei di Tripoli e Leptis, i calchi dei rilievi storici, la nuova cupola in vetroresina, l’iscrizione collocata sulla fronte verso Tripoli che non è pertinente all’arco, ma non è stata rimossa in quanto preziosa testimonianza del pensiero dello Stucchi; rimane l’idea di un primo arco, traianeo, in calcare di Ras el Hamman sulla strada Cartagine-Alessandria. La complessa anastilosi completata tra il 1997 e il 2004 grazie all’impegno dell’équipe tecnica guidata da Gastone Buttarini dell’Università di Urbino, con l’ausilio di Paolo Frigerio e Mohammed Drughi, si è realizzata grazie al finanziamento di quasi mezzo milione di euro del Ministero degli Affari Esteri, del Murst e del CNR ed ha compreso la realizzazione della cupola centrale in vetroresina e la collocazione dei calchi dei pannelli figurati, realizzati in tempi diversi e dunque non sempre uniformi; infine le otto lesene angolari dell’ordine inferiore scolpite con girali animati e trofei è stata solo parzialmente felice. Solo sei su otto sono i pannelli superstiti con rilievi figurati a soggetto storico e allegorico, collocati negli incassi delle fronti interne dei piloni dell’arco, alcuni sicuramente sistemati dallo Stucchi in modo improprio, l’assedio di città (Seleucia per Ward Perkins), le divinità, i sacrifici, la acclamazione di Caracalla e Geta: niente di tutto ciò inficia il valore profondo dell’arco, con i quattro grandi rilievi che rappresentano due solenni parate militari, una scena di sacrificio, Settimio Severo e Caracalla che si stringono la mano davanti a Geta Cesare: emerge la propaganda di corte, la vita militare, la pietà religiosa, l’armonia e la concordia interna, il diritto alla successione dinastica.
Commentando il volume dell’Enciclopedia Classica del 1970 dedicato da Pietro Romanelli alla Topografia e archeologia dell’Africa romana, bilancio di un secolo intero di ricerche archeologiche, la nostra Bibbia di archeologia provinciale, Di Vita presenta un quadro davvero complesso di <<considerazioni, note segnalazioni>>, in realtà di critiche e di aggiornamenti che si estendono dalla Tripolitania a tutto il Maghreb, dimostrando insieme ammirazione per il Maestro ma anche piena libertà di discuterne metodi, categorie interpretative, cronologie, limiti in una documentazione che davvero è sterminata. Capitolo per capitolo emergono osservazioni sull’urbanistica, sulla colonizzazione italica che in Tripolitania sarebbe caratterizzata da uno stato di soggezione degli immigrati italici rispetto alle grandi famiglie locali; dunque il valore e la pervasività della cultura punica, i contatti con Alessandria, la necessità di inquadrare i dati di scavo nell’area della basilica e del foro severiani di Leptis con un progetto ben più grandioso, nel quale la basilica era concepita come asse di un complesso articolato su due ali contrapposte; progetto interrotto drammaticamente dalla morte di Caracalla. E poi gli edifici di spettacolo, come il teatro di Leptis d’impianto augusteo datato tra l’1 e il 2 d.C., l’anfiteatro di Sabratha, il circo di Leptis studiato da John Humphrey dell’Università del Michigan, le scholae per collegi come la casa di Bacco di Cuicul in Algeria, la biblioteca di Thamugadi, gli impianti produttivi, i frantoi, le vasche per salsamenta e l’estrazione della porpora, le figlinae, le ville, le fattorie fortificate, i mausolei, i monumenti funerari come le cupulae africane, le basiliche cristiane, i cimiteri. Tanti temi, tante curiosità, tanti stimoli, che lo portano ad interrogarsi sulle maestranze locali come quelle della spettacolare statua del flamen di età augustea Iddibal Caphada Aemilius, sugli artisti giunti da Afrodisia come nel Serapeo leptitano, da Alessandria (come i festoni e le ghirlande della tomba della Gorgone di Sabratha), da Cartagine, da Roma, come per i mosaici. Come si vede, Di Vita è ormai lontanissimo dalle posizioni del Romanelli che richiamava solo “modelli” e “forma di espressione” derivati dall’Oriente nell’arte della Tripolitania di Commodo e dei Severi, consapevole di una complessità di rapporti che riusciva ad aprire orizzonti nuovi.
Un deciso passo in avanti è rappresentato nel 1976 dalla pubblicazione sui MDAI Römische Abteilung dello studio monografico sul mausoleo punico-ellenistico B di Sabratha, dedicato secondo Colette Picard a quello che è il monumento punico più significativo conosciuto, interpretato come un segnacolo funerario numida a ridosso delle camere funerarie; segnacolo che alla fin fine è una sorta di stele del tipo nefesh (anima, persona), a breve distanza dal secondo mausoleo in gran parte perduto; lavoro arricchito ora in appendice in questo volume dagli straordinari acquarelli inediti di Carmelo Catanuso, anche se continua a mancare l’edizione definitiva dello scavo completa delle stratigrafie e dello studio dei materiali, in parte editi per le fasi più antiche da Benedetta Bessi nel 2009: costruito alla metà del II secolo a.C., il mausoleo era alto 46 braccia puniche, 23,65 m, si datava attorno al 180 a.C., perse il coronamento piramidale e la cuspide già prima del 60 a.C. e fu successivamente inglobato nella torre bizantina e nelle case vicine; l’anastilosi si rivelò complessa ma convincente: il nucleo centrale è rappresentato dalle tre metope che raffigurano il Bes domatore dei leoni a Est, Eracle che lotta contro il leone nemeo a Nord, i due personaggi a cavallo a Sud; si segnalano inoltre la falsa porta della fronte est, la principale, sormontata da un fregio con uréi, i disco solare, l’uso di semicolonne coronate da capitelli con fiori di loto, i leoni del secondo livello, le statue dei tre kouroi angolari (veri e propri geni funerari egittizzanti), i capitelli ionici a volute diagonali di sapore italico, i capitelli eolici, opera di un vero artista e di un artista che vive e lavora in pieno clima barocco nel medio ellenismo. Scontate le influenze egizie, il confronto più vicino (a parte il mausoleo A) è rappresentato da Beni-Rhenane presso Oran (tre volte più grande, veramente di proporzioni smisurate), scavato proprio nel 1964 da Gustave Vuillemot. Negli Atti del convegno del 1980 del CNR e EFR sull’Architettura fino al termine della repubblica, Di Vita si sarebbe spinto fino ad accettare che i due mausolei di Sabratha possano essere interpretati in qualche modo come <<il dilatamento puro e semplice di coeve basi di candelabri o delle basi di tripodi di età classica>>, con una pianta a triangolo dai vertici tagliati e dai lati ad arco di cerchio, dunque a pareti concave, con alto zoccolo a gradini, primo piano massiccio e secondo piano a lanterna, il tutto decorato con semicolonne ioniche al centro delle tre pareti e da tre quarti di colonne alle punte tronche.
Gli scavi effettuati tra il 1964 e 66, con limitati saggi di controllo nel 77, a Nord del Mausoleo punico ellenistico A di Sabratha sono presentati nel 1975 in Libya Antiqua, con molte novità, legate alla cronologia del più imponente mausoleo punico che poggia su una piattaforma di arenaria a forma di triangolo equilatero, segnacolo funerario, nefesh, datato ora al 180 a.C. circa, alla sua struttura, soprattutto alle cerimonie di fondazione documentate da un’olla in terracotta grezza e alle trasformazioni che possiamo seguire attraverso la ceramica, dalla sigillata chiara A, alle coppe in sigillata italica, alle anfore Dressel 7-11 di produzione spagnola per la salsa di pesce a partire dall’età di Augusto, dalla sigillata orientale ai bicchieri a pareti sottili della prima metà del I secolo d.C., alla terra sigillata D alle lucerne di importazione o tripolitane come quelle di Quartus o di A(gipu?)dargus, alle monete; gli aspetti principali sono rappresentati dall’apertura nella piattaforma del mausoleo fatta di grandi e talora immensi blocchi di arenaria di un pozzo, capace di captare una abbondante vena di acqua dolce a oltre 15 m. di profondità; la nuova cronologia dei crolli determinati da grandi sismi alla fine del II secolo a.C., al 65-70 d.C., al 306-310 e al 365, tutti avvenimenti che spesso hanno profondamente modificato l’urbanistica cittadina e l’orientamento stesso delle strade, in uno sforzo ricostruttivo che andò ben oltre l’area del mausoleo crollato. Le monete in particolare testimoniano la diffusione già negli ultimi decenni del III secolo di esemplari di radiati provenienti da zecche irregolari, clandestine o barbare locali relative alla consecratio (da parte di Quintillo) di Claudio il Gotico nel 270, fino agli esemplari di Costantino dalla zecca di Tessalonica o alla Felix temporum reparatio di Costanzo II.
Proprio ai terremoti del 306-310 e del 365 ma in Tunisia è dedicata la nota su “Antiquités Africanies” del 1980, con uno sforzo interpretativo che parte dalla stratigrafia, dal rifacimento dei pavimenti a mosaico come ad Hadrumetum, dalle costruzioni pubbliche nell’età di Valentiniano, Valente e Graziano a Sufetula, dalle opere edilizie di Thugga (un acquedotto), di Thuburbo Maius e di Cartagine, sempre in un contraddittorio con Louis Foucher, Alexandre Lézine, Gilbert Picard. Debbo dire che l’attività di Costantino e dei suoi successori a Cartagine in qualche caso andrebbe collegata forse opportunamente come a Cirta con i disordini successivi alla rivolta di Lucio Domizio Alessandro in Africa e in Sardegna contro Massenzio e con il successivo intervento di Costantino, ricordato espressamente nelle iscrizioni come ricostruttore di Cirta che per riconoscenza prese il nome di Constantina. Un’iscrizione recuperata da Azedine Bescaouch ad El Khandak (Abbir Maius) (AE 1975, 873), dedicata a Valentiniano Valente Gratiano durante il proconsolato di Petronius Claudius c(larissimus) v(ir) precisa che il curator rei publicae alm(a)e Kart(haginis) Flavianus Leontius oceanum a fundamentis coeptum et soliarem ruina conlapsum ad perfectionem cultumque perductos ingressus novos signis adpositis decoravit, ove l’espressione ruina sembra effettivamente indicare un crollo improvviso legato ad un terremoto negli anni precedenti. Al rapporto tra terremoti e urbanistica nelle città della Tripolitania è invece dedicato lo studio Sismi, urbanistica e cronologia assoluta, scritto alla fine degli anni 70, ma presentato a Roma nel 1987 in occasione del Convegno dell’EFR su L’Afrique dans l’Occident romain, al quale io presentai l’articolo dedicato alle Sirti nella letteratura di età augustea, con un capitolo sul rapporto tra Arae Philenorum e Arae Neptuniae: nella prima nota Di Vita racconta drammaticamente il mistero del furto del manoscritto del libro sui terremoti nel mondo romano che era quasi terminato nel 1975, quando il testo gli fu rubato presso via Giulia a Roma, anche se poi gli allievi dopo la morte sono riusciti a ritrovare alcuni capitoli incompleti in un vecchio armadio dell’Università di Macerata. L’ampio articolo dà comunque un’idea dell’orizzonte di una ricerca che istituiva confronti e spaziava in tutto il Mediterraneo, partendo da Sabratha, dai 5 terremoti documentati dal crollo dei mausolei, dagli scavi nell’Iseion e nel tempio del Liber Pater, dai reperti, dalle monete, tra il 100 a.C. e il 365 d.C., in particolare quelli dell’età di Nerone-Vespasiano (65-70), della seconda tetrarchia (306), del 21 luglio 365. A Leptis costituiscono documenti incontrovertibili dei crolli il Serapeo scavato già nel 1963 con la statua abbattuta di Marco Aurelio coperta da uno strato di fango che è veramente il simbolo dell’evento, l’edificio domizianeo costruito da L. Nonio Asprenate, il mercato, la c.d. schola, l’anfiteatro, il ninfeo curvilineo, le terme; il crollo della diga sull’ouadi Lebda avrebbe causato nel IV secolo una violenta inondazione che colpì l’abitato e le cui testimonianze più significative sono state rinvenute nelle terne adrianee, con questa massa di fango che investì le strutture evidentemente già pericolanti dopo i restauri del 306. A Oea il terremoto del 365 sembra documentato dai forni per ceramiche editi da Renato Bartoccini collocati all’interno delle mura e improvvisamente abbandonati, non certo in relazione all’attacco degli Austuriani, che non occuparono mai la città. Ma il terremoto avrebbe colpito Cipro, il Peloponneso, la Sicilia. La garbata polemica si allarga a François Jacques, a Claude Lepelley, a M. Blanchard-Lemée che comunque sul tema “terremoti” e “maremoti” nel Mediterraneo hanno assunto progressivamente una posizione sempre più aperta e disponibile. In questo campo il ruolo dei geologi è essenziale, anche se Di Vita rivendica il ruolo dell’archeologia e sostiene che sono le “scienze esatte” a dover cedere il passo all’evidenza documentaria. È Girolamo a parlarci nel Chronicon di un terremoto universale, terrae motus per totum orbem factum mare litus egreditur et Siciliae multarumque insularum urbes innumerabiles populos oppressere, così come Ammiano Marcellino che racconta come durante il primo consolato di Valentiniano e Valente, <<improvvisamente orrendi fenomeni si verificarono in tutto il mondo, quali non sono descritti né dalle leggende né dalle opere storiche degne di fede>>, horrendi terrores per omnes orbis ambitus grassati sunt subito, qualis nec fabulae nec veridicae nobis antiquitates esponunt. Più precisamente: <<Poco dopo il sorgere del giorno, preceduto da un gran numero di fulmini vibrati violentemente, un terremoto scosse tutta la stabilità della terra; il mare si disperse lontano e si ritirò volgendo indietro le onde>>. La descrizione di Ammiano prosegue con molta efficacia presentando gli effetti del terremoto e del maremoto, la morte di animali e di uomini, la distruzione di navi e di abitazioni nelle città e dovunque si trovassero, su isole e tratti di terraferma,
Infine Libanio nell’Epitafio per Giuliano (che sarebbe successivo al 365 d.C. e al maremoto suscitato da Poseidone), parla di un grande terremoto in Palestina, nella Libia tutta, nella Sicilia, nella Grecia e non solo, descrivendo la Terra-Oikoumene sconvolta per la morte dell’imperatore che come un cavallo infuriato scuote dalla sua groppa le città: un resoconto che Lepelley considerava esagerato, retorico, comunque poco attendibile.
Dalla parte di Di Vita si è schierato René Rebuffat, con i dati dello scavo di Cuicul, l’attuale Djemila in Algeria. Ho rivisto per l’occasione l’ampia documentazione epigrafica citata d Di Vita sull’utilizzo del termine ruina nelle epigrafi di Costantino e poi dei Valentiniani, con l’intervento di curatores rei publicae incaricati dal governo centrale di soccorrere le popolazioni come a Thibusicum Bure: non c’è dubbio che la documentazione è ancora più estesa di quella presentata da Di Vita e parte dalla basilica vetus di Leptis sotto Costantino (IRTrip. 467): cum basilica vetus ex maxima parte ruina esset deformata conlabsa ac spatio sui breviass[et ar]eam forensem [quae] divino (igne ?) icta conflagrarat incendio negli anni di [La]enatius Romulus, nel 317. E tracce dell’incendio sono rilevabili negli scavi. E poi il macellum di Leptis ancora con Costantino e Licinio (IRTrip. 468): quod inter cetera civitatis Lepcimagnensium moenia quae cum sui magnitudine et splendore concordant etiam porticuum macelli in ruina [la]bemque conversam remanere nudam… Ma il confronto si può estendere all’aedes Liberi Patris a Sabratha quam antiqua ruina cum lab[e] … servavit nell’età di Costanzo II e Costante (IRTrip. 55), alle terme di Sabrata durante il VI consolato di Valente e il II di Valentiniano nel 378 (IRTrip. 103), a Tubursicum Numidarum, al fanum dei Mercurii di Avitta Bidda, alle thermae aestivae di Madauros ed al teatro e alla cella balnearum; infine la citata iscrizione di Abbir Maius. Escluderei che il termine ruina di per sé rimandi a un terremoto. Come a Cornus in Sardegna dove attorno al 379 si restaurano le thermae aestivae in una terra che sappiamo poco soggetta ai sismi. Eppure mi scrivono di terremoti proprio in questi giorni Raimodo Zucca e Munir Fantar impegnati negli scavi sottomarini di Neapolis oggi Nabeul in Tunisia. Per loro, alla luce delle recenti indagini della VI missione a Nabeul oggi siamo sicuri di due cose:
1) c’è stato un sisma e una conseguente azione tettonica che ha fatto sprofondare in mare 1/3 della città di Neapolis. Mounir Fantar ricorda il passo arabo di El Bekri che nel XII secolo parla di “portoinghiottito di Neapolis” non di navi inghiottite. Bekri usa il termine marsa = porto. Il sisma ha fatto crollare gli edifici che sono stati sommersi.
2) l’evento sismico è avvenuto prima della riconversione del quartiere produttivo (per la produzione del garum) superstite in terra a Neapolis in quartiere residenziale con la Nymfarum (sic) domus e le altre lussuose abitazioni, poiché non abbiamo tracce di domus impostate sulle “usines de salaison” sommerse. La cronologia della costituzione nella parte terrestre superstite di Neapolis alla seconda metà del IV secolo d. C. è sicura. Ergo come ipotesi storica si può fare riferimento al sisma del 21 luglio 365 di Ammiano Marcellino e Girolamo.
Nonostante le severe critiche successive l’articolo di Di Vita sembra dunque assai solido e mi pare certo che almeno nel 365 violenti terremoti culminati in quello che generò il maremoto del 21 luglio squassarono davvero le terre del Mediterraneo centrale e orientale: si trattò di fenomeni di inusitata potenza e ampiezza e le fonti letterarie fra loro concordi ce ne danno testimonianza.
A partire dagli anni 80 Di Vita scrive alcune opere di sintesi di grandissimo rilievo sulla Tripolitania romana, come nel 1982 sul X,2 volume di Aufstieg und Niedergang der römischen Welt dedicato ad un profilo storico-istituzionale degli Emporia tra Massinissa e Diocleziano e aprendosi ad una riflessione storica davvero innovativa: le colonie puniche di Leptis, Sabratha e Oea dopo lo sfaldamento dell’epicrazia cartaginese a seguito della battaglia di Zama avrebbero acquistato per due secoli una piena autonomia, anche se probabilmente nel 161 a.C. Roma le avrebbe assegnate formalmente a Massinissa, in una condizione sostanzialmente di “vassalli periferici”, vicina ad una vera e propria indipendenza, tanto che vediamo nel 111 a.C. Leptis abbandonare Giugurta e stipulare un trattato di amicizia e di alleanza con Roma. E sappiamo che le città della Tripolitania ebbero il privilegio di battere moneta in bronzo e, Leptis, anche d’argento fino all’età di Giuba, quando si schierò dalla parte dei Pompeiani per dissesionem principum. Mi pare si possa concordare sul fatto che l’enorme multa in olio imposta da Cesare contro i Pompeiani d’Africa dopo Tapso nel 46 riguardò Leptis Magna e non Leptis Minor, per un totale di 3 milioni di libbre d’olio all’anno; ciò però non impedì ad Augusto di riconoscere se non una piena libertas ai tre porti tripolitani come supposto dal Grant sulla base delle monete del 12-8 a.C. con la testa di Augusto, almeno un’ampia autonomia, come dimostrato da L. Teusch e da B.D. Shaw, sulla base della rilettura della formula provinciae pliniana, le cui fonti rimanderebbero addirittura all’età di Cesare quando le tre città della Tripolitania – che non compaiono nell’elenco dei 30 oppida libera dell’Africa – dovevano essere ai margini del regno Numida, tanto indipendenti da battere moneta fino a Tiberio. L’idea di M. Christol e J. Gascou di un nuovo foedus stipulato tra Leptis e Roma è fondata sulla celebre iscrizione dedicata Marti Augusto dove la civitas Lepcitana ricorda che sotto gli auspici di Augusto e sotto il comando del proconsole Cosso Lentulo (ductu) provincia Africa bello Gaetulico liberata; ma in realtà non sarebbe realistica, perché il documento del 6 d.C. ricorda la libertas dell’intera provincia proconsolare e non della singola civitas; analoga prudenza si deve avere con le due basi dedicate alla Victoria Augusta dal proconsole Dolabella, occiso Tacfarinate. Ancora con Vespasiano le città della Tripolitania appaiono relativamente autonome se Oea nel conflitto con Leptis può chiamare in aiuto i Garamanti: uno dei mosaici della villa di Zliten ci ha conservato l’immagine dei Garamanti fatti prigionieri in quell’occasione dal legato della legione Valerio Festo e gettati alle fiere nell’anfiteatro neroniano di Leptis. In quegli anni il legato Settimio Flacco riuscì a raggiungere la Phazania, utilizzando quell’iter praeter caput saxi che è da identificare con la nuova via Tripoli-Mizda-Gheria el-Garbia, la più breve tra le vie carovaniere per Garama, sulla quale vediamo muoversi la spedizione commerciale di Giulio Materno, da Leptis arrivato fino all’Agisymba, nel paese degli Etiopi. Di Vita ritiene che tale relativa indipendenza delle città della Tripolitania abbia avuto concrete conseguenze anche sul piano artistico: un conservatorismo assai accentuato di città che non si sono mai sentite inserite a tutti gli effetti nel regno di Numidia e che hanno mantenuto integra la propria antica cultura punica, per quanto non siano mancati gli influssi da Roma, dalla Grecia, soprattutto da Alessandria. In questi anni il fortissimo rapporto tra Leptis e la domus dei Severi è radicato proprio nell’ambito della permanenza in profondità della cultura punica, come già osservato da Stazio nelle Silvae (IV,5) per il nonno di Settimio Severo; l’imperatore, che praticava l’astrologia uti plerique Afrorum (HA Geta 2,6), continuò a parlare il punico (o almeno ad avere un accento punico) fin da vecchio: Afrum quiddam usque ad senectutem sonans (vd. Epitome de Caesaribus: punica eloquentia promptior) ed è noto che la sorella fu fatta tornare a Leptis perché ignorava totalmente il latino.
Leptis, che probabilmente nel 202, in occasione del reditus dei Severi in urbem [s]uam, ottenne l’eccezionale concessione dello Ius Italicum, con concreti contenuti economici, fu una delle poche città del Nord Africa, in cui fosse costruito ex novo un intero foro per volontà dei Severi: non è il caso di ricordare i celeberrimi monumenti del forum novum Severianum, la basilica che Severo coepit et ex maiore parte perfecit, il tempio, la strada colonnata, l’arco quadrifronte, opere di radicale trasformazione urbanistica che spiegano forse gli epiteti, portati a partire dai primi anni del III secolo, di Septimia riferito alla colonia e di Septimiani ai Lepcitani, grati ob eximiam ac divinam in se indulgentiam, ob cael[est]em in se indulgentiam eius, pro continua indulgentia eius ed ob publicam et in se privatam pietatem. Conosciamo le curie Severa Augusta, Pia Severiana e Severa Ulpia. Già Procopio ricordava le grandi fabbriche erette da Settimio Severo a Leptis, ta Basileia, che considerava mnemeia tes eudaimonias: da qui la riconoscenza della città e la venerazione per Severo divus. Con la nascita della Regio Tripolitana, circoscrizione della res privata sorta per la gestione dei latifondi che la gens Septimia possedeva da tempo, l’area si avviava verso una nuova forma di autonomia che sarebbe stata riconosciuta da Diocleziano con la nascita della nuova provincia; Leptis diventava la capitale di un territorio più vasto, confinante con il tractus Biz[acenus]. Del resto, più che a Settimio Severo, l’espansione sul limes tripolitano sotto i Severi è attribuito da M. Euzennat a Plauziano e ad una consorteria africana a lui legata, anche se l’avanzamento della legione fino a Gheria el-Gharbia, Gheria es-Scerghia, Bu Ngem e Ghadamés prosegue oltre l’età di Caracalla ed è documentata fino ai Filippi.
Di Vita sottolinea l’importanza dell’attestazione tiburtina di un curator rei publicae … Tripolitanorum e, alla fine del III secolo, di un cur(ator) reip(ublicae) reg(ionis) Tripolitanae, che farebbe pensare ad una vera e propria confederazione delle città più importanti della regione, che si sarebbero staccate dal concilium provinciale di Cartagine per le celebrazione del culto imperiale, ben prima della nascita della provincia dioclezianea nel 303.
Un capitolo di sintesi è quello relativo agli ordinamenti, alle istituzioni e alle magistrature civili, in relazione alle permanenze puniche nelle civitates della Tripolitania, popolo, decurioni, senato, sufeti, forse un rab (da tradurre in latino con quaestor) e i mahazim (gli aediles). Al linguaggio punico si richiamerebbero anche le magniloquenti espressioni di tante iscrizioni tripolitane, come ornator patriae, amator patriae, amator civium, amator concordiae ecc.
Superata la fase della civitas libera e forse foederata, con la costituzione sotto i Flavi del municipium di diritto latino (tra il 72 e il 78 d.C.), Leptis mantenne eccezionalmente la magistratura dei sufeti, ricoperta ad esempio dall’avo di Settimio Severo; Di Vita, pur con qualche distinguo, segue la nota posizione di H.E. Herzig e immagina due fasi nella nascita della colonia Ulpia Traiana fidelis: la prima con Traiano già nel 109, quando il nonno dell’imperatore L. Septimius Severus, fu praef(ectus) publ(ice) creatus cum primum civitas Romana adacta est,quando per la prima volta fu introdotta a Leptis la cittadinanza romana; l’espressione ricorre quasi alla lettera in un passo dell’Historia Augusta (Sev. I,2), dove si riferiscono le origini della famiglia dell’imperatore: maiores equites Romani ante civitatem omnibus datam. Solo successivamente Settimio Severo concesse nel 201 lo ius italicum e la colonia fu ripartita in 11 curie, che eressero nel teatro le statue dell’imperatore e di tutti i Severi. Tutte le tappe del complesso percorso istituzionale sono accompagnate da interventi edilizi e da profonde trasformazioni urbanistiche che partono dall’area del foro vecchio e dall’età augustea (mercato, teatro, calcidico, via trionfale).
Sabratha, sulla base della denominazione delle curie Hadriana e Faustina, sarebbe diventata municipio durante l’età di Antonino Pio; e poi colonia solo con Marco Aurelio, in contemporanea con Oea, dove conosciamo un duoviro nel 163 e dove ci è conservato il tempio dedicato al Genio della colonia prima del 183. A Sabratha l’amator patriae C. Anicius Fronto è onorato dalla colonia dopo la questura, l’edilità, il duovirato, perché designato al duovirato quinquennale.
Il capitolo dedicato ai culti e agli uffici di carattere sacrale mette in evidenza nuovamente il conservatorismo questa volta in campo religioso, con la persistente vitalità delle tradizioni puniche e libico-puniche, che si manifestano a Leptis attraverso il ruolo delle due divinità poliadi, Shadrapa, interpretato come Libero, e Milk’ashtart, interpretato come Ercole, titolari dei due principali templi del foro vecchio, il primo costruito in arenaria nel momento stesso in cui era nato il foro, il secondo che conosciamo nel rifacimento di età augustea in calcare; in realtà in un angolo del foro fu costruito già nel 5 d.C. durante il proconsolato di Cn. Calpurnio Pisone un terzo tempio proprio per ospitare Milk’ashtart, visto che il tempio precedente a giudizio di Di Vita fu completamente rifatto nel calcare di Ras el Hammam per ospitare il culto di Roma e di Augusto, poi dopo Tiberio con la dedica delle statue di tutta la famiglia imperiale. Sorprende la precocità delle testimonianze del culto imperiale nella città federata, poiché già nell’8 a.C. conosciamo due flamines di Augusto Cesare, Iddibal figlio di Aris e Abdmelquart figlio di Hannobal: a quella data già da diversi decenni l’impianto urbanistico per strigas di Leptis appare definito in rapporto alla strada Cartagine-Alessandria, con il mercato, il teatro, il calcidico voluto dal flamen Iddibal Caphada Aemilius nel 12 d.C. Appare accertato che il piano originario del foro vecchio prevedesse due templi gemelli e non tre; che i tre templi erano già costruiti nei primi decenni dell’era volgare, dopo il rifacimento del tempio di Milk’ashtart, che originariamente doveva essere in calcare. Il rilievo dato al culto imperiale nella sola Leptis è evidentissimo, proprio in relazione alla sua precocità, al cambio di destinazione per il tempio originario ma soprattutto per il fatto che a portare il titolo di flamines (tradotto nelle iscrizioni puniche in zubehim, i “sacrificatori”) sono i più alti esponenti dell’aristocrazia punica locale, che talora appaiono eponimi come i sufeti, spesso organizzati in un collegio di XVviri sacr(orum), eredità di un analogo collegio punico; uno di loro nell’età di Claudio costruì un tempietto nella corte della porticus post scaenam del teatro, per celebrare la divinizzazione di Livia. Altri esercitarono il flaminato di Tiberio vivente, dei divi Claudio e Vespasiano, mentre sempre a Leptis è documentata la dedica di età adrianea Antinoo deo Frugifero. Ancora una volta è però con i Severi che il culto per la domus divina esplode a Leptis oppure a Gheria el-Gharbia con Caracalla nel più grande dei forti costruiti dalla legione al piede dell’Hamada el Hamra. Flamines annui, flamines e flamines perpetui sopravvivono ancora nel IV secolo, quando finiscono con l’assumere una funzione più politico-ammninistrtiva che religiosa; a livello provinciale a partire da Traiano il titolo documentato è quello di sacerdos (e sacerdotalis) provinciae Africae, con un’evoluzione successiva al distacco della Tripolitania dal concilium di Catagine. Resta da dire del praefectus omnium sacrorum che arriva al IV secolo e che pare la traduzione dal punico addir’azarim. Insomma il tema è quello, che paradossalmente si estende anche alla sfera del culto imperiale, delle origini puniche di sacerdozi che forse continuano antiche tradizioni libiche e numide. Dobbiamo necessariamente sintetizzare il tema del ruolo dei proconsoli d’Africa in Tripolitania, del loro conflittuale rapporto con i legati legionis III Augustae, delle circoscrizioni degli altri legati del proconsole, dell’attività del procurator provinciae Africae che rappresentava gli interessi del principe in una provincia senatoria. Ma l’amministrazione comprendeva anche il procurator ad IIII publica Africae (portorium, XX heditatium, XX libertatis, XXV rerum venalium mancipiorum), i procuratores patrimonii, privatae rationis, fisci, con gerarchie e competenze territoriali distinte.
Capisco le esitazioni sulla cronologia intorno alla nascita della Regio Tripolitana ben documentata a Theveste sotto due Augusti, uno dei quali damnatus, circoscrizione della res privata sorta per la gestione dei latifondi che la gens Septimia possedeva da tempo, dopo le confische subite nel 197 dai partigiani di Clodio Albino, originario di Hadrumetum, e dopo l’istituzione di un apposito proc. ad bona cogenda in Africa. Una riorganizzazione della res privata del Severi avvenne sicuramente alla morte di Plauziano, quando fu istituita la procuratela ad bona Plautiani cogenda, che in Africa fu affidata a Macrino, il futuro imperatore, anch’egli di origine africana e più precisamente maura; ebbe nuovo impulso la politica annonaria del principe, con distribuzioni gratuite e giornaliere di olio alla plebe; del resto conosciamo a Roma un proc(urator) ad olea comparand(a) [per re]gionem Tripolit(anam) sessagenario, un ufficio creato sicuramente da Settimio Severo con sede a Leptis.
Dobbiamo ovviamente sorvolare sugli altri funzionari finanziari e sulle cariche militari che riguardavano dogane, commerci, difesa del limes (praepositi limitis), ecc. Quel che è certo è che la Tripolitania espresse un altissimo numero di procuratori imperiali, senatori, cavalieri, giudici delle 5 decurie, curatores civitatis, patroni, ecc. La nota in appendice sul commercio transahariano è utilissima per definire le vie di penetrazione verso il Fezzan, il Ciad e la Nubia, i prodotti trasportati, polvere d’oro, schiavi, animali esotici.
Nonostante l’evidente subordinazione al culto imperiale, il culto delle divinità poliadi Eracle e Dioniso ebbe uno straordinario successo, testimoniato dal ciclo scultoreo della basilica severiana. Il genius coloniae compare a Leptis, a Oea (dove erano venerati Apollo-Rashef e Athena-Tanit), a Sabratha, dove conosciamo i templi di Eracle e Libero, quest’ultimo restaurato ancora alla metà del IV secolo. Il tema ricorrente è sempre quello della contaminazione e dell’interpretatio delle divinità puniche, come la Tanit-Caelestis e Ba’al Hammon-Saturno spesso presso i tofet tripolitani, divinità ben distinte ad esempio a Bou Ngem dall’Ammone egiziano-Zeus-Iuppiter venerato a Gholaia nel tempio documentato nel 205. Possiamo chiudere con i culti nati in ambito ellenistico di Serapide ed Iside, come a Sabratha, dove Apuleio forse nel 158 tenne il discorso sulla magia nel processo davanti al proconsole Claudio Massimo intentatogli dal figlio di Pudentilla Sicinio Pudente: nelle Metamorfosi Apuleio racconta il sogno alla vigilia del 5 marzo, per la festa del “navigium Isidis”, in cui un battello con la statua della dea veniva portato a mare su un carro. Era la prima nave che partiva nella nuova stagione. Si credeva che la dea camminasse su questo battello ed aprisse ella stessa il periodo di navigazione. Il carro navale era accompagnato da una sfilata di maschere, i “misti” di Iside, travestiti da soldati o gladiatori al servizio della dea. Quando avevano realizzato il loro voto, si toglievano la maschera, indossando la bianca veste dei seguaci di Iside. Il sommo sacerdote reggeva in mano una corona di rose, la pianta sacra a Iside, che durante la processione in sogno veniva offerta a Lucio-asino. Sostenuto dalla forza prodigiosa della dea, Lucio finisce per riacquistare l’aspetto umano e si affida a Iside-Providentia, per andare verso la “renovatio” interiore. Temi tutti che rimandano alle più antiche tradizioni marinare, giunte in Tripolitania da Alessadria; la collocazione stessa del tempio di Iside a Sabratha è più eloquente di qualunque discorso; del resto di matrice alessandrina appaiono i culti dionisicaco-isiaco-alessandrini della tomba n. 1 di Zanzur (il villaggio a ovest di Tripoli) scoperta nel 1959 e quella del defunto eroizzato, poco fuori l’anfiteatro di Sabratha, sulla via per Oea, databili forse nell’età di Claudio, come dimostrato nei diversi articoli pubblicati fino al 2011, il principale dei quali è quello sui Comptes rendus de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres del 2008, che racconta anche il retroscena del mancato distacco della tomba di Zanzur (destinata al Museo di Tripoli) deciso da Abdulaziz Gibril interrotto dalla rivoluzione del I settembre 1969, con la realizzazione di un piccolo museo sul posto voluta da Awad Saddawija.
A Sabratha l’eccellente Marcius figlio del nobile (anziano) MNTLK, il princeps, nella traduzione di Giovanni Garbini che aderendo ai misteri dionisiaci <<aborrì il peccato, amò la mansuetudine>>; ormai cittadino romano, dopo il proconsolato di Q. Marcio Barea del 43 d.C., compare isolato ma scortato da un giovane armato lancia nell’atto del banchettare, sdraiato sulla kline, con il piede destro in una posizione davvero caratteristica che fa pensare ad un mystés o a un bacchos eroizzato, fiducioso nel destino ultraterreno promesso da Milk’ashtart-Liber Pater-Dioniso, nell’ambito del culto orfico o dionisiaco di origine alessandrina; dunque un banchettante isolato con una sua profonda dignità alla maniera dei sovrani orientali o degli aristocratici eroi della Grecia; sua moglie di nome Ala, una domina, appare come lui una libica “eccellente”, con il busto privo di braccia secondo una lontana tradizione punica, che però ricorda l’Euridice delle Metamorfosi di Ovidio, che si vorrebbe risuscitare grazie alla forza morale di Orfeo.
È proprio in età proto imperiale che Di Vita individua in una splendida sintesi gli elementi culturali alessandrini a Sabratha, nell’articolo del 1984 degli Studi in onore di Achille Adriani: la tomba della Gorgone, con le nicchie per le Hydriai contenenti le ceneri dei defunti e il bancone con incavi per effettuare le libagioni o le offerte votive, in un clima che è insieme espressione dell’arcaismo greco e dello stile punico, specie nell’espressione dei Gorgoneia di gusto “orrido” che digrignano mostrando lunghissimi denti, che si ritrovano nella tomba del defunto eroizzato, accompagnato da una Gorgone personale.
Il defunto rappresentato sulla tomba di Zanzur scoperta nel 1959 e mal restaurata (ma si vedano le successive sempre più ampie riflessioni di Mainz nel 2001, Parigi 2008, Selinunte 2011) appartiene ad una fascia sociale più alta, è rappresentato in posizione ieratica con un caratteristico copricapo cilindrico nell’atto di bruciare incenso su un thymiaterion punico, mentre sullo sfondo si presentano parenti e servi che attraversano la riviera infernale sulla barca di Caronte (mi pare una cumba come quella dell’arco costantiniano di Cherchel) e che con lui, presentati da Hermes psicopompo, raggiungono Hades e Persefone divinità infernali assistite da due personaggi femminili dalla caratteristica capigliatura, con tavoletta di cera e collana di perle bianche, nel verde dei campi elisi con alberi, in basso bovini, orsi, cervi, gazzelle, cani, dai quali (così come dai suoi parenti) il defunto proprietario della tomba prende congedo; sulla volta: rose, una grande ghirlanda con maschera di Gorgone e amorini agli angoli di grande eleganza decorativa; il protagonista è però Eracle con leonté rappresentato con barba e baffi che trascina Cerbero tricorpore dall’Ade, e riporta sulle braccia verso la luce Teseo svenuto: si tratta dunque di un punico ellenizzato, un cittadino raffinato della vicina Oea, come testimonia la tipica immobilità dei visi delle figure, secondo la tradizione punica, con i grandi occhi chiusi da un profondo cerchio d’ombra. Per molti aspetti i confronti con l’affresco di Dura Europos e le sculture di Palmira rimandano alle assonanze tra mondo siriaco e mondo punico di età ellenistico-romana, con una ascendenza semitica comune. Il fregio animale, la decorazione del soffitto, le teste dei personaggi, la rappresentazione del defunto senza legami con lo spazio raccontano di un pittore pienamente punico; viceversa l’idea della narrazione continua, certi elementi tipologici (come Eracle) e stilistici (l’impressionismo del trattamento delle figure e degli alberi) implicano degli imprestiti dal mondo figurativo ellenistico.
I protagonisti di questi cicli pittorici sembrano tutti esponenti, come il “miliardario”, il flamen Iddibal Caphada Aemilius costruttore del calcidico di Leptis dedicato al numen imperiale alla fine dell’età augustea, di un’aristocrazia che prendeva a suo carico l’enorme spesa degli edifici destinati alla vita comunitaria delle città e che in cambio si attendeva più grande prestigio ed accresciuta autorità sui concittadini. Il passaggio dall’ellenismo alla romanizzazione riguarda in questa fase solo l’élite cittadina, coloro che, in dimensioni differenti, possedevano ricchezza, cultura, potere comune, anche se si riconoscevano pienamente (ancora nel I secolo d..C.) nella coscienza di un’origine punica comune.
Per i 150 anni dell’Istituto Archeologico Germanico di Roma Di Vita tornava nel 1982 sul progetto originario del Forum Novum Severianum e ricostruiva i risultati dello scavo avviato 25 anni prima da Renato Bartoccini con lo scopo di dimostrare l’esistenza, in fase progettuale, di un secondo foro a est del fianco orientale colonnato della basilica, in modo da ipotizzare un complesso articolato su due ali equivalenti e contrapposte, la seconda delle quali peraltro non venne mai realizzata, anche se rimane la vasta platea in conglomerato cementizio profonda 70 cm. Il tema è delicato, in rapporto all’iscrizione monumentale scolpita su una parete della basilica presso l’abside sud-orientale, che ripete come all’interno della basilica che Settimio Severo coepit et ex maiore parte perfecit e Caracalla completò l’opera del padre nel 216: perfici curavit. Espressioni che contrastano con l’ipotesi di Di Vita che la morte di Caracalla abbia interrotto il cantiere rimasto incompiuto per la seconda piazza forense, con una lacuna sul lato della basilica più lontano dal tempio della gens Septimia. Il punto focale dell’intero foro non sarebbe dovuto essere dunque il tempio severiano come oggi i visitatori ritengono, ma proprio la basilica (92 m x 38 m), che con le sue facciate lunghe colonnate avrebbe costituito la spina, il fulcro, il perno di due ali equivalenti; il che avrebbe consentito di ruotare parzialmente l’asse del complesso con l’area del foro ribaltata ad oriente in rapporto con la via colonnata lungo l’uadi Lebdah, alla quale aderivano i due gruppi di 7 tabernae che fiancheggiano l’ingresso principale alla piazza. Gli allineamenti, le visuali ottiche e gli accessi del foro severiano (132 m x 87 m) nella ricostruzione del progetto originario si debbono a Giovanni Ioppolo, con costante riferimento ai moduli vitruviani, evidenti nei 32 intercolumni del lato lungo della piazza scanditi dalle colonne di granito rosa di Aswan, poi prelevate e perdute. Ho riletto le osservazioni di Johnm Brian Ward Perkins, che non riteneva valida la ricostruzione dell’originario progetto del foro severiano (piazza-basilica-piazza), seguito da Sandro Stucchi, per il quale andrebbe categoricamente smentita l’affermazione di Di Vita che le pareti laterali alle absidi siano state costruite prima delle pareti lunghe perimetrali; all’uno e all’altro Di Vita credo abbia dimostrato nel dettaglio la scalpellatura degli archivolti della basilica verso il foro e molti elementi costruttivi come le grappe sulle pareti.
L’uscita nel 1987 dei due volumi di Giacomo Caputo nelle Monografie di Archeologia libica (III) dedicati al teatro di Leptis Magna, nel 1990 è l’occasione per ritornare sul “Journal of Roman Studies”, su “Gnomon” e sugli “Annali di Macerata” sui numerosi problemi posti dall’affrettata ma fondamentale edizione del monumento, forse il teatro più antico dell’Africa Romana, caratteristico per il suo tamburo chiuso ed eccezionale per l’attestata e datata presenza del tempio di Cerere in summa cavea, studiato assieme a Omar Mahgiub, Antonio Chighine e Raffaello Madaro in Libya Antiqua del 1976-77. Anche polemizzando con la severa recensione di H. Dodge, Di Vita ricostruisce la storia del monumento seguendo la stratigrafia, dunque rovesciando la cronologia: le fasi tarde, gli “avanzi bizantini”, l’abitato tardo-antico, il terremoto del 365, l’età dei Severi con il rivestimento musivo della cornice del portico di coronamento della cavea, il nuovo volto marmoreo sotto Antonino Pio durante il proconsolato di L. Hedius Lollianus Avitus con il rinnovamento della fronte scena e la mamorizzazione della porticus post scenam, l’età traianea e flavia con la nascita della colonia, le strutture originarie del teatro augusteo, che fu inaugurato tra l’1 e il 2 d.C., dono del più ricco leptitano del momento, Annobal Rufus. Di Vita ritiene sostanzialmente accettabile la grande impresa di Caputo del restauro, anche se discute la fronte scena e in particolare la mancata anastilosi del secondo e del terzo ordine. Ma è soprattutto l’iscrizione relativa al proscaenium columnis et marmoribus (a. 157, proconsolato di L. Hedio Rufo Lolliano Avito, legazione di C. Vibio Gallione Claudio Severo vd. IRTrip. 533) che ora, con l’aiuto certamente di Lidio Gasperini e Antonio Chighine, può essere corretta con riferimento alle nicchie (lacunae) planimetricamente presenti già nel teatro augusteo.
Un tema di grande interesse e relativamente autonomo all’interno di questi volumi è quello presentato nel novembre 1996 a S. Maria Capua Vetere sul tema Irregimentazione delle acque e trasformazione del paesaggio, intitolato acqua e società nel prede serto tripolitano, che parte dalla piena dell’Uadi Megenin alla periferia occidentale di Tripoli nel 1982: dunque il tema delle alluvioni causate all’interno del sito archeologico di Leptis dall’uadi Lebda, l’uadi Caam (il Cynips dei greci della spedizione di Dorieo), l’uadi Soffegin e lo uyadi Zemzem, i bacini di raccolta, la fertilità delle vallate fluviali sulla costa oltre che nelle oasi fino a Cidamus-Ghadamés, e poi il predeserto con le fattorie, gli agglomerati difesi, castelli, forti del limes, mausolei spesso a guglia, i ben noti senam: tutte strutture che avevano necessità di una “piccola idraulica” presso i gasr. Le esplorazioni di G. Barker, D. Gilbertson, B. Jones e D. Mattingly venivano pubblicate proprio nel 1996 nell’ambito di quello che ha definito la <<poderosa e metodica operazione di survey del predeserto>> nell’ambito del progetto “Unesco Libyan Valleys Surveys” con preziose osservazioni sulle tecniche di adduzione delle acque nella regione del pre-deserto, sottolineando una continuità fra mondo pre-romano, romano, bizantino, aglabide, in alcuni casi sino ai giorni nostri, con risultati straordinari che rendono giustizia a un mondo tutt’altro che sottosviluppato e al contrario capace di produrre del surplus per il commercio con i centri urbani della costa. Ne abbiamo parlato (con Antonio Ibba) recentemente a Djerba, ricordando come la popolazione sedentaria pratichi l’arboricoltura grazie a metodi di irrigazione molto particolari che attingono l’acqua non tanto dalle rarissime fonti ma grazie a terrazze o sbarramenti (jessour) che controllano e incanalano le acque alluvionali o degli oueds Merteba, Seradou, El Hamma (Ben Ouezdou). Strutture simili sono state individuate in Libia, nella Tunisia sud-orientale nella piana di Augarmi, fra Feriana e Kasserine nella regione delle Alte Steppe. Spesso gli archeologi le hanno confuse con le clausurae, sbarramenti lineari lungo le piste in cui si spostavano in antico uomini, armenti e merci, destinati a regolare i flussi piuttosto che a difendere o chiudere ermeticamente il territorio provinciale. Proprio ad una clausura costiera di Sabratha è dedicato l’articolo del Convegno de L’Africa Romana di Tozeur del 2002, in questo volume con fotografie originali che documentano il progressivo degrado dell’area archeologica in rapporto alla costruzione di un ospedale e di un ristorante che sono andati a insistere sul tophet, sulle latomie, sul porto e sul faro.
Il bilancio sulle città della Tripolitania si arricchisce nel 1998 nell’articolo su Sabratha, ora tradotto dal francese, ma originariamente pubblicato anche in tedesco: ne scaturisce un affresco a tutto tondo della città ellenistica con un tessuto urbanistico organizzato per strigas, che orienta la collocazione dei templi e dei monumenti nei diversi isolati, la prima città romana distrutta da un primo terremoto tra il 65 e il 70 tra Nerone e Vespasiano: il teatro, il foro, la basilica giudiziaria, le vaste latomie; infine la città monumentale dagli Antonini ai Severi, municipio promosso a colonia da Antonino Pio, con il tempio di Liber Pater nel foro con le sue caratteristiche colonne di granito grigio della Misia, la fontana di Flavius Tullus, lo spettacolare tempio Antoniniano dedicato dopo il 166 a Marco Aurelio e Lucio Vero, la curia poi trasformata in battistero, il tempio a divinità ignota dedicato ad Ercole erede di Melqart, la decorazione scultorea del proscenium del teatro, l’anfiteatro per combattimenti gladiatori di inizio III secolo con la quadriga di C. Flavius Pudens, una seconda quadriga, quella del monumento di Settimio Severo nel 202, il porto, il faro. Tutti elementi che vengono sincronizzati con le citazioni dei Sabratenses ex Africa a Roma per la dedica della statua di Sabina e con la statio Sabratesium del Piazzale severiano delle corporazioni di Ostia. Segue un capitolo sui terremoti del IV secolo, le ricostruzioni come della basilica giudiziaria, l’utilizzo come depositi di emergenza di statue monumenti delle favissae del Capitolium. Infine dalla città cristiana alla fortezza di Giustiniano si pone il tema dei complessi episcopali, della presenza dei donatisti, il nuovo battistero, la ricostruzione sulle rovine, le mura, le fortificazioni, le torri angolari, la basilica bizantina ricostruita dentro il museo, le abitazioni, la presenza araba.
Una sintesi sui risultati della lunga missione archeologica a Leptis Magna e Sabratha è pubblicata nel 2002 su “Il dialogo interculturale nel Mediterraneo, la collaborazione italo-libica in campo archeologico”, dove Di Vita ricorda i lunghi 39 anni di presenza in Libia partendo dal 1962, da ultimo in qualità di consigliere scientifico dell’Unesco al momento della realizzazione del nuovo museo di Tripoli, fondatore di Libya Antiqua assieme ad Aissa S. Laswed e Richard Goodchild nel 1963, che si è continuata a stampare in Italia, decano di tutte le missioni archeologiche in attività in tutte e tre le regioni della Jamahirija.
Al 1971 risale la scoperta dell’area sacro-funeraria pagana di Sidret el Balik immediatamente a Sud di Sabratha, che però fu presentata in maniera adeguata solo sui Rendiconti della Pontificia Romana di Archeologia del 1980-81 e in varie altre occasioni fino al 2011 (nel 2007 per l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres): si tratta di un complesso funerario pagano collocato in una cava d’argilla abbandonata costituito da un ingresso, un sacello con due altari, un ampio vestibolo, con ad oriente un vasto spazio a cielo aperto, quattro caratteristici triclinia sigmoidali o stibadia, le esedre e le mensae, con una grande vasca addossata alla parete meridionale. Ancora una volta le strutture del I-II secolo appaiono danneggiate dal terremoto del 306-310, parzialmente ristrutturate nei decenni successivi, comunque prima del terremoto del 365, con un’area di riunione per i pasti funebri connessa ai parentalia; il refrigerium è il pasto commemorativo presso le sepolture, una pratica antica e radicata in Africa e nella Tripolitania di IV secolo, all’alba dell’a tarda antichità; ci appare viva sia presso i pagani (come appunto a Sidret el Balik) quanto presso i cristiani (il più modesto ipogeo di Adamo ed Eva a Gargaresc nei sobborghi occidentali di Oea). Si potrebbe pensare, anche attraverso lo spettacolare affresco (<<le cycle pictural le plus vaste et le plus important jamais découvert et Afrique romaine et (….) l’un des plus entendus de tout l’Empire>>), con animali selvatici e domestici, cacciatori, scene di caccia e altre scene agresti (che ricordano le pitture con scende di caccia del frigidarium delle terne dei cacciatori di Lepts), grappoli d’uva e spighe di grano, ma anche vedute di edifici, ad un paradeisos (amorini, pavoni sotto una pergola come nel mosaico di Cherchell) con riferimento a vere e proprie eterìe, curie, associazioni attive e potenti che avevano l’abitudine di assumere pasti comuni, veri e propri collegi funeratici (almeno 32 persone) che potrebbero esser rimasti pienamente attivi nei decenni successivi alla pace costantiniana: motivi tutti che rimandano all’antico repertorio alessandrino ma con elementi comuni ai mosaici africani.
Al IX Congresso internazionale di archeologia cristiana svoltosi a Roma nel 1975 Di Vita presentò l’ipogeo di Adamo ed Eva a Gargaresc, uno dei sobborghi occidentali di Tripoli, studiato a partire dal 1965 all’interno delle labirintiche cave di arenaria abbandonate: a parte la camera funeraria di Aelia Arisuth pubblicata cinquanta anni prima da Romanelli, ora emergono le figure di Adamo ed Eva (con acconciatura ad elmo) tentati dal serpente e la rara immagine forse dell’ingresso di Gesù su un asino in Gerusalemme o più probabilmente del profeta Balaam, con lampadofori entro nicchie, prototipi di miniature pergamenacee; nella parete occidentale rimangono molto danneggiati frammenti di un episodio cui assistono tre personaggi, dominus, domina e ancella, sovrastati da una lunga iscrizione dipinta poco leggibile; nel complesso espressioni di arte popolare, che si confronta con le catacombe romane, con i mosaici di Piazza Armerina, con altre pitture tripolitane ed ora a Turris Libisonis. I dati antiquari, iconografici e stilistici ci poterebbero al secondo venticinquennio nel IV secolo, prima del terremoto del 365; di grande interesse la lunghissima iscrizione latina corsiveggiante, solo parzialmente interpretata, che potrebbe conservare il ricordo del rito del battesimo, un estratto dagli acta di un martire sottoposto a supplizio in una piscina calcaria. Il materiale rinvenuto nell’ipogeo, soprattutto orci ed anfore africane, rimandano al rito funerario cristiano dei refrigeria.
In questo volume ricorrono tanti temi diversi: uno degli ultimi lavori, presentato da Maria Antonietta Rizzo, proprio in questa sala all’Istituto Nazionale di Studi Romani pochi mesi dopo la scomparsa di Di Vita nell’aprile 2012 su invito di Salvatore Garraffo, è quello sul tesoro di Misurata e la Tripolitania tardo-costantiniana, un lavoro di sintesi che parte dal ritrovamento delle monete d’argento destinate ai gentiles limitanei che proteggevano la fattoria di Rimal Zariq (Zawiath el-Mahjoub), forse devastata dagli Austuriani, ma che si allaga al lontano ricordo di un viaggio del 1981 in compagnia di Omar Mahjoub a metà strada tra Tripoli e Sirte: <<arrivammo tardi, oltre l’imbrunire, vidi i resti di tre-quattro camere, in una delle quali, se non ricordo male, egli mi indicò che erano state trovate delle anfore, ma in realtà i vasi con monete furono rinvenuti seppelliti e non lontani l’uno dall’altro, in un’ampia area aperta, verosimilmente un cortile>>. Ma ormai il discorso è più ampio, riesce ad affrontare il tema dell’insieme della provincia tra Turris Tamallenis e Tacapae Gabes fino alle Are dei Fileni, con attenzione soprattutto per l’organizzazione del limes partendo da occidente dal Gébel che circonda ad arco la pianura costiera della Gefàra, con i tre forti di Ghadames, Gheriat el-Garbia e Bu-Ngem con gli incredibili ostraca di Gholaia, ai quali aveva dedicato voci di enciclopedia e riflessioni originali, nel fecondo confronto con René Rebuffat, lasciandosi alle spalle le vecchie posizioni del Courtois.
Non manca una rilettura attenta di tutte le fonti sulla Libia, partendo da quelle più antiche, come nella presentazione critica del volume Libykà di Gabriella Ottone, a proposito della caratterizzazione come borgo (chorìon) di Abrotonon, Sabratha, in Lico di Reggio: una città invece, polis, in Strabone. Ma Sabratha di inizio III secolo a.C. era ancora solo un piccolo emporio punico allo sbocco dell’importante via carovaniera di Ghadames: ne deriva che lo sviluppo degli empori tripolitani coincide con la autonomia riconosciuta loro dopo Zama quando non pagarono più a Cartagine il pesantissimo tributo annuo che per Tito Livio (34., 62,3) era di un talento d’argento al giorno, una quantità davvero enorme.
Significativa appare la riflessione di sintesi sul ricordo dei viaggiatori e l’esplorazione archeologica in Libia dalla fine del mondo antico ai giorni nostri, partendo dai Quaderni del 1983: Corippo racconta che l’esercito di Belisario che marciava contro i Vandali poteva camminare “nell’ombra che moltiplicavano gli alberi spessi”; e Procopio riferisce che “la zona litoranea era un continuo verziere che si tende da Tripoli fino a Tangeri; una regione ricca fra tutte dei frutti necessari alla vita”. Temi che tornano nelle descrizioni dei primi viaggiatori arabi arrivati nel 642, a proposito della sterminata distesa di alberi che tra Tripoli e Tangeri avevano l’aspetto di un unico immenso bosco nel quale sorgeva una quantità di villaggi (Ibn Khaldun da cui Abd-er-Rn-Ibn-Ziad-Ibd-Anan). La “fine del mondo antico” non sarebbe legata all’arrivo degli arabi di ‘Amr ibn al-‘Aas appoggiati dalla flotta copra di Alessandria, ma andrebbe spostata solo all’XI secolo con la violenta irruzione dei feroci Bani Hilal e dei Bani Suleim. Molti sono i viaggiatori arabi diretti alla Mecca nella Ribba rituale che descrivono la Tripolitania:già nel 1289 lo sceicco al-‘Abdari di Valenza ci ha lasciato la prima descrizione dell’arco quadrifronte dedicato dagli abitanti di Oea a Marco Aurelio e Lucio Vero, una qubba alta con costruzioni elevate; un monumento che nel 1309 viene descritto anche dallo scieicco er-Tigiani, che restò a Tripoli 18 mesi.
Non è possibile seguire in dettaglio l’attività degli europei, come il console francese Claude Lemaire sul finire del XVII secolo, che vide i dominatori ottomani nolenti più che volenti socchiudere la reggenza di Tripoli alle potenze occidentali: instancabile ricercatore di marmi antichi, il console trasse tra il 1683 e il 1708 centinaia e centinaia di colonne marmoree dal tempio (la basilica severiana) di Leptis che furono spedite in Francia. I Britannici scavarono a Leptis già nel 1817 su autorizzazione di Yusuf Caramanli pascià di Tripoli, col capitano W.H. Smyth dell’ammiragliato britannico, che si spinse fino a Ghirza. Due anni dopo il capitano inglese G.F. Lyon arrivava a Bou Ngem. A Cirene, la presenza della sfortunata missione americana diretta da Richard Norton arrivato da Creta tra il 1910 e 1911 e più volte minacciato di morte (sulla via per Cirene fu ucciso a fucilate Herbert Fletcher De Cou l’11 marzo 1911), infastidì non poco gli italiani, in particolare Federico Halbherr e Gaetano De Sanctis, che anticiparono di qualche mese l’occupazione italiana della Tripolitania e della Cirenaica decisa da Giolitti il 29 settembre 1911, quando scoppiò la guerra italo-turca. Ho trovato straordinario l’articolo sul carteggio Halbherr fa politica e archeologia, pubblicato negli Atti del convegno di Catania del 1985 sull’archeologia italiana nel Mediterraneo: vengono svelati con molto equilibrio gli imbarazzanti retroscena dell’attacco italiano alla Libia, preceduto dalle pericolose ricognizioni dell’Halbherr in Cirenaica e in Tripolitania, il ruolo del Banco di Roma, del Consolato e della Missione archeologica, di singoli studiosi come Salvatore Aurigemma a Tripoli (poi Pietro Romanelli) e Ettore Ghislanzoni (poi Gaspare Oliverio) a Cirene, le malignità sull’uccisione misteriosa del <<signore della missione americana>> che sottintende la storia delle donne beduine molestate dal De Cou ma che contrasta con l’indennità pagata per compensare la famiglia dell’ucciso; il ruolo dell’Istituto italiano per l’esplorazione del settore centrale dell’Africa del Nord. Sono soprattutto le lettere al Pernier, al De Sanctis, al Comparetti che ci fanno capire meglio l’ansia dell’Halbherr, il ruolo aggressivo da lui svolto, l’amarezza per il fatto che l’entrata in guerra dell’Italia imponeva buoni rapporti con quegli americani a Cirene che <<rappresentano una spina nell’occhio della nostra colonia>>. Ho studiato in passato lo scontro tra l’Halbherr ed Ettore Pais avvenuto nel 1918, quando il Pais riuscì a coronare una sua antica aspirazione, facendosi nominare a Roma ordinario di Storia antica sulla cattedra del Beloch, nonostante l’avversione dell’Halbherr, che lo considerava uno storico ormai “nella parabola discendente”, un “critico demolitore, incapace di una vera ricostruzione storica”. Che il De Sanctis avesse sposato pienamente ab origine le posizioni guerrafondaie dell’Halbherr è dimostrato dal fascicolo del 1928 della Rivista di Filologia e d’istruzione classica dedicato a Cirene. Fu allora istituito il Servizio per le Antichità presso il Ministero delle Colonie, premessa per la nascita delle Soprintendenze di Tripoli e Bengasi, unificate nel 1936. Conclude Di Vita: <<il moto del rinnovato impero di Roma dell’Italia fascista era cominciato>>. Di Vita osserva che il fascismo fu animato dal <<desiderio di riportare alla luce l’”orma profonda” di Roma nelle città antiche della Libia e soprattutto in quella “imperiale” per eccellenza, Leptis>>. Ma da respingere sarebbero quelle <<accuse generiche e generalizzate di incapacità scientifica e di servilismo ideologico, talora formulate in anni recenti nei confronti degli archeologi operanti in Libia>>, s’intende Salvatore Aurigemma, Gaspare Oliverio, Giacomo Guidi, Renato Bartoccini, Giacomo Caputo, Gennaro Pesce, Pietro Romanelli. Tra gli archeologi stranieri arrivati dopo la sconfitta dell’Asse, Di Vita ritiene che H.W. Haynes, J.B. Ward Perkins, R. Goodchild (primo controllore per le antichità della Cirenaica) e la nostra Joyce Reynolds si siano segnalati per il desiderio di collaborazione con gli archeologi italiani e francesi, se ai vecchi, si aggiunsero E. Vergara Caffarelli, Antonino Di Vita, Sandro Stucchi e René Rebuffat con l’impresa di Bou Njem (affidata inizialmente da Di Vita a Pierre Boyancé della Scuola di Roma, poi passata a Maurice Euzennat di Aix). Ma voglio ricordare anche gli studiosi americani impegnati ad Apollonia – Marsa Susa (prima di Laronde), Cirene, Hadrianolpolis, Euesperides, Tolemaide, ecc.
La cosa che più mi ha sorpreso in questi volumi che testimoniano la misura e la prudenza dell’autore, sempre impegnato a mantenersi su un piano “politicamente corretto” anche quando parla del colonialismo fascista, è nel commosso ricordo di tre amici libici, caduti in un incidente aereo mentre da Tripoli raggiungevano il Cairo. Cito per esteso: <<Tra i passeggeri dell’aereo di linea libico diretto al Cairo, abbattuto il 21 febbraio del 1973 da un caccia israeliano, si trovavano tre dei massimi dirigenti alle antichità di Libia: il dott. Awad Mustapha Saddawaya, direttore generale (Presidente) del Dipartimento dopo la rivoluzione del [I settembre] 1969, laureato a Liverpool, il sig. Aissa Salem el-Aswed, direttore di ricerca e capo dei rapporti con le missioni straniere segretario di redazione di Libya atiqua, il sig. Mohamed Fadil el-Mayar, aiuto controllore delle Antichità di Cirenaica>>. È l’occasione per esprimere il compianto più cocente per gli amici così tragicamente <<strappati agli affetti, al lavoro, alla Patria>>; a questi suoi figli generosi la Libia guarda ora con mestizia ma con orgoglio, e la loro devozione all’archeologia costituisce per tutti noi che li avemmo colleghi ed amici indimenticabili impegno a colmare il vuoto da essi lasciato, continuando la loro opera e adoperandoci a che essa fruttifichi ancora>>. Noi oggi possiamo cogliere solo parzialmente quell’emozione, il senso della perdita irreparabile, il danno che è stato determinato alla cultura archeologica della Libia. Emerge la figura di Aissa Salem El-Asewed, <<il caro, dolcissimo amico, che sarebbe così tragicamente e immaturamente scomparso>>: <<Segretario [di Libya antiqua] preparatissimo e linguisticamente “ecumenico” – giacché oltre al berbero e ad un arabo impeccabile conosceva l’italiano, l’inglese, il francese, il latino, il greco ed un po’ di fenicio-punico. A lui si devono le traduzioni in arabo dei contributi dei primi volumi, con termini “tecnici” che a volte egli dovette creare ex nihilo e che sono entrati nell’arabo archeologico>>.
Sarebbe troppo facile per me ricordare il bombardamento della sede dell’organizzazione per la liberazione per la Palestina del I ottobre 1985 in una località del golfo di Cartagine, Hamman al-Shatt a pochi passi dalla nostra casa di Ez Zahra, dove vivevo con i miei, in particolare con mio figlio Paolo. Allora 10 F 15 israeliani bombardarono l’abitazione di Arafat, che si salvò, a differenza di 50 suoi compagni palestinesi. Naturalmente un effetto più diretto e immediato sul patrimonio della Libia hanno avuto le vicende legate alla caduta di Gheddafi, alla c.d. primavera araba (un vero e proprio “inverno” per il premio Nobel per la pace il segretario generale dei sindacati dei lavoratori, Houcine Abbassi, che ha recentemente parlato a Cagliari su invito della Fondazione Sardegna), alla guerra in corso proprio in questi anni. In queste pagine si colgono qua e là le speranze di una Libia diversa, decisa a procedere sulla strada di uno sviluppo incredibilmente rapido, con la sua attenzione per i parchi archeologici, le ville, grazie alla lontana legge sulla tutela delle antichità che risale al 1953, alla nascita del Dipartimento per le Antichità nel 1963, che ha favorito l’arrivo di équipes di ricerca internazionali, con l’ammirazione per l’azione svolta dai colleghi libici e inglesi, riuniti intorno alla redazione di una rivista “Libia Antiqua” che intendeva portare <<il suo messaggio di civile collaborazione scientifica>>.
Credo di dovermi fermare, mentre resta sospesa la domanda del destino di tanti monumenti libici durante questa guerra sanguinosa che ha visto la distruzione del patrimonio. Ricordo l’opera dell’Istituto Centrale per il restauro per innalzare le pareti abbattute dal sisma del 365 del complesso di Sidret el-Balik con il più esteso ed importante ciclo pittorico di IV secolo trovato nel mondo romano: Di Vita raccontava come era stato difficile salvare le pitture, le quali, una volta tratte fuori dalla sabbia, hanno avuto ed hanno bisogno di restauri e cure continue. Mentre parliamo, ignoriamo totalmente cosa sia davvero avvenuto negli ultimi anni. Naturalmente ci rimane nel cuore la sorte del nostro amico l’archeologo siriano di Palmira Khaled al-Assaad ucciso barbaramente dal Daesh il 18 agosto dell’anno scorso nei primi giorni della “primavera araba”, dopo un mese di torture, magari per inseguire microscopici obiettivi di parte, tra speculazione, traffici illeciti, bieco affarismo. Il progetto dell’Is nei confronti del patrimonio archeologico è ormai chiaro: l’iconoclastia non è un fatto nuovo nella storia e non è sostenuta da alcuna motivazione sincera. Non c’è più oriente o occidente, romani o arabi, cristiani o musulmani, se ad esempio in Libia abbiamo potuto contare oltre cento siti islamici distrutti dal Daesh nello scontro tra sciiti e sunniti: qualche mese fa ne abbiamo presentato un elenco alle autorità internazionali con l’appello inviato all’Unesco e al Centro Arabo per il patrimonio mondiale.
Ma torniamo al nostro amico: 53 anni fa durante i lavori per allargare Sciara es-Seidi a Tripoli, Di Vita ritrovò tra i ruderi di un’antica moschea un frammento architettonico romano in marmo reimpiegato nel 1668, con un’iscrizione araba: tornato da La Mecca lo hāğğ Ahmed Kathodā, <<rinnovò la costruzione di questa moschea benedetta, magnificata, nell’anno 1078 della nobile Egira. E Allah costruì a lui un palazzo nel Paradiso>>, cioè – per seguire alla lettera il Corano – nella dimora della salute (dâr as-salâm) e nei giardini della delizia e del soggiorno ospitale, presso una sorgente che si trova in quel giardino, chiamata Salsabîl. Resta un mistero di come Di Vita sia riuscito a conciliare queste sue curiosità con il rapporto con i suoi amici sacerdoti della chiesa ortodossa di Creta e del patriarcato di Costantinopoli. Ma forse negli ultimi giorni Nino Di Vita pensava a quel luogo misterioso e lontano, quel paràdeisos immaginario, dipinto proprio sulla parete dell’area sacro-funeraria di Sidret el-Balik a Sabratha, dove ora si trova in pace.
 Cari amici,
Cari amici, In questi ultimi anni ho seguito con crescente curiosità e con amicizia la ricerca di Alessandro Piga svolta presso Biblioteche, Archivi e Musei alla scoperta della storia e della memoria di Erula in Anglona, uno dei tanti piccoli paesi della Sardegna: egli si è alla fine potuto giovare della collaborazione di studiosi del livello di Anna Depalmas, Giuseppe Doneddu, Franco Fresi, Mauro Maxia, Carlo Patatu, Vittoria Pilo, Alessandro Soddu, infine di quell’indimenticabile Salvatore Brandanu, di amata memoria, presidente dell’ICIMAR, scomparso ormai da un anno.
In questi ultimi anni ho seguito con crescente curiosità e con amicizia la ricerca di Alessandro Piga svolta presso Biblioteche, Archivi e Musei alla scoperta della storia e della memoria di Erula in Anglona, uno dei tanti piccoli paesi della Sardegna: egli si è alla fine potuto giovare della collaborazione di studiosi del livello di Anna Depalmas, Giuseppe Doneddu, Franco Fresi, Mauro Maxia, Carlo Patatu, Vittoria Pilo, Alessandro Soddu, infine di quell’indimenticabile Salvatore Brandanu, di amata memoria, presidente dell’ICIMAR, scomparso ormai da un anno. Cari amici,
Cari amici,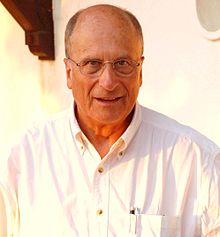 L’Università di Sassari ha conferito all’architetto portoghese Gonçalo Byrne la laurea ad honorem in Architettura. La cerimonia solenne si è svolta mercoledì 5 dicembre in Aula Magna alla presenza del Magnifico Rettore Attilio Mastino, del Prorettore Laura Manca, del Direttore generale Guido Croci, dei componenti del Senato accademico e della Giunta di ateneo.
L’Università di Sassari ha conferito all’architetto portoghese Gonçalo Byrne la laurea ad honorem in Architettura. La cerimonia solenne si è svolta mercoledì 5 dicembre in Aula Magna alla presenza del Magnifico Rettore Attilio Mastino, del Prorettore Laura Manca, del Direttore generale Guido Croci, dei componenti del Senato accademico e della Giunta di ateneo.
 Autorità, cari amici, cari studenti,
Autorità, cari amici, cari studenti,

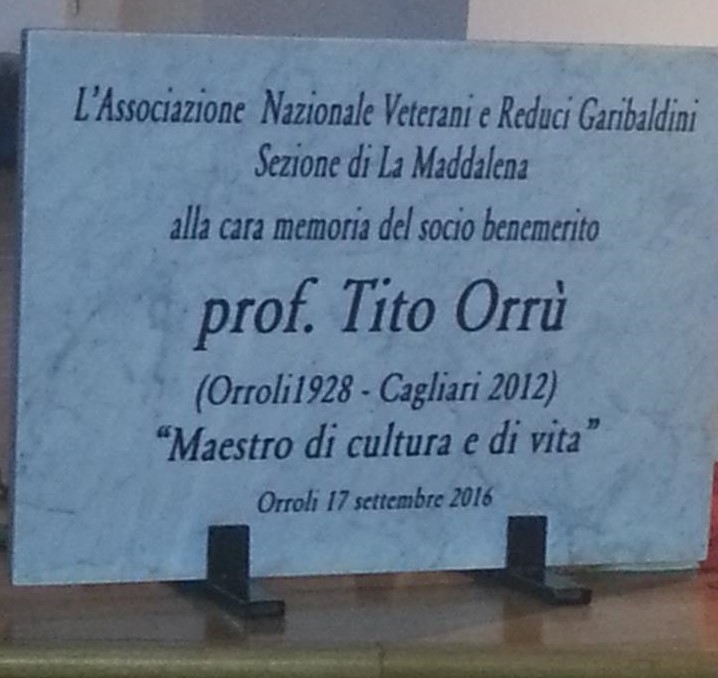
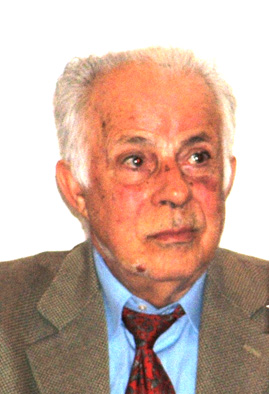 Cari amici,
Cari amici,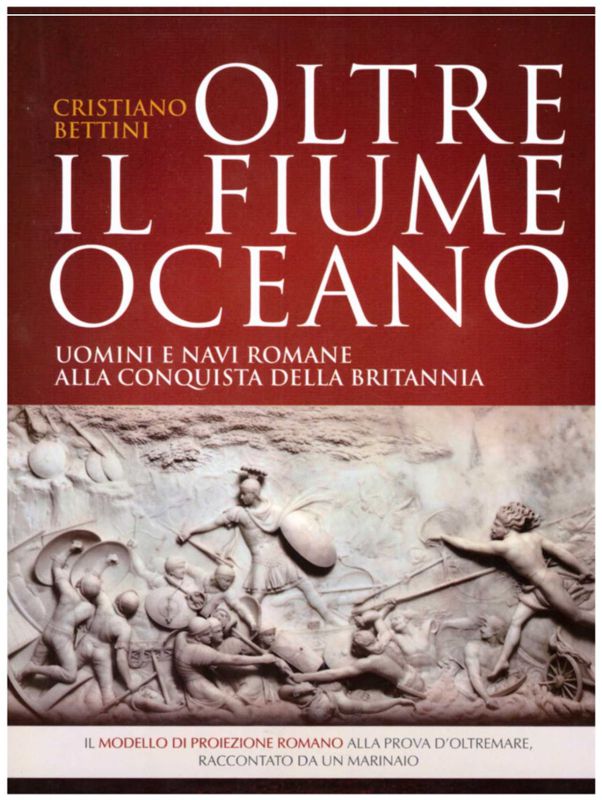

 La vicenda è troppo nota per dover essere ricostruita nei dettagli, deformata con tutta probabilità da quella che in passato è stata ritenuta la malevola ostilità di Ippolito nei confronti di Callisto, che si sarebbe disperato davanti all’inviato imperiale e sarebbe comunque riuscito a farsi liberare; al suo rientro a Roma sarebbe diventato diacono, assistente di Zefirino, incaricato della manutenzione delle catacombe sulla Via Appia, infine pontefice per cinque anni tra l’età di Elagabalo e quella di Severo Alessandro (218-222).
La vicenda è troppo nota per dover essere ricostruita nei dettagli, deformata con tutta probabilità da quella che in passato è stata ritenuta la malevola ostilità di Ippolito nei confronti di Callisto, che si sarebbe disperato davanti all’inviato imperiale e sarebbe comunque riuscito a farsi liberare; al suo rientro a Roma sarebbe diventato diacono, assistente di Zefirino, incaricato della manutenzione delle catacombe sulla Via Appia, infine pontefice per cinque anni tra l’età di Elagabalo e quella di Severo Alessandro (218-222). Dimessosi il 28 settembre 235, secondo il Catalogo, in eadem insula discinctus est IIII K(a)l(endas) Octobr(es), Ponziano morì un mese dopo, il 30 ottobre, a causa del trattamento disumano che dové subire forse presso le stesse miniere sulcitane, adflictus, maceratus fustibus, apparentemente ad opera dei soldati incaricati di obbligare i prigionieri a lavorare nelle miniere (e ormai sappiamo che gli ausiliari romani erano concentrati in Sardegna solo a Carales e nell’area mineraria del Sulcis); molto dubbio e addirittura da escludere, pur considerando le osservazioni contrarie di Raimondo Turtas, è l’esilio nell’insula Bucina, forse Molara, fondato su una variante del Liber Pontificalis, che appare decisamente meno informato del Catalogo: Pontianus episcopus et Yppolitus presbiter exilio sunt deportati ab Alexando in Sardinia insula Bucina.Eppure l’arrivo sotto Gordiano III o Filippo l’Arabo di una delegazione della chiesa romana, guidata da papa Fabiano (236-250), incaricata di recuperare i corpi di Ponziano e di Ippolito,deposti in una tomba provvisoria in Sardegna, dimostra che la memoria del luogo in cui il vescovo di Roma e il suo comes Ippolito erano stati sepolti era rimasto nel ricordo della piccola comunità cristiana locale per quasi cinque anni: Fabianus adduxit [Pontianum] cum clero per navem et sepelivit in cymiterio Callisti, via Appia; Ippolito fu sepolto invece nella catacomba di Ippolito. Avvenimento impensabile se i corpi dei due prelati fossero stati sepolti inizialmente a Molara, isola piccolissima e inospitale, che appare totalmente disabitata nell’antichità. Poco utile è la presenza a Cala Chiesa di una chiesa romanica monoansata intitolata più tardi, apparentemente solo in età spagnola, a San Ponziano.
Dimessosi il 28 settembre 235, secondo il Catalogo, in eadem insula discinctus est IIII K(a)l(endas) Octobr(es), Ponziano morì un mese dopo, il 30 ottobre, a causa del trattamento disumano che dové subire forse presso le stesse miniere sulcitane, adflictus, maceratus fustibus, apparentemente ad opera dei soldati incaricati di obbligare i prigionieri a lavorare nelle miniere (e ormai sappiamo che gli ausiliari romani erano concentrati in Sardegna solo a Carales e nell’area mineraria del Sulcis); molto dubbio e addirittura da escludere, pur considerando le osservazioni contrarie di Raimondo Turtas, è l’esilio nell’insula Bucina, forse Molara, fondato su una variante del Liber Pontificalis, che appare decisamente meno informato del Catalogo: Pontianus episcopus et Yppolitus presbiter exilio sunt deportati ab Alexando in Sardinia insula Bucina.Eppure l’arrivo sotto Gordiano III o Filippo l’Arabo di una delegazione della chiesa romana, guidata da papa Fabiano (236-250), incaricata di recuperare i corpi di Ponziano e di Ippolito,deposti in una tomba provvisoria in Sardegna, dimostra che la memoria del luogo in cui il vescovo di Roma e il suo comes Ippolito erano stati sepolti era rimasto nel ricordo della piccola comunità cristiana locale per quasi cinque anni: Fabianus adduxit [Pontianum] cum clero per navem et sepelivit in cymiterio Callisti, via Appia; Ippolito fu sepolto invece nella catacomba di Ippolito. Avvenimento impensabile se i corpi dei due prelati fossero stati sepolti inizialmente a Molara, isola piccolissima e inospitale, che appare totalmente disabitata nell’antichità. Poco utile è la presenza a Cala Chiesa di una chiesa romanica monoansata intitolata più tardi, apparentemente solo in età spagnola, a San Ponziano.