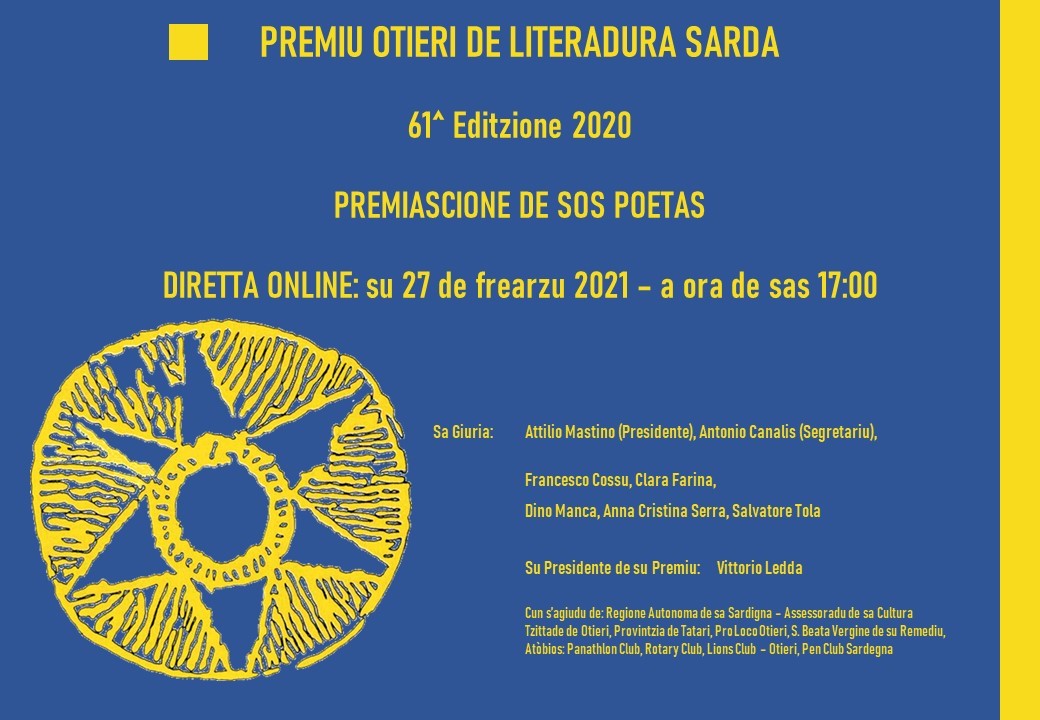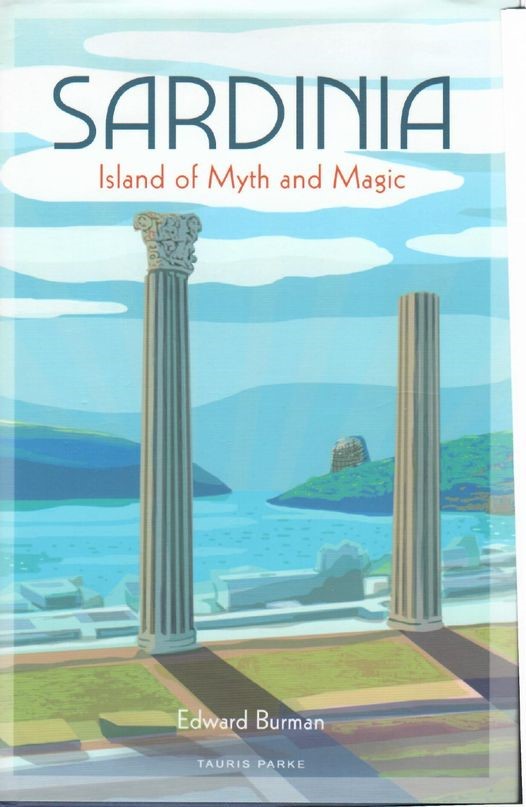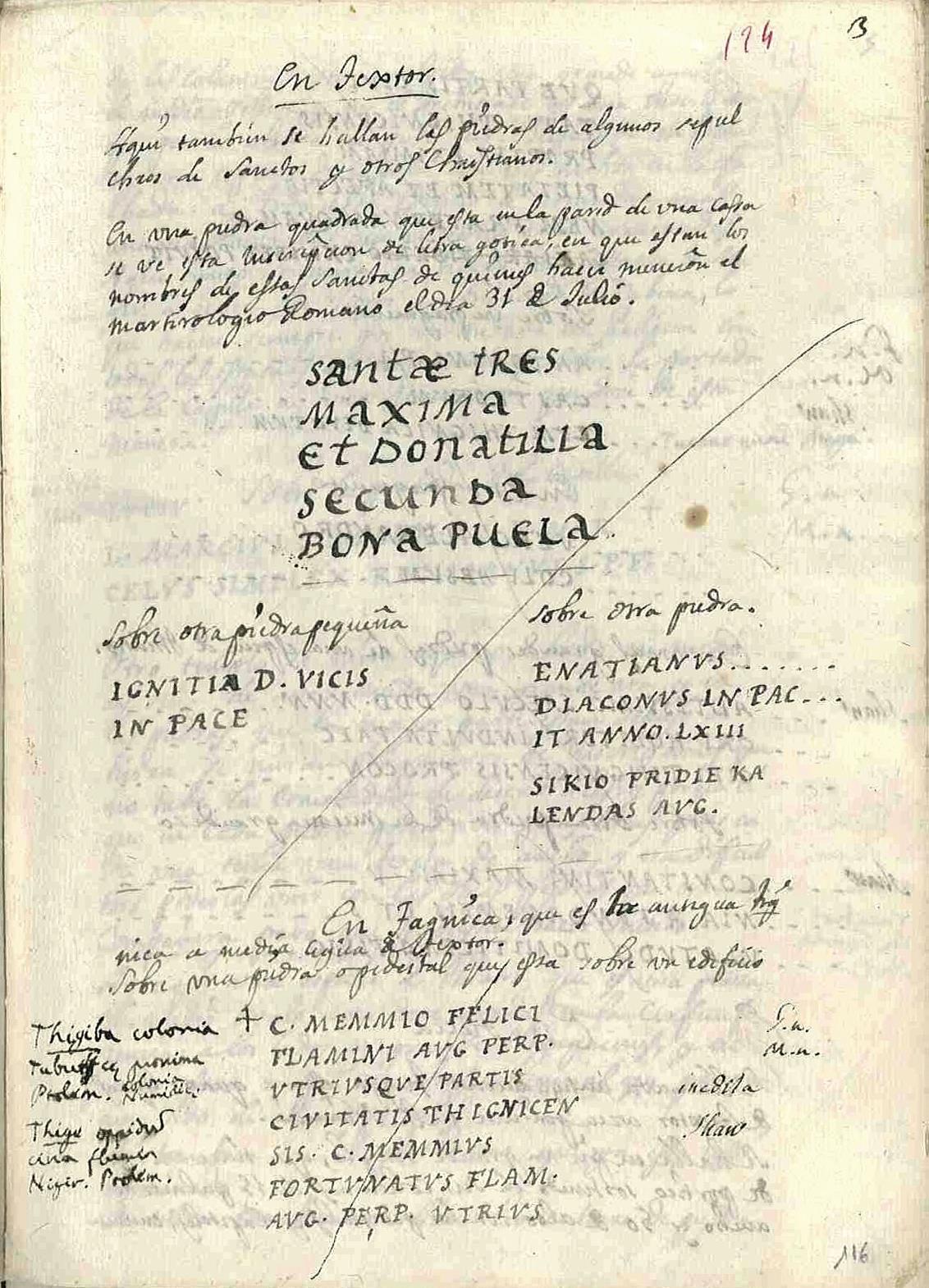Convegno internazionale “La Sardegna e il Mediterraneo: dall’archeologia alla società”.
Studi e ricerche in memoria di Ercole Contu
Sassari, 17-18 Gennaio 2020, Aula Magna, Piazza Università 21
Attilio Mastino, Ossi. Eracle e le Esperidi: le ninfe della Sardegna nell’Occidente
Mediterraneo mitico
 In questa sede, partendo dal culto di Eracle ben documentato in tutta la Sardegna (da Antas a Tharros, da Olbia a Posada, da Cagliari a Serri, infine Padria), ci concentreremo su un aspetto circoscritto, il mito delle Esperidi figlie di Forco re della Sardegna e della Corsica, riprendendo in mano il bronzetto scoperto ad Ossi nel 1938 in località Monte Mammas, sulla piana di Bilikennor presso le rovine romane di età imperiale e il successivo insediamento medioevale: il cimelio <<raffigurante Ercole, alto cm . 7,2 in ottimo stato di conservazione, di accurata fattura e di notevole valore artistico>> fu donato da Michele Macis nel 1956 al Museo Nazionale Sanna in Sassari.
In questa sede, partendo dal culto di Eracle ben documentato in tutta la Sardegna (da Antas a Tharros, da Olbia a Posada, da Cagliari a Serri, infine Padria), ci concentreremo su un aspetto circoscritto, il mito delle Esperidi figlie di Forco re della Sardegna e della Corsica, riprendendo in mano il bronzetto scoperto ad Ossi nel 1938 in località Monte Mammas, sulla piana di Bilikennor presso le rovine romane di età imperiale e il successivo insediamento medioevale: il cimelio <<raffigurante Ercole, alto cm . 7,2 in ottimo stato di conservazione, di accurata fattura e di notevole valore artistico>> fu donato da Michele Macis nel 1956 al Museo Nazionale Sanna in Sassari.
Il bronzetto, che raffigura il figlio di Giove e di Alcmena, il fratellastro di Ificle figlio legittimo di Anfitrione, fu studiato in maniera magistrale da Ercole Contu su “Archeologia Classica” del 1960, con un sguardo sui possibili modelli, forse con qualche eccesso spaziando da Policleto a Lisippo, da Prassitele a Scopas e così via; articolo ripreso e commentato nel 1981 da Robert J. Rowlad jr.. e più recentemente discusso da Pina Derudas e da Maria Pieranna Masala, soprattutto da Rubens d’Oriano nel catalogo del volume curato da Paolo Bernardini e Raimondo Zucca, Il Mediterraneo di Herakles. Da ultimo Giovanni Azzena e Enrico Petruzzi hanno rilanciato il tema della localizzazione di Ad Herculem nella Sardegna nord-occidentale, richiamando l’attenzione sulla lastra marmorea rinvenuta all’inizio dell’Ottocento nel sito dove sarebbe sorto il Palazzo di Città a Sassari, con la raffigurazione di Eracle che doma le cavalle antropofaghe di Diomede (VIII fatica).
Se torniamo al nostro bronzetto di Ossi, la descrizione di Contu è quanto mai vivace e gli ampi confronti con la statuaria classica non sono tutti pienamente giustificati, se non altro per il fatto che la piccola bronzistica ha forme, linguaggi e dettagli del tutto originali e autonomi, in rapporto ai centri di produzione : <<L’Eroe, del tipo barbuto, è rappresentano stante con la mano destra che si appoggia alla nodosa clava, mentre nella sinistra, protesa in avanti con tutto l’avambraccio, regge i pomi del Giardino delle Esperidi; dall’avambraccio sinistro pende la pelle del leone Nemeo>>. Si tratta della undicesima fatica di Eracle, ma il richiamo al leone nemeo riguarda la prima fatica, che si localizza a Nemea immediatamente a Sud dell’istmo di Corinto, su ordine del re di Tirinto Euristeo. Come è noto, in precedenza, i 50 tespiadi colonizzatori della Sardegna erano stati concepiti da Eracle e dalle 50 figlie del re Tespio durante la caccia ad un altro leone sul Monte Citerone nei pressi di Tebe. <<La testa presenta folta capigliatura, che con larghe basette si congiunge alla barba, ed è fasciata da una larga tenia, annodata sulla nuca e con lunghi capi ricadenti ciascuno su una spalla. La tenia è ornata da tre dischetti, uno per tempia ed uno più in alto della fronte. I dischetti sono divisi da una incisione a croce, il che indica trattarsi di fiori con quattro petali>>. Ulteriori dettagli riguardano i capelli quasi dimenticati entro il cerchio della tenia; la clava con nodi e spaccature; i numerosi particolari della pelle leonina; la postura del semidio nudo che grava sulla gamba destra, mentre la sinistra è notevolmente flessa, con un movimento che Contu ricollega al modello greco, lisippeo, del IV secolo a.C., anche se non pochi elementi rimandano ad una produzione pienamente romano-italica, riferibile al I secolo d.C. e ad età giulio-claudia; epoca che non sarebbe troppo distante da quella del bronzetto di Aristeo col corpo coperto di api ad Oliena. Su tale cronologia non concorda Rubens d’Oriano che pensa sì ad una produzione probabilmente italica, ma del III-II secolo a.C., penso anche alla luce dei numerosi confronti possibili con bronzetti conosciuti nel Mediterraneo e in particolare in Sardegna, ad iniziare dall’Ercole di Posada-Feronia, concordemente datato ai primi decenni del IV secolo a.C., riferito a una produzione campana oschizzata, ma collegata alla fondazione di Feronia. Tale cronologa appare francamente troppo risalente e del resto Pina Derudas mi informa che la data di fine repubblica sarebbe da preferirsi: pur non essendosi occupata degli aspetti stilistici, ha potuto citare in passato il bronzetto nell’ambito di studi territoriali in comune di Ossi: nell’areale contiguo è chiaramente attestata la frequentazione (o meglio l’occupazione) dal I al III d.C. come testimoniano sia la celeberrima necropoli romana di Sant’Antonio (più a sud del sito di rinvenimento della statuetta), scavata da Fulvia Lo Schiavo e Alberto Moravetti, sia i ritrovamenti noti dello scavo di un impianto produttivo a nord presso il nuraghe Tresnuraghes (scavo Bedello, mai pubblicato).
Un mondo ricco, vivace, colto pullula dietro la nostra statuina bronzea di Ossi, Ercole riscoperto da Ercole Contu, classicista e allievo di Ranuccio Bianchi Bandinelli relatore della tesi discussa nel 1948 a Cagliari, alla scoperta del Sarcidano, Barbagia di Seulo e Trexenta. Del resto molti di noi l’hanno visto all’opera a Turris Libisonis, per l’altare di Bubastis, a Balai, per i mosaici funerari policromi di Dionisius e Septimia Musa, il ritratto di Faustina Minore rinvenuto presso l’ara di Cuspius, il lingotto Cerdo dall’Argentiera, le tombe romane di Capo Testa, l’epitafio di Aelia Victoria Longonensis, il sarcofago di Santu Antine a Torralba. Infine le stele inscritte romane di Valledoria, di Castelsardo e di Viddalba, una scuola di artigianato popolare che sintetizza antiche tradizioni locali ma che è aperta – secondo Sabatino Moscati – alla circolazione dei modelli e degli artigiani nell’area mediterranea e soprattutto alle suggestioni africane nella Sardegna romana.
Una lettura dell’articolo pubblicato su “Archeologia Classica” conferma se ce ne fosse bisogno la formazione di Contu come archeologo classico, con confronti amplissimi che – se oggi appaiono eccessivi per la statuaria – risultano puntuali nell’arte minore, negli stessi bronzetti come l’esemplare di Marsiglia, opera provinciale italica, dove Eracle compare imberbe e con la pelle leonina che copre il braccio e l’avambraccio sinistro; i confronti arrivano ad Aquileia, Veleia, Parma, Villa Albani, Ostia, Roma Museo dei Conservatori, Palermo, Italica in Betica, musei di Monaco di Baviera e Boston. Il bronzetto di Ossi andrebbe collocato <<fra le opere del classicismo tardo-ellenistico o addirittura imperiale romano; non privo però di influssi provinciali, come parrebbe potersi dedurre dalla testa relativamente grande>>. Se l’ambito cronologico potrebbe portarci – cosa che oggi appare possibile – da Augusto all’età dei Severi, <<la rigidità, e la frontalità in cui uno schema figurativo così comune si manifesta nell’Ercole di Ossi parrebbe suggerirci una datazione ad età giulio-claudia>>. Epoca comunque preferita da Raimondo Zucca nella mostra su L’isola di Heraklés, Oristano 2004, p. 59, per quanto non dobbiamo dimenticare le osservazioni di Contu sul sapore greco-ellenistico della postura del dio.
Abbastanza inconsueto ma non sconosciuto in Sardegna è il fatto che Eracle tenga nella mano sinistra almeno un pomo d’oro raccolto nel Giardino delle Esperidi, il che rimanda al ritorno dell’eroe – scrive D’Oriano (p. 294 cat. 50) – potnios theròn, il signore delle fiere, dalle terre dove Helios declina; il cimelio comunque richiama i viaggi dell’eroe verso l’estremo occidente, non senza un riferimento alla caratterizzazione occidentale della Sardegna e della Corsica, che appare evidente nelle fonti più antiche.
La stessa scena del bronzetto di Ossi compare sulla celebre lucerna di Turris Libisonis, che in età augustea riproduce Eracle circondato dagli alberi del giardino delle Esperidi (I secolo a.C. – I secolo d.C.), in lotta col serpente custode, Ladone fratello delle Esperidi e figlio di Forco (D’Oriano, pp. 293 s. cat. 49): nella descrizione di Roberta Sulis <<Esemplare tipo Loeschcke IV, con corpo circolare tronco-conico, spalla costituita da un modesto bordo, disco concavo a cerchi digradanti concentrici e becco ogivale le cui ampie volute coprono parte della sua superficie. Nel disco è raffigurato Eracle barbato, con indosso la leontè. L’eroe, nel giardino delle Esperidi, brandisce la clava con la mano destra per abbattere il mostro serpentiforme, che tiene per il collo con la mano sinistra. La coda del mostro è avvolta, in una duplice spirale, intorno alla caviglia di Eracle. A destra è l’albero dei pomi d’oro>>.
Le testimonianze dell’XI fatica di Eracle nella Sardegna romana non ci debbono sorprendere, forse con qualche connessione con la rotta ormai in età storica studiata da Posidonio e da Plinio, che calcolavano 1250 miglia, poco meno di 2000 km, per la rotta che da Carales raggiungeva Gades sull’Atlantico. E Atlante, fratello di Prometeo, uccisore di Forco, è uno dei protagonisti del confronto con Eracle nel giardino delle Esperidi.
Il viaggio di Eracle a Sud della Sardegna verso le colonne va ben distinto dal passaggio delle Bocche di Bonifacio, l’antico Taphros, luogo nel quale si concentrano i miti greci più arcaici, alcuni pre-olimpici. Le leggende greche di fondazione immaginano un originario regno di Sardegna e Corsica, affidato a Forco, figlio di Ponto e di Gea o secondo un’altra versione di Oceano e di Teti, sposo di Keto, padre delle Gorgoni dell’estremo occidente (Medusa, Stenno ed Euriale) e delle Forcidi, divinità e mostri marini, oppure delle Sirene, di Echidna, delle Esperidi, tutte leggendarie figlie di Forco-Tirreno; infine padre del serpente Ladone custode del Giardino delle Esperidi. Secondo Servio, che riferisce una versione antichissima ma distinta dalla vulgata greca: Rex fuit (Phorcus) Corsicae et Sardiniae, qui cum ab Atlante rege navali certamine cum magna exercitus parte fuisset victus et obrutus, finxerunt socii eius eum in deum marinum esse conversum. Re della Corsica e della Sardegna è stato una volta Forco, il quale, dopo esser stato annientato in una battaglia navale e poi mandato in rovina da Atlante con gran parte del suo esercito, venne ricordato dai suoi compagni come trasformato in una divinità marina (SERV. ad Aen. V, 824. 9). Il riferimento greco alla tragedia della battaglia navale nel Mare sardo per il controllo di Alalia non è scontato. Il passo dell’Eneide commentato da Servio è relativo al viaggio di Enea nel Tirreno al largo della Campania: Venere prega Nettuno di concedere una navigazione tranquilla e questi lo rassicura dicendo che esigerà una sola vittima, avviandosi poi verso il mare Tirreno, da Ischia-Pitecussa (l’isola delle scimmie) in direzione di Capo Palinuro, dove assistiamo alla morte del timoniere di Enea, evidentemente l’unica vittima sacrificata agli dei per raggiungere l’Ausonia. E non dimentichiamo che tutta la vicenda di Forco è localizzata nel Mare Tirreno, dove si sarebbe svolta la battaglia navale vinta da Atlante, che Eracle conobbe nel Giardino delle Esperidi.
Il primo elemento fin qui trascurato è che Forco, indicato come re della Sardegna e della Corsica in età pre-olimpica, è il padre del serpente Ladone (il mostro incaricato di custodire i pomi del giardino delle Esperidi tra Creta, lo Chott el Djerid e la Mauretania atlantica, con una suggestione finale legata all’andamento sinuoso del fiume Loukkos in Marocco); Forco era anche il padre delle Esperidi (le ninfe più occidentali già per la Teogonia di Esiodo, ‛Εσπερίδες): tra esse la ninfa di Gades Erizia, sposa di Ermes, madre di Norace, il fondatore di Nora.
Il punto più occidentale della Sardegna là dove la terra finisce e il mare comincia per Tolomeo è marcato dalla Nunfaia nesos (Foradada) a 29° e 45’; sulla terra ferma il punto più occidentale e più vicino all’Iberia era invece il Capo Marrargiu, l’Hernaion akron a nord delle foci del Temo. Decisamente più all’interno il Porto Conte, cioè il golfo delle ninfe marine, protettrici della pesca e della navigazione, Numkaion limén. Nelle vicinanze, Tolomeo conosce l’isola di Eracle, l’Asinara, sulla rotta verso occidente; una variante alternativa era la rotta che Eracle avrebbe seguito a Sud della Sardegna, toccando il Portus Herculis a 32° di longitudine, Capo Malfatano (questa è l’unica rotta conosciuta da Plinio tra Carales e Gades). La ninfa Erizia nata da Gerione è ricordata indirettamente con lo sposo Ermes a Capo Marrargiu, sull’Hermaion Acron: il dio Ermes e la Esperide Erizia sono i genitori di Norace, il fondatore di Nora, il cui nome ricorda la Nurra, i Nurritani, i nuraghi. Se confrontiamo le diverse longitudini con partenza dalle Isole Fortunate, il Gorditanum, promontorium Capo Falcone Stintino ha 29° 50’: 5 primi a oriente dell’Isola Foradada, Porto Ninfeo 30° e 10’, Hermaeum promontorium 30°, Temou potamou ekbolai 30° 15’, Coracodes 30’ 20, come Tharros. Dunque la percezione è quella che Capo Marrragiu era più ad Occidente del Porto Ninfeo e che l’Herculis Insula con longitudine di 29° 20’ era più ad occidente del promontorio Gordititanum-Capo Falcone-Stintino. L’oscura denominazione Gorditanum, che troviamo anche nella Naturalis Historia di Plinio III 84, ed in Marziano Cappella, VI 645, pare difficilmente possa essere connessa con Gorgò o Gorgàs, nel senso di “testa di Medusa”, anche se appare ampiamente provato che il mito della Medusa vada inizialmente circoscritto al mare tra la Sardegna e la Corsica.
Nella sua opera In Sardiniae Chorographiam lo storico Giovanni Francesco Fara, alla fine del XVI secolo, parlando della costa a Nord di Bosa rilevava che Capo Marrargiu, noto nell’antichità come Capo Ermeo, collocato a sei miglia a Nord di Torre Argentina, è il primo promontorio della Sardegna ad essere avvistato da chi giunge per mare dalla Spagna toccando le Baleari (VI millia passuum ad prontorium Hermaeo a Polomemaeo Marrargium vulgo dictum, quod adnavigantibus ex Hispania primum omnium apparet).
Le altre Esperidi erano poi Egle, Espere, Aretusas, Esperetusa (o Esperia). Una Esperide era anche Medusa, confusa anche con le Gorgoni: con Stenno e Euriale, immortali. Tra esse (Esperidi o Gorgoni) Medusa, fu decapitata da Perseo, che vide il cavallo alato Pegaso e il gigante Crisaore uscire con violenza dalla ferita insanguinata. La testa di Medusa mantenne la capacità malefica di pietrificare i nemici con lo sguardo, come le Bithie della Sardegna; il suo sangue si trasformò in corallo. Pindaro ed Esichio di Alessandria nel V secolo a.C. sono i primi a riferire il particolare mitico secondo cui lo sguardo della Gorgone tramutava in pietra, con una forza magica che rimase intatta alla testa recisa dal corpo anche in mano a Perseo o sul petto di Athena. Questo spiega la sorte di Atlante uccisore di Forco dopo la battaglia navale nel Mare Tirreno; egli a sua volta fu trasformato in pietra.
Le Gorgoni abitavano l’estremo occidente, nelle vicinanze del regno dei morti, secondo una tradizione che risale già all’Odissea. Il mito di Forco, dio dell’Oceano nelle isole tirreniche, era già conosciuto nel III sec. a.C. da Palefato, autore di un’operetta intitolata Storie incredibili, in cui si riprendevano una serie di miti vedendo nei loro nuclei fatti veramente accaduti. È in ogni caso difficile stabilire quanto si possa ricavare di storico dal mito di Forco, re di Corsica e Sardegna per ciò riguarda i contatti fra le due isole. Indubbiamente fu la loro vicinanza geografica a suggerirne una trattazione comune anche nel mito, come d’altra parte dimostrano i nomi con cui i Greci denominavano la Sardegna e la Corsica: Kyrnos e Sardò, due dei figli di Heracles.
L’immagine di Medusa nel mito appare saldamente radicata a osservazioni naturalistiche effettuate dai marinai greci nell’area marina dello stretto di Taphros, a Nord di Ichnusa e a sud della Corsica, dove erano certamente presenti le pericolose meduse che presentano l’immagine di un polpo rovesciato con tentacoli (Cnidari o Celenterati): nell’immaginario collettivo erano associate anche a veri e propri mostri marini che abitavano il mare tra Sardegna e Corsica, a oriente della Punta Falcone: antiche leggende marinare parlavano di mostri marini, i favolosi thalattoi krioi, identificati oggi con l’orca gladiator che secondo Claudio Eliano trascorrevano l’inverno nei paraggi del braccio di mare della Corsica e della Sardegna, accompagnati da delfini di straordinarie dimensioni (Ael., Sulla natura degli animali 15.2).
Le numerose protomi femminili che risalgono ai primi decenni dell’occupazione romana (come quelle dello stagno di Santa Gilla), fissano un ramo significativo del mito di Medusa proprio in Sardegna. Gli Oracula Sibyllina annunciavano per Cyrno e per la Sardegna uno stesso destino tragico, una sorta di apocalisse incombente, “sia a cagione di grandi procelle invernali, sia per le sciagure inflitte dal supremo dio, quando le due isole nel profondo del pelago penetreranno, sotto i flutti marini” (Orac. Sib., 477-479). Sardegna e Corsica erano collocate al buio, nell’estremo occidente, in un mondo pieno di mistero, oltre prima o dopo quelle colonne che Ercole per i marinai greci indicavano il confine più estremo per la navigazione.
Secondo Raimondo Zucca <<l’isola di Hercules della Sardegna [l’Asinara] appare connessa ad una serie di toponimi sparsi nel Mediterraneo occidentale (cui partecipano anche le isole di Herakles presso Cartagena e Huelva) lungo la via Eraclea che segnano, lungo il mare, le tappe dei miti relativi al viaggio di Herakles in Occidente, alla conquista delle mandrie di buoi di Gerione e all’acquisto dei pomi d’oro nel giardino delle Esperidi. A dire il vero secondo gli antichi, Herakles non sarebbe passato in Sardegna, ma vi avrebbe inviato una colonia costituita dai suoi cinquanta figli, nati dalle cinquanta figlie di Tespio, re di Tespie in Beozia. A capo della colonia l’eroe pose Iolaos, che avrebbe fondato in Sardegna Olbia e altre città greche. Secondo una tradizione lo stesso Herakles avrebbe condotto degli Olbiesi, forse proprio quelli di Sardegna, sino in Mauretania. A sostegno indiretto di una rotta eraclea che avrebbe toccato anche la Sardegna possiamo citare l’epitome liviana che conosce un Baleo, eponimo delle insulae Baliares, compagno di Hercules abbandonato in quelle isole, allorquando l’eroe si dirigeva in nave verso Tartesso, la terra di Gerione. La rotta Sardegna-Baleari-Spagna sarebbe dunque stata seguita da Hercules secondo la versione principale del mito. Le fonti mitografiche antiche avevano coscienza della complessità della figura di Herakles nella sua proiezione occidentale, giungendo a teorizzare l’esistenza di due Herakles, uno tirio, l’altro tebano. Tuttavia le profonde relazioni tra l’elemento euboico e quello levantino avevano prodotto un vero e proprio sincretismo tra Melqart (l’Herakles tirio) e l’Herakles tebano, così da proiettare la saga dell’Herakles tirio anche nel Mediterraneo orientale e nella stessa Grecia continentale, in Beozia e a Delfi, mentre l’Herakles tebano partecipava ad avventure di ambito occidentale, fino a divenire l’Heraklés gaditano. Osserviamo in filigrana nei racconti mitografici relativi all’Herakles tirio in Grecia la connessione tra i Phoinikes e gli Eubei storicamente documentata in Oriente e in Occidente tra IX e VIII secolo a.C. Questa liaison è stata autorevolmente affermata da Laura Breglia Pulci Doria in riferimento all’apoikia dei Tespiadi, figli di Herakles, in Sardegna, ma è ora limpidamente confermata da una documentazione archeologica cospicua nel Mediterraneo centrale (compresa la Sardegna) e occidentale e nell’Atlantico, dove a Huelva, in particolare, i rinvenimenti archeologici più recenti illustrano il rapporto tra Fenici, Euboici, Sardi e Villanoviani>>.
Per Paolo Bernardini <<La mitologia è racconto dell’inizio dei tempi e insieme ideologia e trasfigurazione del presente: le imprese di Melqart-Heraklès in Occidente legittimano, per i marinai e i mercanti che seguono le loro tracce, il loro diritto a stanziarsi in quelle terre per loro conquistate dal dio. Nel mito e nelle storie che legano Melqart a Heraklès, dalle colonne che segnano i confini del mondo – ma che aprono in realtà un mondo nuovo, le frontiere atlantiche, agli scambi e ai traffici dei Fenici e dei Greci – alla conquista dei pomi delle Esperidi o al ratto delle mandrie di Gerione, traspare una storia reale di interrelazioni e di contatti che legano ai Fenici i primi intraprendenti naviganti greci dell’Occidente: i marinai dell’isola di Eubea; gli empori fenici mediterranei si aprono volentieri all’apporto ellenico e la mescolanza etnica sulle nuove frontiere dell’Ovest è un fenomeno ormai ben documentato dall’archeologia: che siano i Greci che risiedono a Cartagine o i nuclei levantini residenti nell’emporio di Pitecusa o, sulla frontiera sarda, le tracce di una loro presenza, accanto ai Fenici e agli indigeni, negli avamposti commerciali impiantati sulle coste>>.
Naturalmente il mito confonde le Esperidi con altre divinità, ninfe o comunque dee della navigazione e delle acque: possiamo tentare un elenco relativo ai miti femminili sulla colonizzazione della Sardegna.
Cirene, Euridice, Autonoe.
Aristeo fu generato in Libia da Cirene e da Apollo, nelle grotte calcaree del Djebel Akdar in Cirenaica; egli avrebbe amato Euridice così come lo sconsolato Orfeo dei mosaici di Cagliari o di Turris; Aristeo sposò poi Autonoe, madre di Charmo e Callicarpo, nati in Sardegna dopo la tragedia di Atteone: il ragazzo era stato allevato dal Centauro Chirone, lo stesso della IV fatica di Eracle.
Medusa: madre di Pegaso, figlio di Poseidone oppure di Pasifae o Perseide.
La “visione a volo d’uccello” della Sardegna Ichnussa-Sandaliotis descritta con la forma di un piede o di un sandalo dove l’alluce è rappresentato dall’Isola di Eracle, richiama il volo mitico di Pegaso figlio di Medusa e Posidone. Oppure il volo di Dedalo profugo dal labirnto cretese e da Kokalos in Sicilia (secondo una versione del mito sposo di Pasifae, figlia di Elios e della ninfa oceanina Perseide); infine il volo dell’automa bronzeo Talos figlio di Vulcano.
Sardò
Altri filoni del mito rimandano a Sardò, sposa di Tirreno, se stiamo ad uno Scolio al Timeo di Platone, che colloca il nome “l’isola dalle vene d’argento” abbandonato a favore di “Sardò”, con l’arrivo della sposa del dio tirreno, eponimo degli Etruschi.
Altre ninfe
L’elenco delle ninfe della Sardegna è più ampio: basi pensare alle Ninfe salutari, alle Ninfe Augute, ai Numina delle Ninfe, delle Aquae Hipsitanae collegate al culto di Esculapio oppure alle Aquae Lesitanae.
I collegamenti onomastici sono numerosi: le 50 Tespiadi amate da Eracle si confrontano coi nomi delle Amazzoni, delle Nereidi, delle Ninfe, delle Muse, delle Menadi, delle Esperidi, delle Oceanine, delle figlie di Pelope, del ciclo troiano, delle eroine ateniesi o della Beozia.
Bibliografia minima
AA.VV. L’isola di Herakles, a cura di P.G. Spanu, R. Zucca, R. D’Oriano, Mythos iniziative, 2004
A.VV., Il Mediterraneo di Herakles. Studi e ricerche. Atti del Convegno di studi (Sassari, 26 marzo 2004; Oristano, 27-28 marzo 2004), a cura di: Paolo Bernardini, Raimondo Zucca, Carocci, Roma 2005
G. Azzena, A. Mastino, E. Petruzzi, Dalla Colonia Iulia Turris Libisonis al Comune di Sassari. Eredità, persistenze e trasformazioni, in G. Azzena, A. Mastino, E. Petruzzi, D. Rovina, Alle origini di Sassari, dal volume I Settecento anni degli Statuti di Sassari, A. Mattone, P. Simbula edd., Sassari, 24-26 novembre 2016, Delfino editore, Sassari 2018, pp. 9-33
E. Contu, Ercole e le Esperidi in un bronzetto da Ossi, “Archeologia Classica”, XII, 1960, pp. 96-99
M. Derudas, Ossi, storia, arte, cultura, Sassari 2013
P. M. Derudas, La necropoli di Mesu ‘e Montes (Ossi), Sassari 2005
P.M. Derudas, Necropoli ipogeiche di s’Adde ‘è Asile e Noeddale (Ossi), Sassari 2005
M. Madau, Immaginario del potere e mostri marini. Mito, storia, paesaggi culturali, L’Africa Romana XIX, Roma 2012, pp. 1693-1704
M.P. A. Masala, Il culto di Ercole in Sardegna. Identità e geografia di un Mito, Cargeghe 2008
A.Mastino, I miti classici e l’isola felice, in Logos peri tes Sardous, Le fonti classiche e la Sardegna, a cura di Raimondo Zucca, Carocci, Roma 2004, pp. 11-26
A.Mastino, La Sardegna arcaica tra mito e storiografia: gli eroi e le fonti, in Corpora delle antichità della Sardegna, La Sardegna fenicia e punica, Storia e materiali, a cura di M. Guirguis, Poliedro, Nuoro 2017, pp. 19-29
 A nome della Scuola archeologica italiana di Cartagine annunciamo con vivo dolore la scomparsa del socio Jehan Desanges, Maestro ed amico indimenticabile. Siamo vicini alla Signora Monique Longerstay, che abbracciamo con affetto, ai suoi allievi, ai suoi studenti. Abbiamo avuto il privilegio di conoscere da vicino uno studioso che già nel 1962 aveva pubblicato il suo capolavoro, Catalogue des tribus africaines de l’Antiquité classique à l’ouest du Nil, éd. Publications de la section d’histoire de l’Université de Dakar.
A nome della Scuola archeologica italiana di Cartagine annunciamo con vivo dolore la scomparsa del socio Jehan Desanges, Maestro ed amico indimenticabile. Siamo vicini alla Signora Monique Longerstay, che abbracciamo con affetto, ai suoi allievi, ai suoi studenti. Abbiamo avuto il privilegio di conoscere da vicino uno studioso che già nel 1962 aveva pubblicato il suo capolavoro, Catalogue des tribus africaines de l’Antiquité classique à l’ouest du Nil, éd. Publications de la section d’histoire de l’Université de Dakar.