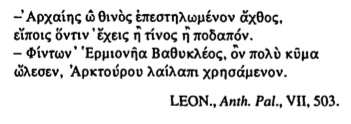Convegno “La cittadinanza, MDCCC Anniversario della Constitutio Antoniniana”
Attilio Mastino (Sassari)
Constitutio antoniniana: la politica della cittadinanza di un imperatore africano
Roma 17 dicembre 2012
Convegno “La cittadinanza, MDCCC Anniversario della Constitutio Antoniniana”
A milleottocento anni di distanza dalla emanazione, la Constitutio antoniniana de civitate continua ad essere un tema storico giuridico di grandissima rilevanza: anche se ci pare di conoscere quasi ogni dettaglio, in realtà il provvedimento imperiale di Antonino Magno, alias Lucio Settimio Bassiano alias Caracalla si caratterizza quasi per un’aura di mistero che noi storici e giuristi non riusciamo a disvelare, perché ancora oggi è davvero difficile tracciare un quadro complessivo degli effetti concreti della portata del provvedimento, forse ispirato dal grande Settimio Severo. Si discute se si sia trattato di una norma che metteva ordine in una situazione eterogenea di accesso alla cittadinanza, o se piuttosto rispondesse alle esigenze di rimpinguare le casse imperiali con l’imposizione della tassazione al maggior numero di cittadini possibile.
Oggi celebriamo questa ricorrenza qui in Campidoglio presso il tabularium, il più antico edificio arrivato fino a noi della Roma repubblicana e più precisamente dalla dittatura legibus scribundis di Silla, per quanto la dedica sia stata effettuata due anni dopo, hoc solum felicitati eius negatum.
Veniamo ai fatti così come ce li presentano gli autori che vissero ed ebbero contatti con la corte severiana, Cassio Dione ad esempio e successivamente gli autori di epoca tardo-antica e cristiana che offrono una lettura meno materialistica e con maggiori accenti ecumenici dell’editto de civitate.
Nella primavera del 212 l’imperatore Caracalla, ormai unico Augusto dopo aver eliminato qualche mese prima il fratello Geta, con un editto stabilì che tutti coloro che erano all’interno dell’Impero avessero accesso alla cittadinanza, in orbe romano qui sunt ex constitutione imperatoris Antonini cives Romani effecti sunt recita il commentario edittale di Ulpiano (Dig. 1. 5. 1). In realtà Ulpiano dà conto di una situazione già profondamente trasformata grazie al recente provvedimento di Caracalla già divenuto prassi in quanto nell’ecumene romana tutti erano divenuti cittadini romani. La storiografia contemporanea si è generalmente mossa su un filone critico tendente a valorizzare il lato “rivoluzionario” del provvedimento che riguardò migliaia o centinaia di migliaia di peregrini, cioè di stranieri che fino a quel momento avevano vissuto entro l’impero romano fianco a fianco dei cives Romani.
L’elemento discrepante, rilevato dalla maggior parte degli storici e dei giuristi, il lato oscuro della vicenda va ricercato nella modesta eco che l’editto trovò nelle fonti storico-giuriche, anche in quelle contemporanee. Lo storico filosenatorio Dione Cassio, testimone diretto degli avvenimenti, ostile alla memoria di Caracalla, interpretò riduttivamente ed in chiave fiscale l’editto: se ufficialmente Antonino Magno avrebbe inteso onorare gli abitanti dell’orbis romanus con l’estensione della cittadinanza, in realtà il suo obbiettivo concreto sarebbe stato quello di incrementare il gettito tributario, gravando anche i novi cives delle imposte sulle manomissioni e sulle successioni, di recente da lui raddoppiate, per far fronte alle spese militari e per stipendia e donativi a legionari e pretoriani che com’è noto costituivano la principale base di consenso non solo dell’imperatore in carica ma dell’intera dinastia severiana. Nell’opera di Erodiano, anch’egli contemporaneo di Caracalla e personaggio di spicco della burocrazia imperiale che scrive all’epoca di Filippo l’Arabo, negli scritti del giurista Paolo come pure nella più tarda Historia Augusta, non vi è traccia di riferimenti al provvedimento. Come si è detto il solo Ulpiano fa un cenno nel commentario edittale che trova spazio nel Digesto mentre è frequente la confusione e l’imprecisione circa l’attribuzione della Constitutio ad altri imperatori diversi da Caracalla: in una novella di Giustiniano del 539 l’editto è per errore attribuito ad Antonino Pio, ma la cosa non sorprende a causa della somiglianza nella titolatura imperiale con il figlio di Settimio Severo; analoghi errori si riscontrano anche in Aurelio Vittore ed in Giovanni Crisostomo che fanno risalire l’editto rispettivamente a Marco Aurelio e ad Adriano.
Certo è che le fonti più tarde, in particolare quelle cristiane, con maggior distacco rispetto a Dione Cassio scelgono come parametro di giudizio l’ecumenismo del provvedimento sottolineando, nel caso di Agostino, come esso rispondesse ad un principio di umanità e partecipazione ad un bene comune, se così vogliamo definire la cittadinanza, che precedentemente era riservato a pochi.
Prudenzio si spinge oltre istituendo un vincolo diretto tra Dio e la cittadinanza romana: «Dio insegnò a tutti i popoli a piegare il capo sotto le medesime leggi e a diventare tutti romani» contra Symmachum vv.601-602: …Deus, undique gentes/inclinare caput docuit sub/legiuis iisdem, Romanosque omnes fieri e afferma con decisione che: «Gli abitanti di regioni lontane le une dalle altre e di rive opposte del mare si incontrano ora nell’unico foro comune per ottemperare alla promessa di comparire in giudizio, ora a una fiera assai frequentata dove scambiano i prodotti delle loro attività, ora a stringere vincoli nuziali con pieno diritto di nozze straniere; infatti si va creando una stirpe sola di sangue misto, da popoli che si incrociano». X vv. 612-618: Distantes regiones plagae divisaque ponto/Littora conveniunt nunc per vadimonia ad unum/Et commune forum nunc per commercia et artes/Ad coetum celebrem nunc per geniala fulcra/Externi ad ius connubii: nam sanguine mixto/Texitur alternis ex gentibus una propago.
Le più recenti sintesi di carattere storico-giuridico come quella recentissima assai accurata di Valerio Marotta continuano a rilevare la «totale mancanza di epigrafi e di conii celebrativi». Permettetemi a questo punto una nota di dissenso e una precisazione che avanzo da studioso, ormai purtroppo in anni giovanili e lontani, delle titolature relative a tutti i documenti epigrafici di Caracalla e di suo fratello Geta.
Credo che la celebrazione, contemporanea agli eventi, della Constitutio sia sotto gli occhi di tutti: nell’adozione forse sin dal 212 da parte dell’imperatore del titolo di Magnus, nell’ideologia cosmocratica attestata dal titolo cosmocrátor che avvicinava Caracalla a Serapide, divinità cara ai ceti popolari. In tutto ciò si può leggere un coerente e ampio disegno propagandistico, teso ad affermare il principio di una monarchia estesa a tutta l’oikouméne, finalizzata a distribuire pace e felicità a tutti gli uomini. Del resto tale filone propagandistico si individua in altri elementi della titolatura dell’imperatore, gli epiteti di rector orbis e di pacator orbis frequenti sulle emissioni monetali. Come già ebbi modo di scrivere, lo sviluppo dell’ideologia cosmocratica e la titolatura conseguente va messa in relazione con la Constitutio antoniniana de civitate del 212 d.C., comunque tempo prima della vcittoria germanica del 213, ed è questo il riflesso nella documentazione epigrafica che ci è rimasto di quel provvedimento. Sullo sfondo il modello ideale di Alessandro Magno al quale Caracalla si è certamente ispirato – l’assunzione del titolo di Magnus rientra appieno in questa prospettiva – con il suo militarismo, la politica di universalismo e di sincretismo religioso.
In passato ho potuto dimostrare che il titolo di Magnus, adottato ufficialmente da Caracalla fin dal 212, può essere collegato con l’emanazione della constitutio Antoniniana de civitate e contribuisce comunque a chiarire l’ambiente politico e culturale nel quale è maturato il provvedimento, che realizzava per la prima volta un impero universale aperto a tutti gli uomini. Dedicando a Caracalla la sua opera sulla caccia, Oppiano nel 212 impiegava già un modello propagandistico, che avrebbe avuto immediato successo: parlando del principe, poteva scrivere che Giulia Domna aveva generato Antonino Magno per Settimio Severo Magno.
A tale ricostruzione ha aderito a suo tempo già André Chastagnol che ha denunciato l’innovazione introdotta da Caracalla accettando la data del 211, ben prima della spedizione germanica: «d’autre part, que, depuis 211, Maximus a souvent été remplacé par Magnus, qui ne paraissait pas auparavant et est devenu pour l’empereur un véritable cognomen distinctif, certes moins reluisant à première vue que son superlatif, mais adopté dans le désir de prendre modèle sur Alexandre». È sicuro il collegamento, attraverso il titolo di Magnus, con la figura di Alessandro Magno, un modello riproposto proprio in quegli anni dallo Pseudo Callistene; nell’Epitome de Caesaribus, lo Pseudo-Aurelio Vittore sembra legarne l’assunzione al periodo immediatamente successivo alla morte di Geta.
L’aspirazione, almeno teorica, ad allargare i confini dell’Impero fino a comprendere territori poco romanizzati e fino ad abbracciare potenzialmente tutte le terre conosciute, è confermata anche dal rarissimo epiteto kosmokratwr, ripetutamente portato da Caracalla filosarapij, così come dal dio Serapide comes e conservator dell’Augusto, definito a sua volta mevga” come il principe.
Gli aspetti spaziali di questa teoria di governo sono sottolineati ed acquistano significato nel richiamo ad Eracle (che assieme a Libero era uno dei due dii patrii della città di Lepcis Magna, città di origine di Settimio Severo), il dio che aveva fissato i confini occidentali del mondo; fu allora valorizzato il culto dello stesso Dioniso e si tentò un collegamento del nevo” Diovnuso” con il trionfo indiano del dio.
I riferimenti all’orbis (pacator orbis, propagator orbis, rector orbis), frequenti nelle iscrizioni e nelle monete, sono ripresi significativamente anche dalla titolatura greca, dove con maggiore enfasi si esalta l’ oijkoumevnh, l’impero universale che comprende la terra ed il mare (gh kai; qalassa), il kosmoj, di cui il principe è di volta in volta despothj, euergethj, kurioj, swthr.. È un altro aspetto di un coerente ed ampio disegno politico-religioso-giuridico, che si manifestò pienamente non appena Caracalla rimase solo al potere: in una iscrizione alessandrina dell’8 novembre 212 l’imperatore è esaltato come o swthr thj olhj oikoumenhj, un’espressione che certamente dev’essere collegata all’emanazione della constitutio Antoniniana de civitate, dato che il dedicante riconoscente è un M. Aurhlioj Melaj che senza dubbio intendeva così ringraziare Caracalla per avergli concesso la cittadinanza romana.
I richiami all’impero universale, l’esaltazione del principe che distribuisce pace e felicità a tutto il genere umano (pan anqrwpwn genoj), lo stesso titolo di Magnus, già portato da Pompeo, che era stato ugualmente un ammiratore di Alessandro, vanno collegati non tanto alle vittorie militari di Caracalla, quanto piuttosto all’entusiasmo che certo in alcuni ambienti provinciali dovette suscitare l’emanazione della constitutio Antoniniana de civitate, un provvedimento che tendeva all’uguaglianza di tutti gli uomini liberi nel quadro dell’unico ius Romanum, fondando una realtà sovrannazionale che superava ormai ogni divisione di razza e di lingua.
In questo senso Caracalla fu più grande di Augusto (maior Aug(usto) lo chiamavano già il 17 maggio 213 i Fratres Arvales) e più grande anche di Alessandro, che secondo Elio Aristide era stato piuttosto un conquistatore che un sovrano («kthsanenw basileian mallon eoiken h basileusanti»). Nell’Encomio ”A Roma”, pronunciato forse il 21 aprile 148, in occasione dei festeggiamenti per i novecento anni dalla fondazione di Roma, Elio Aristide aveva esaltato l’impero degli Antonini, sostenendo che era superiore a qualunque altro precedente storico; non reggevano al confronto né l’impero persiano, né quello di Alessandro e a maggior ragione neppure la modesta ajrchv fondata dalle città greche, in particolare da Sparta e da Atene. I Romani erano infatti riusciti a stabilire una « koinh; thj ghj dhmokratia, uf’eni; tw aristw arconti kai; kosmhth », che era caratterizzata dal fatto che un’unica città si era estesa fino a comprendere tutto il mondo.
Distinguendosi da tutti i suoi predecessori, Caracalla riusciva ora a superare anche quel contrasto tra politai ed uphkoi, che lo stesso Elio Aristide alcuni decenni prima aveva segnalato come una realtà di fatto che pareva quasi insuperabile; risolvendo una tale aporia, dando dignità e voce ai provinciali ed a tutti i gruppi che l’avevano portato al potere, Caracalla si dimostrava più grande degli altri Antonini, fondava un nuovo secolo aureo, realizzava per primo un impero universale aperto a tutti gli uomini. Con un tono enfatico e con qualche ingenuità, il [corpus piscatorum] et urinatorum del Tevere avrebbe allora festeggiato il suo genetliaco salutandolo per aver allargato i confini dell’impero e concesso la pace al mondo: il 4 aprile 211 il principe era invocato come deus, sideribu[s in terram delapsus], e ancora [t]onitrator Aug(ustus), orbis terrarum [propagator, dominus] maximus, poiché ha ampliato l’impero e garantito la pace: providens imperi sui mai[estatem finesque eius] ampliavit, largam gloriam pac[e data auxit; coronavit la]urea dextra manu signum Victor[iae quae loco veneratu]r curiae sacro urbis, ut in aeternum [illi laus esset], secondo l’edizione di Geza Alföldy.
Il contenuto effettivo della Constitutio Antoniniana de civitate è tutt’oggi incerto, in quanto problematica, nonostante l’ampiezza degli studi in proposito, è la tradizione testuale ad essa relativa. La maggior parte degli studiosi ritiene che il testo in lingua greca dell’editto di Caracalla sia contenuto in un papiro, scoperto nei dintorni di Heptacomia- Apollonopolite in Egitto, poco più a sud di Licopolis, nella Tebaide e custodito nella biblioteca di Giessen, in Germania più precisamente nell’Assia (Papiro n. 40). Esso venne pubblicato per la prima volta nel 1910 dal Kornemann e dal Meyer; si tratta di un testo nel complesso molto lacunoso, scritto sulla prima colonna del papiro che contiene, su una seconda colonna, altri due provvedimenti attribuibili a Caracalla, un’amnistia e un’ordinanza di espulsione degli Egizii da Alessandria, risalenti rispettivamente al luglio 212 e al gennaio 213 e che costituiscono una sorta di terminus ante quem per la pubblicazione dell’editto de civitate che risale perlomeno a data antecedente al luglio 212.
Secondo le integrazioni proposte già dai primi editori, le linee 7-9 rappresentano il dispositivo del provvedimento, relativo alla concessione della cittadinanza da parte dell’imperatore: dídomi toij sumpá[sin xénoij toij katá t]hn oikouménhn p[olei]teían Romaíwn cioè concedo a tutti gli stranieri che si trovano nell’ecumene la cittadinanza dei romani. In realtà il testo greco parla di oikouménen parola quasi sicuramente corrispondente al termine originale latino orbis: l’uno e l’altro, pur riferendosi allo spazio dell’impero romano in ambito mediterraneo, non escludono però la pretesa imperiale di un’estensione verso un’area geografica più ampia che forse arrivava ad oltrepassare teoricamente i confini dell’impero. Del resto tale ampliamento è testimoniato dall’interesse di Caracalla verso l’area orientale e non solo quella del vicino oriente antico ma anche verso i luoghi della spedizione indiana di Alessandro, sulle tracce di Dioniso del trionfo indiano del dio.
Alla linea 9 del Papiro di Giessen sembrerebbe comparire una clausola di salvaguardia di difficile interpretazione introdotta dal participio [m]énontoj usato nella forma transitiva che farebbe riferimento ad una generale concessione della cittadinanza a ciascun ceto sociale, tranne che ai dediticii ([m]énontoj [tou dorou pan ghénoj tagmátwn] cor[íj] twn [de]deitikíwn). Sull’identificazione dei dediticii come gruppo sociale, se questa integrazione fosse giusta, ad oggi non vi è una risposta univoca e viene da domandarsi chi fossero e perché nell’ambito di un provvedimento a così forte pregnanza universalistica siano stati esclusi. L’autorità del Mommsenn (che altresì non vide il papiro perché morì sette anni prima della sua pubblicazione) e quella dei primi editori Kornemann e Meyer hanno lasciato la loro impronta su numerosi studi successivi e il quadro che ne è scaturito è stato di una esclusione dagli effetti dell’editto de civitate delle masse contadine tributarie (da identificarsi con i dediticii?) mentre i beneficiari sarebbero stati gli abitanti delle città dell’impero, cives o polítai.
Di recente è stata proposta un’altra possibile integrazione alternativa a [de]deitikíwn, ossia [ad]deitikíwn con riferimento agli additicia, nel senso di vantaggi addizionali come immunità e privilegi attribuiti a comunità o singoli individui. A questo punto, secondo la critica più recente entra in gioco il confronto con la clausola di salvaguardia contenuta in un importante documento epigrafico dell’età di Marco Aurelio, la tabula Banasitana.
Pubblicato oltre trent’anni fa, esso sembra costituire, per alcuni aspetti l’antecedente diretto della Constitutio Antoniniana. Rinvenuta a Banasa, colonia augustea in Mauretania Tingitana, la tabula contiene le copie (exempla) di due epistulae inviate ai governatori provinciali rispettivamente da Marco Aurelio e Lucio Vero nel 168 e Marco Aurelio e Commodo nel 177: gli imperatori concedevano, su istanza del governatore, la cittadinanza ad alcuni notabili del popolo degli Zegrensi, prima a Iulianus e alla moglie Ziddina; più tardi alla famiglia di Aurelius Iulianus, più precisamente alla moglie Faggura ed ai quattro figli. Il secondo personaggio, Aurelius Iulianus, figlio probabilmente dell’omonimo che ha avuto per primo la cittadinanza, compare addirittura come princeps gentium Zegrensium. Si tratta di un esponente di primo piano, appartenente all’élite di un popolo barbaro, stanziato nell’attuale Marocco. Il suo orgoglio per la cittadinanza romana concessa ai suoi figli e per il loro nuovo status di cittadini spiega anche la ragione della trascrizione su una tabula di bronzo, che fu sicuramente esposta al pubblico, probabilmente presso la residenza familiare.
L’elemento che permette di accostare il dettato della tabula e quello della successiva Constitutio riguarda la cosiddetta clausola di salvaguardia indicata nel rescritto imperiale: la cittadinanza veniva concessa salvo iure gentis, a condizione cioè che potesse essere rispettato il ius gentium, ma anche che non venisse pregiudicato il pagamento dei tributi dovuti all’erario ed al fisco (sine diminutione tributorum et vectigalium populi et fisci); dunque una possibile ricostruzione per le linee 8-9 del Papiro di Giessen 40 sempre secondo la critica più recente potrebbe essere: [«fatto salvo il diritto delle comunità politiche (esistenti) tranne …»] (ménontoj tou nómou (o dikaíou) ton politeumáton coríj twn …
La Tabula Banasitana, potrebbe documentare la persistenza di obblighi nei confronti della comunità d’origine: Aurelius Iulianus, civis Romanus è contemporaneamente un princeps gentis, la gens degli Zegrenses, un princeps constitutus dall’autorità romana, interessata a che egli mantenga ben vivo il legame con la realtà locale anche per ragioni di ordine pubblico: le tribù locali del Nord Africa spesso daranno vita a sommovimenti e rivolte contro l’autorità romana sino alla grande rivolta delle tribù maure del IV secolo, capeggiata dal principe Firmo della tribù degli Iubaleni. In ogni caso è plausibile che la clausola salvo iure gentis possa riferirirsi ad un diritto delle singole gentes o nationes, che sopravvive al fianco del diritto romano senza peraltro pregiudicare gli obblighi nei confronti della communis patria, Roma; tale sopravvivenza viene anzi sentita come necessaria soprattutto ai fini dell’integrazione delle aristocrazie locali e non solo.
Del resto sia nelle aree orientali sia in quelle occidentali dell’impero a partire dall’età antonina, come testimonia almeno la Tabula Banasitana, e con un costante incremento a partire dall’età severiana si assiste ad una particolare forma di adattamento dei diritti locali consuetudinari o meglio di quelle che a livello giuridico vengono definite consuetudini provinciali al diritto romano e viceversa. Tutto ciò si presta a particolari approfondimenti per l’Egitto e per il vicino oriente antico a causa delle importanti e recenti scoperte papiracee. Del resto si è detto di quel processo che progressivamente spostò l’asse dell’interesse imperiale verso oriente. In questo senso si possono leggere ad esempio la persistenza delle unioni endogamiche e dei matrimoni adelfici in Egitto (assolutamente vietati ai cittadini romani), perlomeno sino ad una costituzione di Diocleziano e Massimiano del maggio 295 che intervenne a vietarli; e d’altra parte i nuovi cittadini dopo la Constitutio antoniniana utilizzarono schemi contrattuali propri del diritto romano (emptio, venditio e fidepromissio) a loro più favorevoli, come attestano i papiri in greco del medio Eufrate di recente pubblicazione. Per quanto riguarda l’Occidente il piano di lettura sembra essere apparentemente meno complesso in quanto il diritto romano non pare concorrere con istituti e modelli negoziali di natura locale ma è bene sottolineare come forme di diritto arcaico e consuetudinario abbiano continuato a sopravvivere, come l’ordalia, strumento di giudizio legato al mondo magico-popolare pagano almeno sino al IV secolo d.C. in aree decentrate come la Britannia e la Sardegna.
Con l’accesso alla cittadinanza di centinaia di migliaia di nuovi cittadini dovettero essere adottati una serie di meccanismi per decentrare presso sedi locali l’attività di registrazione che poté essere facilitata dalla pratica quinquennale dei censimenti cittadini; ciò in primo luogo per contenere il pericolo di frequenti usurpazioni della cittadinanza che già a partire dal periodo precedente si era tentato di arginare attraverso una rigida procedura. Dalla Tabula Banasitana sappiamo che l’editto imperiale veniva trascritto, seguendo la procedura in uso, sul Commentarius civitate Romana donatorum, il registro custodito nell’archivio imperiale a Roma, presso il tabularium principis sul Palatino, ciò dopo l’emanazione della Constitutio avrebbe creato seri problemi di ricezione e conservazione dei documenti, all’interno della sola sede romana, per quanto possa ammettersi un ruolo anche per il nostro tabularium senatorio.
Il rapporto documentario abbastanza solido tra la clausola di salvaguardia del Papiro di Giessen 40 e quella della Tabula Banasitana pone con decisione il tema della doppia cittadinanza, la contemporanea appartenenza alla patria d’origine (soprattutto se essa era una civitas peregrina), ed alla communis patria, Roma. D’altro canto il provvedimento di Caracalla, che chiude l’età degli Antonini e che nella visione già di Settimio Severo doveva aprire un nuovo secolo d’oro, si inserisce all’interno di un quadro sociale e politico assai complesso e dominato da una varietà di situazioni: rapporti tra Roma e le comunità locali, risvolti amministrativi e giuridici che ne derivavano, autonomia municipale, ruolo delle élites locali, organizzazione interna di alcune gentes, differenze culturali nella ricezione del potere tra province occidentali e orientali.
Due scuole di pensiero si sono fronteggiate su questo tema, quella di Mitteis, Arangio-Ruiz e Luzzatto che hanno interpretato la Constitutio antoniana nel senso di una affermazione totale e pervasiva del diritto romano sui diritti nazionali che erano destinati inevitabilmente a soccombere. “Il vigore ufficialmente esclusivo del diritto romano – scriveva Arangio-Ruiz – risulta chiaro dagli sforzi che tutto sommato le persone dei documenti fanno per richiamarvisi e adeguarvisi”. Ciò per certi versi è pur vero ma oggi tale interpretazione appare eccessivamente rigida e formale, anche perché non tiene conto della pluralità di situazioni geografiche, culturali, sociali sulle quali la generalizzazione della civitas romana andava ad incidere; del resto la romanizzazione non assunse ovunque le stesse caratteristiche, ma cercò localmente un equilibrio con i livelli di organizzazione politica coi quali si trovò a confrontarsi. Uno degli aspetti più significativi della romanizzazione fu l’estrema flessibilità, il tentativo di rispondere ad esigenze culturali particolari, frutto di tradizioni stratificatesi nel tempo, come nel caso dell’Egitto e delle province orientali. Occorre sottolineare che anche in Africa, la provincia che aveva dato i natali a Settimio Severo, si manifestò l’esigenza di mediare il rapporto tra peregrini e cives, tra comunità romane e comunità peregrine, ancora all’indomani della Constitutio Antononiana.
Di contro studiosi come Segrè, Schoenbauer, seguiti dal De Visscher dal Wenger ed in parte dal Taubenschlag hanno prospettato, con il conforto dei documenti papiracei il persistere, soprattutto nelle provincie orientali, dei politeumata locali accanto al diritto romano. Il Modrzejewski ha sfumato i termini della disputa escludendo l’equazione: civitas romana-civitas peregrina, diritto romano-diritto privato; in realtà la sopravvivenza di alcune consuetudini locali gli appare un fatto innegabile, che però non si tradusse né in un conflitto né in una giustapposizione con il diritto romano; a suo giudizio “le tradizioni locali di origine peregrina si mantengono in quanto diritto sussidiario di portata limitata, con la riserva della priorità accordata al ius civile romano”. Del resto su questa linea si pongono gli studi più recenti come quello di Marotta per il quale: «l’esistenza della doppia cittadinanza, prima della Constitutio Antoniniana è un dato empirico solitamente accettato dagli studiosi: sicuramente più difficile, al contrario, fornire un’adeguata spiegazione di questo fenomeno sul piano giuridico», allo stesso tempo lo studioso insiste sullo sviluppo del concetto di communis patria, passato a designare dall’ambito chiuso dell’urbs di epoca repubblicana la comunanza di ruolo e di diritti tra le singole civitates e l’urbs, in rapporto con l’orbis; egli dedica un intero capitolo al rapporto tra diritto imperiale e diritti locali.
Credo sia questo poi il senso della formula civitas augescens, di quel processo di progressivo ampliamento dell’area romana e del tentativo di equilibrare il rapporto tra cives e peregrini valorizzando il senso di comunità, di orbis, di oikouméne. Del resto Dione Cassio in epoca severiana retrodatava almeno fino all’età di Augusto il tema della civitas e della communis patria: se fa pronunciare a Mecenate il discorso sul definitivo tramonto dell’istituto monarchico nel quale il consigliere suggerisce ad Augusto di concedere la cittadinanza a tutti i sudditi, in modo che essi si sentano veramente parte di un’unica urbs, Roma. Il tema è ovviamente quello dell‘Encomio a Roma di Elio Aristide, che raffigura sul piano ideologico un impero universale alla cui unità e stabilità tutti dovevano concorrere. L’era di pace e di prosperità realizzata dagli Antonini rappresenta forse il momento più alto del mondo antico, per quanto l’equilibrio raggiunto ci appaia solo apparente: con l’anarchia militare del III secolo la stabilità dell’organizzazione sociale ed economica, fondata su un ceto di governo assai ristretto, sarebbe esplosa con drammatica evidenza.
Possiamo solo percepire vagamente la complessità della problematica e la ricchezza delle diverse realtà provinciali. Per l’Egitto il Segré notava che il diritto romano applicato agli Egiziani dopo la Constitutio non era il diritto romano vero: il diritto dei novi cives delle provincie ellenistiche constava di leggi romane, di leggi romane modificate dall’influenza delle leggi ellenistiche e di leggi ellenistiche vere e proprie. A parte la specificità egiziana, anche nelle altre province il provvedimento di Caracalla non chiude una volta per tutte il problema della doppia cittadinanza, se è vero che nel IV e nel V secolo continuò l’uso di concedere alle popolazioni barbariche stanziate all’interno dell’impero di vivere secondo il proprio diritto: è ad esempio il caso dei Visigoti nell’età di Teodosio.
Ma senza arrivare ad età così bassa, c’è da osservare che un indizio della sopravvivenza di comunità di peregrini all’interno di province di antica romanizzazione potrebbe essere documentato negli anni immediatamente successivi all’editto dalla pratica di concedere a puro titolo onorifico il titolo di municipio o di colonia di cittadini romani a città indigene. I casi sarebbero moltissimi e in questa sede mi limiterò a citare l’esempio di Uchi Maius (l’attuale Henchir Douamis in Tunisia), dove si svolgono attualmente le ricerche epigrafiche dell’Università di Sassari e dell’Institut National du Patrimoine di Tunisi da me dirette assiene a Mustapha Khanoussi. Circa vent’anni dopo la Constitutio Antoniniana de civitate, in occasione dei decennali di Severo Alessandro, la città numida di Uchi Maius continuava a vivere il problema dei rapporti tra cittadini romani e peregrini, dato che solo nel 230 d.C. si svolse la deductio della colonia di cittadini romani, ad opera di [L.] Caesonius Luc[illus] (Macer Rufinianus) legato e vicario del proconsole d’Africa: non si sarebbe trattato di una vera e propria deduzione coloniaria, ma di una semplificazione istituzionale, che avrebbe portato gli Uchitani indigeni (ormai tutti o quasi tutti cives) allo stesso livello degli eredi della colonizzazione mariana ed augustea, privilegiati almeno sul piano fiscale.
Il caso di Uchi è dunque paradigmatico dello sviluppo nel tempo dei rapporti tra indigeni ed immigrati, ma più ancora tra peregrini e cives, con una tendenza ad un progressivo ampliamento della categoria dei cittadini, aperta anche al contributo delle élites locali dal castellum numida al pagus ciuvium romanoum e alla colonia. Al di là delle regole teoriche e delle formule giuridiche, appare evidente come nei fatti la situazione fosse alquanto più complessa e variabile, a seconda delle località e dei periodi. Un vero e proprio equilibrio tra peregrini e cittadini non fu mai raggiunto definitivamente, ma fu sempre soggetto ad un lento processo di adeguamento e di integrazione.
Ed ecco allora che dalla communis patria intesa con significato quasi restrittivo da parte di Cicerone nella difesa di Cornelio Balbo di Gades accusato di aver usurpato la cittadinanza, nell’ultimo secolo della repubblica: Duarum civitatum civis noster esse iure civili nemo potest”, ed ancora: “sed nos non possumus et huius esse civitatis et cuiusvis praeterea” si passa progressivamente, già al principio dell’età imperiale, al tema di una communis patria diffusa, una sorta di villaggio globale dell’antichità. Ciò naturalmente senza voler banalizzare mutamenti che furono difficili e dolorosi. Il senso di appartenenza del civis romanus e la consapevolezza di possedere un diritto, la civitas, reso prezioso dalla sua esclusività è elemento capace di caratterizzare antropologicamente il romano e ciò per tutta l’epoca repubblicana: si prendevano provvedimenti ad personam per insignire della civitas romana personaggi di spicco del mondo culturale e politico locale, cittadini di città magnogreche come ad esempio il poeta Archia. Tale modo di procedere proseguì con Augusto che pur essendo, secondo la testimonianza di Svetonio, assai prudente in tema di concessione della cittadinanza attribui la civitas romana optimo iure optimaque lege, sulla base della legge Munatia Aemilia del 42 a.C., al navarca Seleuco, già cittadino di Rodi, a sua moglie, ai genitori, ai figli e ai discendenti che vennero esentati da prestazioni gravanti sui loro beni, dal servizio militare, da liturgie pubbliche ed inoltre potevano rivestire, se volevano, cariche e sacerdozi locali.
Non è certamente un caso, anche se alcuni studiosi tendono ingiustamente a confinare tale aspetto, che il superamento di una prassi giuridica restrittiva in tema di accesso alla civitas si debba ad un imperatore africano con ascendenze siriache per parte di madre, abituato a girare l’orbis allora conosciuto con le sue legioni composte da soldati provenienti da diverse province dell’impero, ossia un perfetto romano cosmopolita del suo tempo, abituato sin da piccolo a spostarsi tra Roma e le provincie.
In una prospettiva più storica ritengo allora che si debba considerare il quadro complessivo della formazione di Antonino Caracalla la sua raffinata educazione letteraria con le lezioni di Filostrato, filosofica con Antipatro di Ierapoli e giuridica con Papiniano, maestri che la madre Giulia Domna aveva scelto come precettori per i figli e i nipoti. Del resto gli interessi intellettuali di Giulia Domna, fecero della corte severiana un centro culturale di grande vivacità, dove gravitavano anche scrittori naturalisti del calibro di Eliano e probabilmente lo stesso Galeno. Ciò che fa più riflettere è la presenza a corte, nel ruolo istituzionale di prefetto del pretorio dei giuristi Papiniano e del suo successore Ulpiano; non escluderemmo che in qualche misura abbiano avuto un ruolo nell’elaborazione, soprattutto Ulpiano, dell’editto de civitate per la parte che riguarda l’ispirazione relativa alla prospettiva fiscale del provvedimento che si rendeva necessaria nell’ottica imperiale e del consilium principis come pure nell’ottica di Giulia Domna -da sempre molto legata al figlio- per sopperire alla penuria di risorse e alle spese militari. D’altra parte la critica troppo partigiana di Dione Cassio dimostrerebbe proprio in virtù della sua unidirezionalità che oltre la politica fiscale dovettero esservi altre ragioni di tipo ideale alla base della concezione della Constitutio, prima fra tutte la volontà di Antonino Caracalla di portare a termine il progetto paterno di valorizzare le province e di allargare la base di consenso con l’immissione nella cittadinanza dei nuovi Aurelii.
La Constitutio Antoniniana fu dunque la risposta che uno degli imperatori africani ritenne di dover dare alle istanze dei provinciali, cioè dei gruppi che lo avevano portato al potere, un primo importante passo verso l’eguaglianza nei diritti e nei doveri che costituisce il nucleo di ogni cittadinanza antica e moderna. Certo i problemi di convivenza tra cittadinanze di antica tradizione e nuove cittadinanze continuarono a persistere ma mi piace concludere ricordando che la straordinaria risposta che in antico venne data al problema della cittadinanza con l’emanazione della Constitutio antoniniana de civitate del 212 d.C. e la concessione della cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell’impero potrebbe servire a suscitare una riflessione nel nostro paese a proposito di una legislazione sui migranti che deve mettersi al passo con i tempi: il primo problema giuridico da risolversi pare quello dell’attribuzione della cittadinanza ai figli degli immigrati, nati in Italia, sulla base dello ius soli.
 Luciano di Samosata nella sua arguta opera Come si deve scrivere la storia (che non dimostra i suoi duemila anni) racconta con un po’ di riprovazione e di aristocratico distacco la celebre pazzia degli abitanti di Abdera, una città della Tracia: <<Dicono che durante il regno di Lisimaco, una malattia colpì gli Abderiti: dopo esser andati a teatro e aver sentito l’attore tragico Archelao che recitava l’Andromeda di Euripide, dapprincipio tutti in massa presero la febbre, forte e persistente; poi, intorno al settimo giorno, alcuni versarono abbondante sangue dal naso, altri si coprirono di sudore, che li liberò dalla febbre. Ridussero però le loro menti in uno stato pietoso.
Luciano di Samosata nella sua arguta opera Come si deve scrivere la storia (che non dimostra i suoi duemila anni) racconta con un po’ di riprovazione e di aristocratico distacco la celebre pazzia degli abitanti di Abdera, una città della Tracia: <<Dicono che durante il regno di Lisimaco, una malattia colpì gli Abderiti: dopo esser andati a teatro e aver sentito l’attore tragico Archelao che recitava l’Andromeda di Euripide, dapprincipio tutti in massa presero la febbre, forte e persistente; poi, intorno al settimo giorno, alcuni versarono abbondante sangue dal naso, altri si coprirono di sudore, che li liberò dalla febbre. Ridussero però le loro menti in uno stato pietoso.
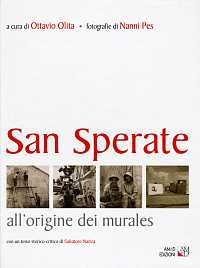 La lunga primavera di San Sperate è iniziata quaranta anni fa, nel 1968, all’indomani del viaggio di Pinuccio Sciola in Spagna e poi nella Parigi sconvolta dal vento della contestazione del maggio studentesco e poi in Messico, alla ricerca di una dimensione mitica immaginata e desiderata a lungo: con questo volume curato da Ottavio Olita siamo condotti per mano attraverso le interviste dei tanti protagonisti di allora a riscoprire le ragioni per le quali il paese contadino del Campidano è uscito da un sonno millenario, quando i suoi abitanti tutti all’improvviso si sono appassionati di arte, hanno scelto la rivoluzione del sorriso, hanno compiuto un percorso culturale che è stato anche un’esperienza collettiva che possiamo riconoscere ormai entrata nella storia della Sardegna.
La lunga primavera di San Sperate è iniziata quaranta anni fa, nel 1968, all’indomani del viaggio di Pinuccio Sciola in Spagna e poi nella Parigi sconvolta dal vento della contestazione del maggio studentesco e poi in Messico, alla ricerca di una dimensione mitica immaginata e desiderata a lungo: con questo volume curato da Ottavio Olita siamo condotti per mano attraverso le interviste dei tanti protagonisti di allora a riscoprire le ragioni per le quali il paese contadino del Campidano è uscito da un sonno millenario, quando i suoi abitanti tutti all’improvviso si sono appassionati di arte, hanno scelto la rivoluzione del sorriso, hanno compiuto un percorso culturale che è stato anche un’esperienza collettiva che possiamo riconoscere ormai entrata nella storia della Sardegna.
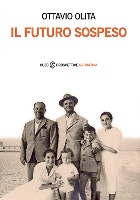 Questo romanzo di Ottavio Olita è soprattutto una storia vera di vita e di amore. Amore innanzi tutto per la Sardegna, per la città del sole, Cagliari, per il suo lavoro, per la famiglia, per i figli, specialmente per la nuova donna, la Gaia del romanzo, alla quale è legato da un rapporto dolce e amaro, fatto di intesa profonda ed ora anche di riconoscenza senza confini.
Questo romanzo di Ottavio Olita è soprattutto una storia vera di vita e di amore. Amore innanzi tutto per la Sardegna, per la città del sole, Cagliari, per il suo lavoro, per la famiglia, per i figli, specialmente per la nuova donna, la Gaia del romanzo, alla quale è legato da un rapporto dolce e amaro, fatto di intesa profonda ed ora anche di riconoscenza senza confini. Oggi in questa cerimonia si incontrano tre storie lunghe, tre storie parallele: la storia dell’Università, la storia del Comune di Sassari, la storia dei Gremi e dei candelieri raccolti nella pittoresca Faradda.
Oggi in questa cerimonia si incontrano tre storie lunghe, tre storie parallele: la storia dell’Università, la storia del Comune di Sassari, la storia dei Gremi e dei candelieri raccolti nella pittoresca Faradda. Mi sono chiesto che senso può avere oggi l’inaugurazione del nuovo museo nazionale garibaldino nella fortezza di Arbuticci, a Caprera, proprio di fronte alle Bocche di Bonifacio: la nuova struttura progettata dall’arch. Pietro Carlo Pellegrini, fortemente voluta dall’Istituto Nazionale di studi di G. Garibaldi, dal Sen. Mario Birardi, dalla Fondazione Banco di Sardegna e dall’Associazione delle Casse di risparmio, in occasione delle celebrazioni dei 150 anni dall’Unità d’Italia, diventerà un polo vitale di un più ampio museo nazionale diffuso solo se non sarà un memorale tradizionale, se guarderà avanti, se si collegherà con il Compendio Garibaldino e la Casa Bianca, con la Casa Manno in Alghero, con le Università della Sardegna, che rappresento anche a nome del Rettore dell’Ateneo cagliaritano Giovanni Melis.
Mi sono chiesto che senso può avere oggi l’inaugurazione del nuovo museo nazionale garibaldino nella fortezza di Arbuticci, a Caprera, proprio di fronte alle Bocche di Bonifacio: la nuova struttura progettata dall’arch. Pietro Carlo Pellegrini, fortemente voluta dall’Istituto Nazionale di studi di G. Garibaldi, dal Sen. Mario Birardi, dalla Fondazione Banco di Sardegna e dall’Associazione delle Casse di risparmio, in occasione delle celebrazioni dei 150 anni dall’Unità d’Italia, diventerà un polo vitale di un più ampio museo nazionale diffuso solo se non sarà un memorale tradizionale, se guarderà avanti, se si collegherà con il Compendio Garibaldino e la Casa Bianca, con la Casa Manno in Alghero, con le Università della Sardegna, che rappresento anche a nome del Rettore dell’Ateneo cagliaritano Giovanni Melis.