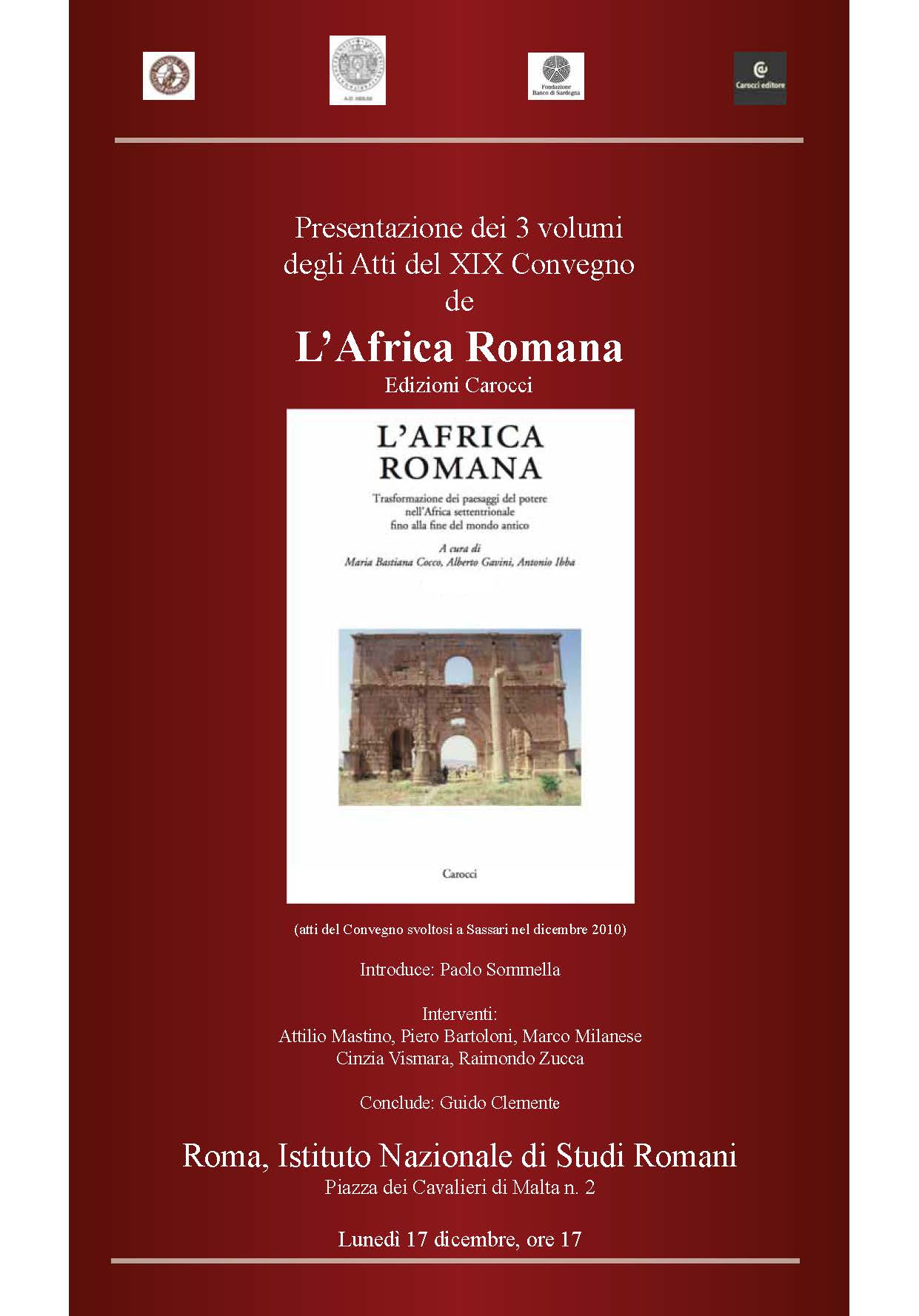Intervento del prof. Attilio Mastino
Venerdì 21 dicembre 2012
Cerimonia degli auguri di fine anno
Cari amici,
in occasio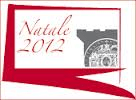 ne dell’inaugurazione del 451° anno accademico, un mese fa, il 9 novembre, abbiamo presentato il bilancio dell’ultimo triennio, che è stato pieno di impegni e di iniziative, portate avanti dagli organi accademici, dai delegati, dal Direttore Generale, dai docenti, dal personale tecnico e amministrativo, dagli studenti. Gli obiettivi raggiunti dai nostri ricercatori e da tutti i nostri colleghi sono numerosi; e in questi ultimi giorni abbiamo ritirato premi e riconoscimenti nazionali, come quello di Italia Camp per i farmaci naturali PHA.RE.CO., alla presenza del Presidente Monti.
ne dell’inaugurazione del 451° anno accademico, un mese fa, il 9 novembre, abbiamo presentato il bilancio dell’ultimo triennio, che è stato pieno di impegni e di iniziative, portate avanti dagli organi accademici, dai delegati, dal Direttore Generale, dai docenti, dal personale tecnico e amministrativo, dagli studenti. Gli obiettivi raggiunti dai nostri ricercatori e da tutti i nostri colleghi sono numerosi; e in questi ultimi giorni abbiamo ritirato premi e riconoscimenti nazionali, come quello di Italia Camp per i farmaci naturali PHA.RE.CO., alla presenza del Presidente Monti.
Sono convinto che un buon amministratore non può essere mai interamente soddisfatto dei risultati raggiunti, eppure abbiamo sentito giorno per giorno il senso di una missione condivisa, l’orgoglio di un’appartenenza, il percorso comune che ci ha visto impegnati su tanti fronti alla ricerca di sinergie e di alleanze. Ho avuto ed ho il privilegio di guidare una nutrita pattuglia di collaboratori competenti e motivati, che hanno operato e operano con grande autonomia e senso dell’istituzione. Oggi molti di loro sono assenti per poter rappresentare l’Ateneo in altre sedi come il Prorettore Donatella Spano a Cagliari nel Comitato tecnico regionale della legge 26, rinunciando ad essere presente con noi per un impegno di fine anno dal quale giungeranno ulteriori risorse.
Dopo tre anni di attività, dunque, sentiamo ancora più forte il dovere di un impegno ulteriore, se possibile più determinato e serrato, orientato ad indicare prospettive e indirizzi, pesando il contributo di tutti e suggerendo strade nuove per il futuro, con la voglia di non rinunciare a crescere e di riuscire a coinvolgere tutti i colleghi, anche quelli più demotivati, in un momento decisivo di crisi, ma anche pieno di opportunità e di speranze. In questi giorni, la discussione sul bilancio 2013, con le sue luci e le sue molte ombre, è stato un momento di presa di coscienza di nuove difficoltà che investono tutti gli Atenei italiani, con una drastica riduzione delle entrate ministeriali, ma anche con una vigorosa ripresa degli investimenti grazie ai fondi FAS. Il fatto che il Consiglio di Amministrazione non abbia potuto approvare il bilancio triennale, abbia dovuto attingere all’avanzo per assicurare un equilibrio di bilancio e abbia posto precisi limiti alle nuove assunzioni è un segno di una difficoltà che condividiamo con quasi tutte le Università anche per precise responsabilità del Ministro e della Conferenza dei Rettori. Eppure l’approvazione del bilancio per l’anno prossimo ha testimoniato la fiducia che è riposta in noi e l’impegno per lavorare in positivo per monitorare prestazioni e risultati di tutti.
Dopo le celebrazioni dei nostri 450 anni dalla nascita nel 1562 del Collegio Gesuitico, dopo la visita del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e del Presidente della Camera dei Deputati Gianfranco Fini, è venuto veramente il tempo di guardare al futuro, di segnare i percorsi di una ripartenza. Non avremo paura del cambiamento, indicheremo nuove frontiere e cercheremo migliori percorsi per tutti.
Ci presentiamo a questo tradizionale appuntamento della cerimonia degli auguri davvero con l’emozione del primo giorno, con la preoccupazione di non riuscire a rispondere alle attese che ci accompagnano, con l’entusiasmo per l’orizzonte che abbiamo davanti e che va ben oltre i due anni residui del mio mandato, ma che si spinge oltre, verso il 2020, in una continuità ideale con l’azione svolta anche da tutti i Rettori che mi hanno preceduto, partendo da Antonio Segni nel secondo dopoguerra, fino ad Antonio Milella, Giovanni Palmieri, Alessandro Maida, ai quali ultimi ci lega un sentimento di gratitudine profonda. Soprattutto guardiamo ai giovani, ai tanti impegnati in questi giorni nel concorso nazionale per le abilitazioni, e soprattutto ai nostri ricercatori a tempo determinato, agli assegnisti, ai dottorandi, agli specializzandi, perché il futuro del nostro Ateneo è ora veramente nelle loro mani. Le nostre decisioni debbono tener conto innanzi tutto di loro, che chiamiamo a raccolta verso obiettivi alti di successo e di sviluppo comune.
Vogliamo estendere le collaborazioni, in sede locale, con l’Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” di Sassari, il Conservatorio di Musica “Luigi Canepa”, il Centro Universitario Sportivo, il Circolo ricreativo dell’Università, le Associazioni studentesche, i Goliardi, l’Associazione ALAUNISS (Associazione dei laureati nell’Università di Sassari), l’Associazione dei dottorandi e dei dottori di ricerca ADI, l’ERSU dopo la ricostituzione della Commissione mista, la Regione, le istituzioni locali, i Sindacati; così come rilanceremo la collaborazione con il Garante degli studenti. Più in generale, vogliamo stipulare nuovi accordi di cooperazione accademica con l’Ateneo federato di Cagliari e poi con altri Atenei, in sede nazionale e internazionale. Del resto, la prospettiva di una collaborazione di prossimità con l’Università di Cagliari non può oscurare la necessità di migliorare le tante potenzialità esistenti, i rapporti storici del nostro Ateneo con altre Università italiane, come con Pavia e Parma, con lo IUAV di Venezia, sulla nautica con Pisa e Genova, per l’Industrial Liaison Office con Milano Bicocca e ancora Genova.
Questi sono i tempi della valutazione e della premialità: lasceremo da parte ogni accento critico sul sistema di valutazione messo in campo dall’ANVUR per confrontarci ogni giorno con equilibrio, senza complessi di inferiorità ma consapevoli delle nuove responsabilità che ci vengono assegnate in un momento di crisi.
Vogliamo lasciarci rapidamente alle spalle i numerosi conflitti nati tra i nuovi dipartimenti per l’attribuzione di personale, di spazi, di biblioteche, di attrezzature, di aziende, di laboratori, di centri interdisciplinari. Abbiamo superato la fase più critica ed ora occuperemo le nuove sedi, come l’ospedale di Santa Chiara in Alghero. Lavoreremo per stabilizzare la riforma statutaria, senza mitizzare le soluzioni adottate, cercando di risolvere le situazioni di disagio e di ascoltare il parere di tutti, favorendo la libera scelta di adesione ai 13 Dipartimenti. Costituiremo altre strutture di raccordo e vareremo il nuovo modello istituzionale di Università secondo gli indirizzi ministeriali, interpretati in senso molto innovativo.
L’Università si trova oggi ad affrontare una situazione molto diversa rispetto al passato, anche recente, che presenta aspetti di forte instabilità e segnali di involuzione La complessità organizzativa che ne scaturisce è caratterizzata da autonomia gestionale ma con risorse tendenzialmente sempre meno disponibili, con una richiesta di servizi qualitativamente più elevati nei settori strategici, con una forte competizione nel settore della ricerca, nel quadro di una spietata concorrenza sul mercato nazionale ed internazionale della formazione universitaria, con nuove opportunità disponibili.
Vogliamo ora stimolare processi virtuosi e far crescere l’Ateneo tenendo conto della sua storia secolare, della sua complessità, della sua ricchezza di contenuti umani e scientifici: un Ateneo europeo proiettato anche nel Mediterraneo, di qualità, capace di misurarsi in un confronto internazionale, ma fortemente radicato nell’isola.
Vogliamo sostenere le persone che operano nella nostra Università nell’affrontare le incertezze e il mutamento, perché il cambiamento deve essere vissuto come sfida positiva. Per costruire un assetto organizzativo sempre più centrato sui bisogni degli utenti, sugli obiettivi istituzionali e sulle esigenze delle persone, chiederemo a tutti uno sforzo e un impegno sostenibili.
Il cambiamento deve essere attuato con le persone e non sulle persone, in modo da costruire un’organizzazione in cui tutti gli attori ricoprano un ruolo significativo, ai diversi livelli, nel perseguimento degli obiettivi e nell’attuazione della missione istituzionale.
Il processo di cambiamento che l’Università si trova inevitabilmente ad affrontare è anzitutto un cambiamento culturale, in quanto riguarda in primis i valori e gli orientamenti; e questo implica una maggiore consapevolezza da parte di tutti gli attori impegnati nella didattica, nella ricerca, nelle attività direzionali e in quelle tecniche e amministrative.
Le azioni per il cambiamento dovranno avere tre direttrici:
– la valorizzazione delle competenze professionali;
– lo sviluppo delle motivazioni individuali;
– l’integrazione delle professionalità.
Le azioni prioritarie, perseguendo obiettivi di risparmio e di buona amministrazione, assolutamente necessari di fronte alla crisi, sono:
– migliorare gli indicatori di performances che vengono utilizzati per ripartire le risorse statali e per attribuire le risorse alle strutture dipartimentali;
– favorire l’arrivo di risorse esterne, in particolare quelle europee;
– mettere a punto le politiche di reclutamento del personale, ponendo particolare attenzione agli equilibri di bilancio;
– valutare l’impatto finanziario relativo alla gestione ordinaria di tutte le strutture edilizie “a regime” e rispettare il programma di dismissioni deliberato dal CdA nel rispetto della normativa vigente in materia di vendita di immobili;
– individuare azioni volte al contenimento delle spese, programmando le attribuzioni finanziarie;
– accelerare la spesa per l’edilizia su fondi di avanzo vincolati.
Le politiche del personale coerenti con queste linee di azione:
– prevedono opportunità di crescita individuale, la creazione di nuove figure professionali e spazi per più soddisfacenti percorsi di carriera.
– richiedono un coinvolgimento diretto di tutto il personale e un forte investimento nelle attività di formazione e sviluppo.
– presuppongono un confronto corretto e trasparente con le organizzazioni sindacali.
L’Ateneo continuerà ad aprirsi all’Orientamento e agli scambi internazionali, lancerà programmi di mobilità per studio, per ricerche, per tirocini all’estero, continuerà a scalare le graduatorie nazionali, insisterà a investire nell’ERASMUS, anche in un momento nel quale dall’Unione Europea non arrivano messaggi rassicuranti in materia di borse. Miglioreremo i dati sulla mobilità internazionale studentesca in entrata e in uscita per studio e per tirocini, l’Ulisse, il programma di Ateneo per la mobilità extraeuropea. Continueremo a sviluppare, dopo questo primo semestre, il nuovo programma di partnerariato territoriale “Erasmus Placement in Sardinia”, finalizzato a promuovere l’offerta di tirocini presso amministrazioni, imprese, istituzioni, laboratori e studi professionali aventi sede nel territorio del Nord Sardegna per gli studenti universitari di altri paesi europei, che vogliano “spendere in Sardegna” la borsa ottenuta dalla loro università di appartenenza. Saranno oltre 200 gli studenti universitari di altri pesi europei che quest’anno studieranno presso il nostro Ateneo, frequentando i nostri corsi di studio o svolgendo dei tirocini presso imprese e istituzioni locali sotto la nostra guida accademica nel quadro delle attività finanziate con il programma Erasmus.
Inoltre lavoreremo all’interno delle reti interuniversitarie e ospiteremo a Sassari in primavera la Rete di eccellenza dei territori insulari RETI, Excellence Network Island Territories. Svilupperemo i rapporti nella Rete delle università catalane e nella rete di università mediterranee.
Attraverso la convenzione triennale con la Regione ci daremo nuovi obiettivi in attuazione della legge regionale 26/96, definendo un programma triennale condiviso che avrà lo scopo di armonizzare gli interventi nell’ambito del diritto allo studio e del riconoscimento del merito, della didattica e della ricerca, di base e applicata, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico alle imprese del territorio regionale, con interventi a favore dell’internazionalizzazione, del tutoraggio in entrata, in itinere e in uscita.
Intendiamo accrescere la qualità dell’offerta formativa e tagliare i corsi improduttivi, promuovere l’allineamento dei tempi della formazione universitaria a quelli medi delle altre regioni italiane e degli altri paesi europei, sostenere concretamente l’integrazione del sistema universitario alle realtà territoriali locali e il suo collegamento ai contesti internazionali più innovativi; infine promuovere attraverso un sistema di incentivazione premiale, la ricerca di base e applicata.
Intendiamo mobilitare consistenti investimenti sugli obiettivi strategici di medio e lungo termine nel campo dell’alta formazione e della ricerca: dunque i criteri per accreditare, se sarà possibile, i corsi di laurea fuori sede a Nuoro, ad Oristano, ad Olbia, l’internazionalizzazione del sistema universitario, la formazione permanente (con impiego delle risorse del FSE e dell’Assessorato regionale al Lavoro a valle del recente protocollo d’intesa sull’alta formazione) per master, corsi di aggiornamento, biblioteche, archivi, musei, servizi, politiche della ricerca, i finanziamenti per l’allestimento tecnologico legato alla didattica, i processi di certificazione e accreditamento, la residenzialità, il campus, la qualità ambientale dell’Università e delle residenze.
Il Sistema universitario regionale parte dal rispetto assoluto per l’identità e l’autonomia irrinunciabile di ciascun Ateneo storico. Eppure il futuro della nostra Università e la sua capacità di garantirsi risorse certe ed esigibili da parte della Regione sono per la gran parte legati alla capacità di “fare sistema”.
Con la città di Sassari vogliamo ascoltare, cogliere le ragioni della crisi, affermare valori condivisi, perseguire la sostenibilità del consumo di risorse economiche e naturali, combattere i fenomeni di disagio giovanile, lavorare per un nuovo modello di sviluppo urbano virtuoso.
Vogliamo raccogliere le osservazioni sulla necessità di conoscenza tecnologica e informatica diffusa, con un maggior interesse per le discipline dell’area ingegneristica, fisica e matematica.
L’Università in Città o la Città universitaria deve fondarsi su una continuità urbanistica tra Ateneo e Città concordata con l’ERSU, su una reciproca accettazione di valori e di prospettive, su un impegno comune per migliorare la qualità della vita non solo degli studenti e dei professori ma anche dei cittadini.
Ci batteremo per la polarizzazione dei siti universitari, per favorire la piena utilizzazione delle strutture, la realizzazione di campus per consentire la nascita di una vera comunità di studenti e docenti. Sotto questo profilo, ripensare ai tempi del lavoro e dello studio dentro l’Università può costituire un input per il rilancio stesso della vita urbana.
Il mondo della politica e dell’impresa deve allearsi con l’Università, nel rispetto dei ruoli e delle diverse competenze.
L’Università, con tanti suoi autorevolissimi esponenti, si deve collegare con il sistema delle autonomie locali, con le città della Sardegna e con le Province; deve rompere ogni residuo isolamento e deve attivare nuove forme di collaborazione e di coordinamento con il sistema delle autonomie locali e funzionali per dar vita ad appositi percorsi formativi.
L’Università è il valore aggiunto di un territorio che ha assoluta necessità di svilupparsi, un interlocutore fondamentale per le istituzioni che vogliano avviare nuovi percorsi di crescita, per l’economia e la piena occupazione in nuove filiere, sulla base di nuovi modelli di sviluppo.
Le stesse ricerche che si svolgono entro l’Università debbono assumere una visibilità maggiore e rendere fertile il territorio che ci accoglie, con l’incremento dei brevetti che si deve raggiungere anche grazie all’impegno dell’Ufficio per il trasferimento tecnologico.
Svilupperemo nuovi rapporti con il Comune, col progetto UniCittà, finanziato dal Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la Farmacia comunale, con la nascita del Polo delle identità. E poi i rapporti con il territorio, la Provincia e la CCIA attraverso Fabrica Europa, il nuovo Sistema culturale ambientale Nord Ovest della Sardegna-Golfo dell’Asinara, il Parco internazionale delle Bocche di Bonifacio.
Ad Alghero l’Ateneo chiede al Comune di concedere al Dipartimento di Architettura anche lo spazio centrale del complesso di Santa Chiara necessario per disporre di una Aula Magna, che al momento sarebbe invece destinato all’Archivio Storico. Un’Aula Magna è fondamentale per le esigenze didattiche del Dipartimento di Architettura, e diventerebbe anche l’Aula Magna della città di Alghero, in un rapporto sinergico fra studio universitario e vita cittadina che non dovrebbe mai mancare.
Rilanceremo le attività della Consulta sulla Cappellania universitaria, in occasione del 50° anniversario dal Concilio Vaticano II.
L’autonomia universitaria deve essere intesa come processo critico e non come acquisizione per sempre, in un continuo confronto interno e con le realtà circostanti. Innanzi tutto si deve costruire un rapporto trasparente con il territorio, perché l’Università deve sentire il dovere di giustificare e difendere pubblicamente le proprie scelte strategiche, ad esempio sul piano urbanistico, ma anche sull’organizzazione interna, sulle strutture didattiche, sul decentramento.
Anche la città deve crescere più velocemente e sentire la responsabilità di ospitare una prestigiosa università, estendendo le proprie offerte culturali, ampliando e qualificando la rete dei musei, con concerti, spettacoli, offerte culturali e con una elevazione della qualità della vita e degli incontri sociali, trasformandosi in un sistema urbano eco-sostenibile.
Arriveremo alla costituzione di un Forum sulle pari opportunità, politiche e studi di genere come luogo di elaborazione e di scambio tra la ricerca delle donne all’interno dell’Università e quella espressa dal tessuto culturale del territorio.
Tra le prime iniziative che si intendono portare avanti: a marzo l’incontro sul fenomeno vecchio e nuovo del Mobbing. Aspetti psicologici, psicopatologici e medico legali.
Il documento di programmazione elenca le iniziative previste per il Completamento del percorso di adeguamento regolamentare a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Statuto, con particolare riferimento a:
– adozione del Regolamento generale di Ateneo;
– adeguamento del Regolamento didattico di Ateneo al nuovo Statuto.
Riformeremo lo statuto sul tema delle pari opportunità e delle rappresentanze dei Dipartimenti in Senato.
Nelle prossime settimane procederemo alla consegna dei premi per i nostri migliori studenti, con altre iniziative volte a sostenere la politica del merito a favore degli studenti in corso che, al 31 luglio 2011, abbiano maturato il maggior numero di crediti e si siano distinti per la votazione media degli esami.
Per l’anno accademico 2013-14, l’Offerta didattica sarà per la prima volta predisposta dai 13 dipartimenti, con i corsi di studio, i master, le scuole di specializzazione, il Tirocinio Formativo Attivo. Discuteremo sul prossimo riavvio del Master di giornalismo, per il quale è in corso la trattativa con l’Ordine dei giornalisti. Ci confronteremo con le nuove norme relative all’accreditamento dei corsi di studio e delle sedi, con l’intendo di ridurre il numero dei corsi, di abbassare il numero degli studenti inattivi, di mantenere il trend positivo delle iscrizioni.
L’Ateneo ha acquisito la piattaforma U-Gov, che comprende il Sistema Informativo Esse3: un supporto indispensabile per predisporre, gestire e monitorare tutti i processi, dalle immatricolazioni e iscrizioni agli atti amministrativi connessi agli ordinamenti e regolamenti didattici, alla programmazione dell’offerta formativa, alla verbalizzazione automatica degli esami fino alla gestione delle carriere degli studenti, compreso il Post-Laurea e l’Alta Formazione. L’applicativo entrerà a regime con il prossimo anno accademico: obiettivo finale è la riprogettazione e successiva automazione di tutte le tappe del percorso universitario dello studente. Questo passaggio comporta una stretta integrazione tra il sistema di gestione dei documenti (TITULUS) e il sistema di gestione delle carriere studenti. Questo nuovo approccio prevede il monitoraggio delle carriere universitarie e la possibilità di interventi rilevanti nella ricognizione.
Particolare attenzione merita il tempestivo smaltimento delle pratiche studenti, in particolare quelle che prevedono la convalida degli esami e l’approvazione dei piani di studio.
L’Ateneo ha disposto il rilascio del Diploma Supplement (D.M. 509/1999) ai laureati.
Lavoreremo per ottimizzare l’utilizzo delle risorse di docenza e organizzare la IV Conferenza di Ateneo sulla didattica
Partirà il processo di Autovalutazione, Valutazione periodica e Accreditamento secondo quanto disposto dal documento approvato nel luglio 2012 dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR. Le azioni e i processi sono molto complessi e richiederanno il contributo delle strutture didattiche e di diversi Uffici dell’Amministrazione centrale. Sono previsti incontri dedicati con i molti partecipanti al processo e alcuni delegati rettorali.
Per le Scuole di dottorato, rafforzeremo ulteriormente il principio della valutazione e della premialità. Per quanto concerne l’internazionalizzazione dei dottorati, confermiamo il proposito di favorire la partecipazione di studenti stranieri consentendo loro di presentarsi alle procedure di valutazione senza onerosi spostamenti da aree spesso remote.
Abbiamo avviato le nuove procedure di valutazione delle Scuole di Dottorato in collaborazione con il Nucleo e l’Ufficio Pianificazione con la predisposizione di una scheda di autovalutazione.
A livello nazionale entreranno presto in vigore le nuove disposizioni relative ai dottorati che, immediatamente applicati, porterebbero al dimezzamento dell’offerta formativa, in termini di dottorati di ricerca del nostro Ateneo, e che pertanto saranno oggetto di un adeguato impegno organizzativo nel futuro immediato. Alcuni dei criteri proposti per la nuova normativa derivata dalla legge 240 avranno un forte impatto sull’attuale schema delle scuole. In particolare:
– la eliminazione delle scuole interdisciplinari dovuta alla indicazione precisa di denominazioni dei dottorati prossime a quelle dei settori scientifico disciplinari;
– la richiesta di almeno 6 borse disponibili per dottorato;
– la valutazione dei coordinatori e del collegio dei docenti;
– la stringente valutazione su strutture e mezzi messi a disposizione dei dottorandi.
Condizioni, queste, che potrebbero rappresentare gravi ostacoli alla prosecuzione della esperienza attuale nei termini che conosciamo. La soluzione possibile è da individuarsi nella sopravvivenza di alcune scuole, che però dovranno riconvertirsi in modo da poter rientrare nelle denominazioni definite dal Ministero e nella riconversione di scuole interdisciplinari in dottorati intersede o internazionali, dotati di forti competenze scientifiche riconosciute e valutabili. Tutto questo processo porterà inevitabilmente a delle scelte sulle risorse disponibili e, in questo senso, l’unico criterio possibile sarà rappresentato dalla qualità scientifica delle proposte. Il nucleo di valutazione e gli altri organi accademici svolgeranno quindi un ruolo fondamentale nel determinare criteri di giudizio validi.
È in programma, in collaborazione con l’associazione dottorandi e con i direttori delle scuole, una giornata di informazione e dibattito sull’attività delle scuole. Nel corso di tale incontro ci sarà modo di illustrare le principali attività dei dottorandi nelle diverse scuole, ma anche di dibattere problemi dell’attuale schema organizzativo e di considerare le prospettive future.
Il Centro Orientamento Studenti (COS) dell’Ateneo gestisce attività e programmi per sostenere le persone nella scelta degli studi universitari, per supportarne la carriera, per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro; predispone inoltre azioni informative e formative, incontri di orientamento e consulenze. Tra il 15 il 19 aprile organizzeremo la X edizione delle “Giornate dell’orientamento: studiare a Sassari e in Europa”.
Porteremo avanti i diversi progetti, tra i quali il Progetto STUD.I.O. (Studenti In Orientamento), finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna, dal POR-Fondo Sociale Europeo e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che interviene sulle difficoltà di accesso all’Università rilevate dagli esiti dei test di ingresso, sul ritardo negli studi universitari e sull’elevato numero di studenti fuori corso. Le azioni sono rivolte agli studenti delle ultime classi della Scuola secondaria superiore e alle matricole universitarie. Il Progetto è articolato in 3 linee d’intervento: a) raccordo con le Scuole; b) iniziative di potenziamento dell’orientamento universitario; c) strumenti di accompagnamento e supporto per studenti al primo anno del percorso universitario.
Sulla disabilità, cercheremo di risolvere l’annoso problema del servizio di trasporto da e per l’Ateneo dei nostri ragazzi e porteremo avanti il progetto sottoposto al MIUR che intende affrontare la problematica degli studenti con DSA (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia).
Sosterremo le attività autogestite dagli studenti, costituiremo l’albo delle Associazioni studentesche, al fine di promuove ulteriormente le iniziative culturali, sociali, sportive, ricreative proposte dagli studenti dell’Ateneo.
Riconosceremo la pratica sportiva come una delle componenti della formazione universitaria e svilupperemo il PROGETTO UNICITTÀ, promuoveremo l’Autofinanziamento del CUS, apriremo l’uso degli impianti, modificheremo la Convenzione col CUSI.
Verranno sviluppate le attività musicali universitarie, in collaborazione con il Coro dell’Università e il gruppo ICHNUSS.
Il Centro Linguistico si impegna con l’attivazione di corsi di lingua straniera per tutti i Dipartimenti dell’Ateneo e per il territorio (fondi POR), mentre vengono potenziati dappertutto i laboratori informatici e progettiamo il rilancio di Unitel Sardegna.
Ci aspettiamo risultati ancora straordinari nel campo della ricerca scientifica con il reperimento di nuove consistenti risorse e di nuove fonti di finanziamento, con un deciso avanzamento dell’Ateneo in campo regionale e nazionale, grazie ai progetti presentati, ai nuovi laboratori, al riconoscimento di competenze, talenti e opportunità. Alle tante idee che ormai sono in campo, dalla chimica verde all’agroalimentare, dalla biomedicina all’ambiente, dalle tecnologie informatiche alle discipline umanistiche, giuridico-economiche, dalle bonifiche ai bbcc e al patrimonio identitario. Parliamo di rientro dei cervelli, visiting, assegni cofinanziati, grandi progetti di Ateneo (Dottorati, ricercatori a tempo determinato, assegni di ricerca nell’ambito della conservazione e restauro dei beni culturali, assegni di ricerca in forma associata con enti di ricerca e imprese, laboratori).
In questo campo la legge regionale n. 7 del 2007 continuerà ad aprire nuove strade anche nel settore del trasferimento tecnologico.
Il Centro Servizi Grandi Attrezzature di Ateneo per la ricerca e il Centro interuniversitario sulle tecnologie per i beni culturali riceveranno a breve nuove risorse. Sosterremo il Centro interuniversitario sulla nautica con Pisa e Genova, e poi la collaborazione con l’area del CNR.
Tutto ciò segnerà un momento di importante modernizzazione delle strutture stesse della ricerca, che si accompagna al trasferimento del Centro Elaborazione Dati in via Rockefeller, nel quadro dei programmi rinnovati per l’Università digitale.
L’organizzazione e le procedure del sistema della ricerca d’Ateneo stanno subendo profonde modifiche a seguito dei cambiamenti introdotti dalla legge 240/2010. L’approvazione del nuovo Statuto ha declinato con chiarezza i principi della missione dell’Ateneo sulla ricerca e ha dato il via a un ampio processo di riorganizzazione della comunità scientifica delle diverse aree della ricerca con la costituzione dei nuovi Dipartimenti. La riorganizzazione passerà innanzi tutto attraverso i dipartimenti, con i Comitati per la Ricerca, istituiti, sulla base dello statuto, con il preciso compito di elaborare il piano della ricerca e di monitorare le performance del dipartimento. Potenzieremo la Commissione Ricerca, che svolge compiti istruttori, consultivi e propositivi, nei confronti degli organi di governo, ed elabora le proposte per la distribuzione delle risorse per la ricerca. Un più pressante impegno sarà quello del Nucleo di Valutazione, organo di valutazione interna, con il compito di verificare l’attività di ricerca dei dipartimenti e di elaborare le procedure di valutazione in raccordo con le direttive dell’ANVUR.
La programmazione e il processo decisionale della ricerca terrà conto della forte tendenza del MIUR a ribaltare sugli Atenei molte fasi critiche e onerose dei processi di valutazione e di assegnazione delle risorse (per esempio, invio prodotti e rapporti nell’ambito dell’esercizio VQR; gestione progetti di interesse nazionale, ecc.).
Questo quadro impone una forte sinergia fra i delegati, che ancor più devono condividere gli indirizzi strategici, trovare soluzioni operative e tecniche che consentano di migliorare il posizionamento dell’Ateneo nel sistema della ricerca internazionale, nazionale e regionale. Nell’ambito di Horizon 2020 si prospetta un progressivo potenziamento degli uffici dedicati ai fondi europei, a valle dell’attività formativa svolta nell’ultimo anno.
Il sistema regionale della ricerca si svilupperà con lo scopo di migliorare il posizionamento dell’Ateneo nelle reti nazionali e internazionali, di mettere a regime dei flussi di finanziamento per il reclutamento (ricercatori, assegni, dottorati), di completare i progetti infrastrutturali (laboratori, attrezzature), di trasferimento tecnologico (INNOVA.RE) e del piano di gestione e dei regolamenti di accesso alla strutture. Realizzeremo il sistema di valutazione della ricerca, miglioreremo le procedure per la distribuzione delle risorse e il reclutamento per l’attività di ricerca.
Con il mese di gennaio 2013 disdetteremo il contratto di comodato d’uso del Centro di Tramariglio con scadenza al 2014, dato che permangono diversi aspetti gestionali che devono essere perfezionati per rendere più chiari ed efficaci i rapporti di collaborazione fra le parti.
Il testo dell’accordo quadro tra le Università e CNR sarà rimesso in discussione su richiesta del nuovo Presidente del CNR. La revisione sarà effettuata anche attraverso il coinvolgimento della RAS e dei centri di ricerca.
In questo senso vanno le iniziative condotte dai delegati per il Museo Scientifico di Ateneo, l’Orto Botanico, il Sistema bibliotecario di Ateneo, reso autonomo e profondamente rinnovato, che ha necessità di superare rapidamente le attuali criticità legate ad una delicata fase di passaggio. Gli Organi Accademici continueranno a sostenere la crescita e lo sviluppo delle nostre Biblioteche, per quanto le prospettive finanziarie e politiche lo consentiranno. Siamo infatti consapevoli dell’importanza del ruolo da esse svolto e delle difficoltà crescenti, imposte in particolare da una progressiva riduzione della dotazione di personale strutturato. Siamo altresì convinti che la concezione stessa di servizio bibliotecario sia in rapida evoluzione, non solo per via dei progressi della tecnologia dell’informazione e della comunicazione, che renderà le biblioteche sempre più virtuali e delocalizzate e sempre meno condizionate dalla gestione del supporto cartaceo, ma anche in virtù del radicamento delle forme di condivisione reticolare delle conoscenze, delle esperienze e delle informazioni, di cui i social networks rappresentano espressione tangibile. Alcune nostre Biblioteche, del resto, assolvono già oggi, specialmente per gli studenti, funzioni che vanno al di là della mera erogazione di servizi di ricerca e prestito anche interbibliotecario, per spingersi fino alla vera e propria aggregazione e socializzazione tra studenti, colleghi e cittadini. Non si parla più, dunque, di depositi di libri in locali polverosi e austeri, ma di strutture multifunzionali di servizi multimediali nelle quali le informazioni e le esperienze sono condivise. Sarà nostro impegno supportare questa evoluzione funzionale, in modo da consentire alle Biblioteche ed al nostro Ateneo di intensificare le relazioni con il territorio e di enfatizzare le proprie funzioni istituzionali di produzione e diffusione della conoscenza
L’Ufficio di trasferimento tecnologico porterà avanti il progetto INNOVARE che prevede le seguenti azioni:
– consolidamento e rafforzamento della struttura tecnica organizzativa/gestionale esistente;
– creazione d’impresa;
– innovazione e trasferimento tecnologico nelle imprese esistenti, col bando per assegni di ricerca in azienda;
– strumenti per l’innovazione;
– archivi istituzionali ad accesso aperto. L’attività è in stretto collegamento con la Biblioteca Scientifica Regionale (BSR) ed ha lo scopo di ottimizzare gli Archivi istituzionali (P-arch, UniCA-Eprints e UniSSResearch).
Insieme agli enti del territorio è in atto l’avvio e la gestione di un incubatore universitario cittadino di impresa, di dimensioni ridotte, ma essenziale per dare impulso e valore aggiunto all’attività di creazione di imprese innovative, che è stata avviata con successo anche grazie alle sinergie territoriali create con la StartCup Sardegna.
L’Università di Sassari incentiverà la tutela brevettuale dei risultati della ricerca trasferendo il proprio potenziale tecnologico e promuovendo l’innovazione nelle imprese attraverso differenti attività, con funzioni di servizio e commerciale.
Nell’ambito della promozione della tutela della proprietà intellettuale, l’Università manterrà in portafoglio i brevetti dell’attuale lista, che comprende una decina di brevetti.
Nel campo delle grandi attrezzature, in questi giorni si procede ad impegnare nuove risorse e a completare i lavori per l’acquisizione di grandi apparecchiature, necessarie al corretto compimento di progetti di ricerca.
Si procede al monitoraggio delle partecipazioni universitarie nei Consorzi e Società consortili, con il proposito di riequilibrare i bilanci, siano progetti, convenzioni o contratti di servizio; e insieme agli altri soci pubblici l’Università vigilerà negli organi direttivi e nelle assemblee dei soci.
Per il prossimo biennio ci si propone di promuovere una politica proiettata al raggiungimento di una dimensione pienamente internazionale della formazione e della ricerca.
Si punterà pertanto a rafforzare le attività finora intraprese e ad attivare nuovi partenariati, tesi ad allargare le collaborazioni scientifiche e tecnologiche sia con i Paesi più vicini che con aree geografiche lontane e culturalmente diverse. Si promuoverà il nostro Ateneo all’estero, con il duplice obiettivo di attrarre studenti e di attuare progetti multiculturali di ampio respiro.
Crescente attenzione sarà rivolta alle politiche di reclutamento di studenti stranieri che si iscrivono presso i nostri Corsi di Laurea.
In quest’ottica, ci proponiamo di portare avanti azioni coordinate quali:
– potenziamento dei corsi di italiano per gli studenti stranieri;
– offerta di corsi di insegnamento erogati in lingua inglese. Essa può rendere più attrattiva la sede agli studenti stranieri e anche preparare e formare gli studenti italiani ad un’apertura verso il mondo scientifico e lavorativo a livello internazionale;
– istituzione di uno “sportello” per il miglioramento delle procedure legate al soggiorno di studenti, ricercatori e docenti stranieri nel nostro paese, per le problematiche legate ai visti di ingresso e alle norme di immatricolazione;
– istituzione di un sito web specifico perché vi sia la massima diffusione di tutte le informazioni sui principali temi dell’internazionalizzazione e della cooperazione accademica.
Si promuoveranno azioni di sostegno da parte della Regione Sardegna quali:
– istituzione di borse a favore di immatricolandi e giovani ricercatori stranieri;
– istituzione di progetti di cooperazione interuniversitaria internazionale.
Particolare attenzione sarà rivolta alla possibilità di istituire Corsi di Laurea a doppio titolo o titolo congiunto.
In campo informatico stiamo procedendo al Trasferimento dei servizi informativi nel nuovo stabile di via Rockefeller, dopo la realizzazione della rete metropolitana UNISS in fibra ottica, con utilizzo di fibre spente di proprietà comunale. Stiamo realizzando n. 6 aule informatiche di polo. Inoltre seguiamo la Migrazione di tutti i principali servizi verso la piattaforma CINECA U-GOV.
Nel prossimo biennio, saranno considerate problematiche che coinvolgono le attività informatiche ma che richiedono scelte e strategie più generali, come l’anagrafe della ricerca, la piattaforma WEB integrata di Ateneo, i servizi all’attività didattica (questionari per la valutazione della didattica, ed altro), i servizi agli studenti (per es., l’utilizzo delle aule informatiche), la formazione del personale, l’e-learning, l’università telematica ed altre proposte ed esigenze che potranno emergere dall’Ateneo o dall’esterno.
Attualmente le risorse finanziarie disponibili per i servizi informatici fanno riferimento a specifici progetti (POR laboratori, e, marginalmente, altri) di prossima scadenza, o a finanziamenti limitati nel tempo (legge regionale 26/96 per il triennio 2012-2014), ma, dato il loro carattere permanente, sarà indispensabile definire apposite poste di bilancio per il funzionamento ordinario e lo sviluppo, naturalmente in connessione con una strategia di utilizzo razionale delle risorse.
Sarà organizzata la II Conferenza informatica di Ateneo.
In collaborazione con l’AOU la medicina universitaria si trasformerà profondamente, in un orizzonte di programmazione e di risparmio, in piena sintonia tra Università e Direzione generale.
Pensiamo ad un percorso di integrazione e razionalizzazione dopo la istituzione dei tre Dipartimenti universitari di area medica e della Struttura di raccordo. La prossima istituzione dell’Organo di Indirizzo, l’emanazione dell’Atto Aziendale, i risultati della trattativa al tavolo tecnico, gli investimenti per il nuovo ospedale, le nuove attrezzature, dalla PET alla TAC, consentiranno alla AOU di Sassari di essere percepita come Azienda di riferimento per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Sarà pertanto possibile realizzare un’integrazione sinergica fra un’assistenza di eccellenza ed i compiti universitari della Facoltà di Medicina e Chirurgia, mediante l’articolazione di strutture semplici, di strutture complesse e dei Dipartimenti assistenziali integrati.
È ora indispensabile, previo il reperimento di nuove risorse, colmare gravi carenze tecnologiche che ancora impediscono alla AOU di Sassari di qualificarsi come struttura di eccellenza, anche se la recente acquisizione del Tomografo PET a 64 strati rappresenta decisamente un punto di svolta decisivo e testimonia una rinnovata attenzione della Regione dopo anni di abbandono.
È necessario acquisire alcune grandi attrezzature e supporti tecnologici e diagnostici, la cui mancanza sta producendo effetti negativi per il funzionamento e l’immagine dell’Azienda.
Si rende necessario certificare tutti i possibili Centri di Eccellenza a valenza per tutto il Nord Sardegna già esistenti o in via di istituzione.
Alcuni prossimi impegni:
– inventario dei beni immobili della AOU;
– Aavvio della trattativa per la chiusura del rapporto con la Fondazione Santa Maria Bambina di Oristano;
– test ammissioni ai corsi di laurea;
– accordi convenzionali con le AASSLL in Sardegna e in altre Regioni;
– corsi singoli per studenti di medicina;
– determinazione del percorso formativo per le professioni sanitarie;
– spese per professioni sanitarie (risorse regionali dal 2008);
– definizione del bisogno formativo per le professioni sanitarie;
– possibile trasferimento della U.O. di Neuropsichiatria infantile dal Policlinico Sassarese al VI piano del Palazzo Clemente (spesa 835 mila euro);
– costi del personale medico: richiesta della AOU alla Regione delle indennità assistenziali dovute ai medici. Ricorso al Consiglio di Stato e adempimenti successivi, calcolo delle indennità sanitarie da liquidare, accantonamento fondo rischi, richiesta rimborso Regione;
– ripartizione spese comuni con la AOU.
Porteremo avanti il programma edilizio AOU, rimodulato nel CdA del 26 settembre 2012, con la realizzazione degli ambulatori e del day hospital di Oncologia al piano terra della Seconda Stecca, gli spogliatoi centralizzati al sottopiano del Palazzo Clemente, la Ristrutturazione della parte del piano secondo (lato viale S. Pietro) del Palazzo Clemente, da destinare alle degenze della Clinica Neurologica, la realizzazione del nuovo reparto di terapia intensiva e rianimazione, nel rustico al piano terra fra la prima e la seconda stecca, e incremento degli spogliatoi e dei magazzini al piano seminterrato, al di sotto della nuova rianimazione, la ristrutturazione del piano secondo della palazzina della Clinica Neurologica, da destinare all’istituto di Neurologia.
Ulteriori iniziative in avvio o programmazione:
– sono già in fase di ultimazione le procedure per l’affidamento dei lavori per la nuova Rianimazione e per il nuovo Reparto di Neuropsichiatria Infantile (piano VI del Palazzo Clemente);
– è in fase di approvazione il piano esecutivo per le degenze della Clinica Neurologica e l’adeguamento antincendio (piano II del Palazzo Clemente);
Per il Palazzo Materno-Infantile sono previsti:
– adeguamento del blocco parto e adeguamenti antincendio del palazzo;
– risanamento della facciata principale;
– progetto di adeguamento dei laboratori diagnostici in vista di una futura centralizzazione;
– progetto di razionalizzazione dell’area parcheggi;
– progetto di razionalizzazione stoccaggio rifiuti ospedalieri negli spazi antistanti gli edifici didattico-assistenziali;
– il reparto di Rianimazione e terapia intensiva verrà trasferito negli “Edifici delle chirurgie”, piano terra, con una spesa superiore ai 2 milioni di euro.
– è inoltre prevista la programmazione della destinazione d’uso degli edifici dismessi, una volta completato il nuovo Ospedale.
Spenderemo i fondi FAS 2007/2013 per un importo totale di 182,75 milioni di euro a favore di Università, AOU, Accademia delle Belle Arti “Mario Sironi”, ERSU.
I macrointerventi previsti sono:
– 3.600.000 euro per il Potenziamento della didattica dei Dipartimenti (ex Facoltà) di Agraria;
– 3.600.000 euro per il Polo Agrario Veterinario;
– 18.000.000 euro per la realizzazione dell’Orto botanico e Completamento realizzazione Area Bionaturalistica;
– 7.000.000 euro per la costruzione nuova sede Dipartimenti (ex Facoltà) di Farmacia, complesso Monserrato;
– 9.000.000 euro per la realizzazione del nuovo Polo umanistico di via Roma – Dipartimenti (ex Facoltà) di Lettere e Lingue;
– 17.800.000 euro per la ristrutturazione dei palazzi dell’Amministrazione centrale, complesso piazza Università;
– 4.000.000 euro per la ristrutturazione della Sede dei Dipartimenti (ex-Facoltà) di Economia.
Il programma consentirà di risolvere i propri problemi edilizi per almeno un ventennio, pur se non sarà facile trovare i fondi necessari a gestire i nuovi spazi e le nuove esigenze, quali si configurano dalle richieste, destinate ad avere piena soddisfazione, dei nuovi dipartimenti. È da rimarcare, a questo proposito, che gli adempimenti edilizi richiesti dalla legge 240, in molti casi distruttivi per gli atenei, potranno essere portati a termine senza affanni, in una prospettiva a medio termine, consentendo una ricollocazione complessiva, organica e coerente dei poli didattici e scientifici in cui si articolerà l’università di Sassari.
Con il nuovo Ospedale veterinario ci prepariamo nel migliore dei modi alla visita della Commissione EAEVE, recentemente nominata, che nella prossima primavera valuterà il Dipartimento di Medicina veterinaria. Recupereremo rapidamente i ritardi accumulati per la nuova Azienda zootecnica di La Crucca.
Programmazione triennale 2012-14 ed Elenco annuale delle opere pubbliche dell’Università degli Studi di Sassari (CdA del 21 dicembre 2011):
– lavori di manutenzione straordinaria facciate Palazzo Ciancilla in piazza Conte di Moriana (euro 370.000);
– lavori di recupero edilizio e adeguamento normativo dell’edificio di via del Fiore bianco (euro 800.000)
– lavori di recupero edilizio e manuenzione straordinaria degli impianti sportivi in regione Ottava (euro 422.303);
– lavori di ristrutturazione, restauro conservativo e adeguamento nornativo dell’edificio di largo Porta Nuova (euro 4.000.000);
– lavori di completamento funzionale aree 4, 5, 6 e 7 del Polo naturalistico di Piandanna (euro 16.641.639);
– lavori di realizzazione di un edificio per nuove aule biblioteca e servizi generali della Facoltà di Agraria (euro 6.157.106)
– lavori di completamento finale nuovo reparto di malattie infettive euro 985.000.
Ulteriori iniziative in avvio o programmazione:
– installazione frangisole e tende finestrature Polo bionaturalistico (circa euro 200.000);
– Indagine strutturale edifici ex Estanco (circa 12.000 euro);
– Azienda Agraria Santa Lucia Oristano: realizzazione capannone per ricovero macchine agricole (importo lavori in fase di stima: circa euro 220.000);
– recupero dell’area ex-Orto botanico di via Muroni, al fine di creare una unica area verde nel complesso del Quadrilatero (importo lavori in fase di stima);
realizzazione parcheggi area Igiene, in accordo con piano particolareggiato P9 del Comune di Sassari (importo lavori in fase di stima: circa 500.000 euro);
– avvio piano per l’adeguamento normativo antincendio degli edifici universitari (importo in fase di stima, ma dell’ordine di alcuni milioni di euro);
– avvio piano per l’abbattimento di barriere architettoniche;
– avvio piano per il contenimento dei costi di gestione e manutenzione degli edifici, passando ad una manutenzione programmata;
– avvio procedure finalizzate al contenimento dei costi delle utenze elettriche, mediante ricorso al mercato dell’energia ed ad una politica di certificazione energetica degli edifici;
– avvio piano delle aree verdi, ludiche e sportive, per realizzare all’interno dei poli universitari zone attrezzate con prati e giardini, al fine di creare campus universitari urbani, con particolare riguardo alla implementazione delle aree verdi dell’Ateneo;
– ulteriori interventi sono previsti per le esigenze dettate dall’applicazione del Testo Unico in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro;
– per il parcheggio del Quadrilatero, si discuterà la attribuzione di tutti i parcheggi. Il Dipartimento di Agraria, in via dell’inizio dei lavori, propone di ottenere la disponibilità dello sterrato di Viale Italia. Altre richieste pervengono dal personale sanitario e dagli studenti.
– predisposizione di un quadro delle operazioni di dismissione del patrimonio. In merito all’Alienazione dei beni immobili e della messa a valore di strutture patrimoniali, a breve partirà il primo lotto di dismissioni, che comprenderà un immobile sito a Sassari, in via Muroni, e l’Azienda Sperimentale La Naciola, sita a Tempio Pausania (OT). Ed inoltre: Via Brigata Sassari, Corso Vittorio Emanuele, Piazza d’Armi, Vicolo Marchetto, eredità Ittiresu di Nulvi, terreni di Torralba, terreni di viale Italia e San Lorenzo di Sassari.
L’Ateneo si è dotato di una struttura organizzativa di Coordinamento delle attività di Comunicazione e di informazione, composta dagli Uffici Comunicazione, Relazioni con il Pubblico (URP) e dalla figura dell’Addetto stampa, inserita nella Segreteria del Rettore.
Attualmente siamo impegnati nello sviluppo del nuovo sito e sistema web di ateneo e nello studio della piattaforma CMS da utilizzare per il nuovo sistema. Inoltre è in fase di avanzata elaborazione un manuale di identità visiva di ateneo, che conterrà un insieme di norme, strumenti ed esempi che servono a uniformare, modernizzare e semplificare la rappresentazione dell’Ateneo in tutti i prodotti di comunicazione creati per l’interno e per l’esterno sui più diversi supporti (dalla carta al video, dal sito web, agli oggetti e agli allestimenti).
Si intende inoltre proseguire nell’attuazione del Progetto e-learning, “Il sistema di e-learning dell’Ateneo di Sassari”, che prevede l’estensione del servizio offerto dalla piattaforma a tutte le attività formative dell’ateneo. Questo attraverso l’organizzazione dell’intera offerta formativa nella piattaforma stessa, alla quale corrisponde la formazione consapevole degli attori in gioco: docenti, ricercatori, personale t.a. e studenti. In accordo con l’ufficio Organizzazione e Formazione, vi è la proposta futura di poter svolgere, attraverso l’uso della piattaforma, anche corsi per esterni a pagamento.
Per i prossimi mesi è in programma, da parte della struttura di Coordinamento delle attività di Comunicazione, la redazione del “Piano di comunicazione”, che rappresenta uno degli strumenti in grado di coniugare strategie, obiettivi, azioni e strumenti di comunicazione, secondo un disegno organico e razionale.
Cari amici,
il grande storico arabo Ibn Khaldoun osservava nel XIV secolo che solo le tribù capaci di forte senso di appartenenza possono sopravvivere nel deserto. Dopo 450 anni di storia il nostro Ateneo sopravviverà solo se sapremo coltivare un forte senso di appartenenza. A questo ci siamo dedicati nell’anno delle celebrazioni centenarie, rese possibili grazie ai generosi contributi finanziari che abbiamo ricevuto.
Ora, però, occorre lavorare per affermare il senso etico dell’impegno personale di ciascuno di noi, il che significa distribuire le risorse con criteri condivisi, stabilire indicatori veramente imparziali, fissare obiettivi alti, e poi pesare i risultati. Vogliamo riaffermare in tutte le sedi che il nostro Ateneo ha messo e continuerà a mettere al primo posto il principio di legalità, inteso come impegno per realizzare il bene comune, che è il presupposto necessario per fare università. Su questo versante saremo davvero intransigenti.
Allora, veramente, voglio rivolgermi a ciascuno di voi, ai nostri studenti, ai nostri colleghi, alle nostre famiglie, per formulare i miei auguri.
Auguri a tutti noi, per le prossime Festività e per un vero Natale pieno di serenità e di gioia, per un anno nuovo ricco di cose che contano davvero, di emozioni, di sogni e di speranze.
Auguri e un affettuoso in bocca al lupo ai nostri colleghi che, superato lo sbarramento delle mediane, in questi giorni partecipano al rito iniziatico delle abilitazioni nazionali, con la speranza di un successo personale che sarà anche un successo per tutto l’Ateneo.
Auguri a ciascuno di voi, alla grande famiglia dell’Università, alla città di Sassari ed a tutta la Sardegna. Il nuovo anno sia veramente un anno di svolta, positivo, ricco di salute, speriamo senza una lacrima, con tanti momenti di gioia e di felicità.
 rivedo oggi con piacere in questa splendida nuova sede della Biblioteca Castellana alcuni colleghi che mi sono molto cari, a iniziare da Abdelkader Sid Ahmed.
rivedo oggi con piacere in questa splendida nuova sede della Biblioteca Castellana alcuni colleghi che mi sono molto cari, a iniziare da Abdelkader Sid Ahmed. quest’anno la Pasqua cade in un momento di profonda crisi per il Paese e per la Sardegna, colpite dai licenziamenti come quelli annunciati a porto Torres per EON, ultimo episodio di un rosario di notizie che testimoniano il declino del sogno industriale, iniziato con la rottamazione degli impianti della Vinyls, quando tanti giovani cassintegrati ci sono stati strappati dopo anni di lotta disperata. Ho sempre negli occhi l’immagine di Padre Paolo che accoglie gli operai. Colgo l’occasione per augurare Buona Pasqua anche a loro, ai nostri studenti, ai nostri colleghi, agli amici dell’Istituto di Scienze Religiose, perché tutti possiamo essere in grado di leggere con speranza i segni dei tempi nuovi che passano anche attraverso il forte rinnovamento della Chiesa, che riscopre valori profondi e una dimensione veramente universale, con l’arrivo di un grande Papa, Francesco.
quest’anno la Pasqua cade in un momento di profonda crisi per il Paese e per la Sardegna, colpite dai licenziamenti come quelli annunciati a porto Torres per EON, ultimo episodio di un rosario di notizie che testimoniano il declino del sogno industriale, iniziato con la rottamazione degli impianti della Vinyls, quando tanti giovani cassintegrati ci sono stati strappati dopo anni di lotta disperata. Ho sempre negli occhi l’immagine di Padre Paolo che accoglie gli operai. Colgo l’occasione per augurare Buona Pasqua anche a loro, ai nostri studenti, ai nostri colleghi, agli amici dell’Istituto di Scienze Religiose, perché tutti possiamo essere in grado di leggere con speranza i segni dei tempi nuovi che passano anche attraverso il forte rinnovamento della Chiesa, che riscopre valori profondi e una dimensione veramente universale, con l’arrivo di un grande Papa, Francesco. sono qui innanzi tutto per portare il saluto dell’Università di Sassari per questa giornata di riflessione con i rappresentanti sindacali e dell’agricoltura sarda, con uno sguardo rivolto innanzi tutto agli operai di E.ON, impegnati nella difesa del proprio posto di lavoro.
sono qui innanzi tutto per portare il saluto dell’Università di Sassari per questa giornata di riflessione con i rappresentanti sindacali e dell’agricoltura sarda, con uno sguardo rivolto innanzi tutto agli operai di E.ON, impegnati nella difesa del proprio posto di lavoro. intervengo con emozione a questo incontro con tanti amici dedicato al tema della pace, partendo dal mondo antico, cercando di esprimere la complessità del tema.
intervengo con emozione a questo incontro con tanti amici dedicato al tema della pace, partendo dal mondo antico, cercando di esprimere la complessità del tema.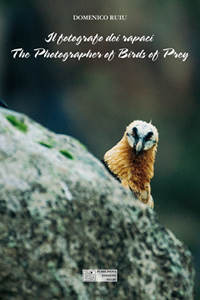 I rapaci occupano da sempre uno spazio significativo nella letteratura sulla Sardegna per rappresentare un ambiente naturale, gli spazi solitari del Gennagentu, ma anche una cultura e una tradizione, frutto di osservazioni e di riflessioni che iniziano nel mondo antico con lo Pseudo Aristotele.
I rapaci occupano da sempre uno spazio significativo nella letteratura sulla Sardegna per rappresentare un ambiente naturale, gli spazi solitari del Gennagentu, ma anche una cultura e una tradizione, frutto di osservazioni e di riflessioni che iniziano nel mondo antico con lo Pseudo Aristotele. Vorrei ricordare Laura Morelli partendo dalla sua pagina facebook che è illuminata dalla fotografia di una cascata di acqua cristallina che cade dall’alto delle rocce antiche, scolpite dal tempo, in un luogo remoto della Sardegna: immagino che alla base della cascata, sulle rive del laghetto, in un ambiente tanto suggestivo Laura abbia vissuto alcuni dei momenti più belli della sua vita, sia stata felice, magari assieme a Gaetano e ai due ragazzi, Francesca e Lorenzo, che oggi la piangono e che avvertono i morsi della solitudine.
Vorrei ricordare Laura Morelli partendo dalla sua pagina facebook che è illuminata dalla fotografia di una cascata di acqua cristallina che cade dall’alto delle rocce antiche, scolpite dal tempo, in un luogo remoto della Sardegna: immagino che alla base della cascata, sulle rive del laghetto, in un ambiente tanto suggestivo Laura abbia vissuto alcuni dei momenti più belli della sua vita, sia stata felice, magari assieme a Gaetano e ai due ragazzi, Francesca e Lorenzo, che oggi la piangono e che avvertono i morsi della solitudine. con qualche emozione porto oggi il cordialissimo saluto di tutta l’Università degli Studi di Sassari testimoniando adesione e consenso per questa giornata.
con qualche emozione porto oggi il cordialissimo saluto di tutta l’Università degli Studi di Sassari testimoniando adesione e consenso per questa giornata.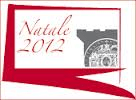 ne dell’inaugurazione del 451° anno accademico, un mese fa, il 9 novembre, abbiamo presentato il bilancio dell’ultimo triennio, che è stato pieno di impegni e di iniziative, portate avanti dagli organi accademici, dai delegati, dal Direttore Generale, dai docenti, dal personale tecnico e amministrativo, dagli studenti. Gli obiettivi raggiunti dai nostri ricercatori e da tutti i nostri colleghi sono numerosi; e in questi ultimi giorni abbiamo ritirato premi e riconoscimenti nazionali, come quello di Italia Camp per i farmaci naturali PHA.RE.CO., alla presenza del Presidente Monti.
ne dell’inaugurazione del 451° anno accademico, un mese fa, il 9 novembre, abbiamo presentato il bilancio dell’ultimo triennio, che è stato pieno di impegni e di iniziative, portate avanti dagli organi accademici, dai delegati, dal Direttore Generale, dai docenti, dal personale tecnico e amministrativo, dagli studenti. Gli obiettivi raggiunti dai nostri ricercatori e da tutti i nostri colleghi sono numerosi; e in questi ultimi giorni abbiamo ritirato premi e riconoscimenti nazionali, come quello di Italia Camp per i farmaci naturali PHA.RE.CO., alla presenza del Presidente Monti.