Intervento davanti alla Prima Commissione del nuovo Consiglio Regionale
(con il contributo del Prorettore prof. Omar Chessa)
Cagliari, 10 giugno 2014

1. La guida, il faro del progetto riformatore delle istituzioni sarde dovrà essere l’art. 5 della Costituzione repubblicana. Questa disposizione – pur con la premessa che la repubblica è una e indivisibile – «riconosce e promuove le autonomie locali (…) e adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento».
Anche se nella prima parte si riferisce espressamente solo alle «autonomie locali», per la dottrina non ci sono dubbi che l’intento dei costituenti fosse quello di sancire un generale «principio autonomistico», quale chiave di volta della costruzione repubblicana. Da un lato, infatti, si afferma il carattere unitario della Repubblica – nonostante la sua formulazione articolata – dall’altra, come una sorta di contrappeso, si afferma che l’unità repubblicana deve conseguirsi e preservarsi nel rispetto e sviluppo del principio autonomistico, in tutte le sue declinazioni: cioè come autonomia politica-amministrativa degli enti territoriali (Regioni ed enti locali sub-regionali), come autonomia funzionale (evocata dall’art. 33, ult. comma, della Costituzione, a mente del quale «le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato»), come autonomia personale (cui si richiama l’ampia previsione delle liberta fondamentali e dei diritti sociali).
Non per caso il «principio autonomistico» rientra tra i «principi supremi dell’ordinamento repubblicano», ossia è un elemento identitario essenziale della nostra forma di stato democratica ed è, per questa ragione, sottratto alla stessa possibilità della revisione costituzionale.
2. Ciò premesso, non c’è alcun dubbio che la specialità regionale sia la realizzazione più intensa del principio autonomistico.
Sappiamo che in base all’art. 116 della Costituzione «il Friuli Venezia giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige e la Valle d’Aosta dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con leggi costituzionali». Da anni si discute se abbia ancora un senso che, accanto alle regioni ordinarie, ci siano cinque regioni speciali provviste di condizioni particolari di autonomia, garantite da statuti che hanno la forma e il rango di leggi costituzionali (e che perciò sono un “pezzo” della costituzione repubblicana). Sta di fatto, però, che la legge costituzionale n. 3 del 2001, cui si deve un’ampia riforma del Titolo V della Costituzione italiana, ha sostanzialmente riconfermato la formulazione del previgente art. 116, comma primo, ribadendo pertanto le ragioni della specialità regionale.
Sotto questo profilo, il fatto che talune Regioni godano di «forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale», non è un retaggio tralatizio o un corpo estraneo rispetto ai principi di fondo e alla logica che sottendono il diritto regionale italiano. Al contrario, è parte integrante del progetto autonomistico che anima la riforma del Titolo V e che animava l’impianto regionalista delle origini. Calata in questa prospettiva, la specialità è nient’altro che la realizzazione più intensa e la massima espressione del principio costituzionale di autonomia, sancito nell’art. 5 della Costituzione.
Sennonché va detto che il nuovo Titolo V non solo ribadisce la specialità regionale, ma sottolinea la necessità di un suo «adeguamento». Non per caso l’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 prevede che le norme di maggiore autonomia contenute in questa legge si applichino alle regioni speciali, appunto, «fino all’adeguamento» dei loro statuti. La vigenza degli attuali statuti speciali è quindi riguardata come una situazione transitoria, il cui superamento porterà a compimento la riforma del regionalismo italiano. Per certi versi l’adeguamento degli statuti speciali è un obiettivo da cui dipende l’attuazione stessa del Titolo V nel suo spirito di fondo: questo prefigura sì la specialità come la forma di massima autonomia riconosciuta dal diritto regionale italiano, ma a condizione che quanto prima si realizzi una coerente modifica del regime costituzionale delle regioni speciali.
3. A ben vedere, le criticità non mancano. È legittimo chiedersi se la specialità sarda abbia mantenuto, nei decenni della sua vigenza, tutte le sue promesse: quanto è realmente “speciale” la Sardegna? In quale misura realizza un sistema differenziato e autonomo, più competitivo rispetto al complesso delle altre regioni italiane? Proverò a rispondere considerando quattro versanti: l’autonomia statutaria, legislativa, locale e finanziaria.
Inizio con l’autonomia statutaria. È ovviamente opportuno distinguere i due versanti dello Statuto propriamente detto e della Legge statutaria.
Per quanto riguarda il primo versante, qui di certo non ci troviamo dinanzi a un inveramento del modello differenziato-competitivo: la forma costituzionale dello statuto speciale non solo non è espressione di maggiore autonomia (negativa o positiva) rispetto a quanto goduto dalle regioni ordinarie, ma non è neppure espressione di autonomia tout court. Non è un atto di autonomia. Il rilievo è così diffuso e condiviso in dottrina che non merita di essere approfondito oltre.
Quanto alla legge statutaria, la potestà di adottarne una è sicuramente una forma di minore autonomia rispetto alla potestà statutaria delle regioni ordinarie: basti pensare che, diversamente dagli statuti ordinari, le leggi statutarie di regione speciale non sono competenti in materia di «principi di organizzazione e funzionamento» (ciò implica che – diversamente dagli statuti ordinari – le leggi statutarie non dispongono del procedimento legislativo regionale).
Vengo all’autonomia legislativa. Sul piano delle potestà legislative, se guardiamo alla prassi avallata dalla giurisprudenza costituzionale, non esiste una vera differenziazione tra regioni ordinarie e speciali. Anche in seguito alla riforma del Titolo V la Corte ha adottato un orientamento interpretativo che ha progressivamente smussato le differenze tra regioni ordinarie e speciali, sicché il rapporto che la funzione legislativa dello stato ha con le funzioni legislative della regione speciale sarda non differisce granché da quello che ha con le funzioni delle regioni ordinarie. Grosso modo e semplificando moltissimo, quello che lo Stato può fare nei confronti delle competenze delle regioni ordinarie lo può fare anche nei confronti delle competenze delle regioni speciali: il sistema complessivo dei limiti statali alle competenze legislative regionali è sostanzialmente il medesimo per le regioni ordinarie e speciali (analogia tra il modo in cui opera il limite delle norme fondamentali di riforma economico-sociale nelle materie di potestà regionale primaria e i titoli statali d’intervento trasversale nelle materie di competenza regionale residuale).
Per quanto riguarda l’autonomia locale. Qui registriamo una forte differenziazione rispetto alle regioni ordinarie, grazie all’interpretazione riduttiva fornita dalla Corte costituzionale all’art. 10 della legge cost. 3/2001. A seguito di questa lettura, nelle regioni speciali si è realizzata una situazione paradossale: il sistema delle autonomie locali sub-regionali non gode delle medesime garanzie che gli sono riconosciute nelle regioni ordinarie, dal principio di sussidiarietà, alle potestà normative locali. Insomma, gli enti locali delle regioni ordinarie sono più garantiti degli enti locali delle regioni speciali: gli spazi di autonomia di cui possono godere sono più ampi.
4. Dopo l’analisi critica occorre la proposta costruttiva. L’Ateneo turritano, che rappresento, ritiene che il disegno riformatore debba essere ampio e organico. Deve scaturire da un progetto unitario che tenga conto di tutte le criticità segnalate sopra e che offra una soluzione complessiva. Non bisogna cedere alla tentazione di proporre riforme settoriali, come se il volto della nuova specialità regionale sarda possa essere la giustapposizione di tanti, diversi, piccoli aggiustamenti parziali, inevitabilmente scoordinati per via della loro episodicità: è invece necessario un grande piano riformatore unitario, che sappia valutare le profonde connessioni sistemiche tra i vari problemi sui quali si dovrà intervenire.
Fatta questa premessa di metodo, illustro ora, in modo più puntuali, le riforme che l’Università sassarese suggerisce.
5. Posto che attualmente lo Statuto speciale è una legge costituzionale, cioè una legge statale alla cui formazione concorre in modo poco incisivo la Regione interessata, occorre una riforma che accresca sensibilmente il ruolo della regione nella decisione delle modificazioni statutarie, fino al punto di rendere determinante il suo consenso.
Ovviamente si deve conservare la natura costituzionale dello Statuto speciale: poiché questo deroga alla disciplina costituzionale comune, bisogna che sia incorporato in una fonte di pari grado. Trattandosi però di una fonte di rango costituzionale, lo statuto speciale non può certo essere una determinazione autonoma della regione; una determinazione, cioè, che esclude il contributo decisivo del Parlamento nazionale. Sarebbe, infatti, irrealistico pretendere dallo Stato che sia la Regione sarda a definire unilateralmente il proprio regime costituzionale dei rapporti col resto delle istituzioni repubblicane. Di conseguenza, in quanto legge costituzionale di competenza del Parlamento, continuerà ad essere un atto statale. Tuttavia, in coerenza con la declinazione intensa del principio autonomistico di cui si è detto, tale atto non può essere imposto alla regione, ossia adottato contro la sua volontà: il suo contenuto deve essere condiviso dalla Regione.
Ebbene, il procedimento di revisione dello statuto dovrà essere adeguato al principio secondo cui le modificazioni dello statuto debbono essere determinate col consenso della regione.
6. Si è detto che la specialità è (deve essere) la forma più intensa di autonomia compatibile con l’unità e l’indivisibilità dell’assetto costituzionale repubblicano. Ciò implica il diritto di concorrere alla determinazione del proprio regime costituzionale, in posizione di parità con il Parlamento nazionale. Se, etimologicamente, l’autonomia è il dare leggi a se stessi, l’autonomia speciale è il dare leggi costituzionali a se stessi, o perlomeno contribuire in modo decisivo alla loro formazione.
Tuttavia, se non viene riempita di contenuti, l’autonomia è solo una mera “possibilità di fare” e, alla fine, solo un guscio vuoto, di cui non s’intravede la funzione e l’utilità. Sicché il riconoscimento formale di poteri ulteriori ha senso solo se questi vengono esercitati per promuovere il valore della differenza, ossia per valorizzare una peculiarità e un tratto identitario.
Seguendo coerentemente quest’impostazione, l’ordinamento costituzionale differenziato della Sardegna dovrà porsi come obiettivo non soltanto quello, storico, di rimuovere una condizione economica di arretratezza e di sottosviluppo, ma anche quello di preservare e sviluppare l’identità sarda. Di qui la necessità di disposizioni statutarie di principio che, per un verso, fondino la possibilità di un governo autonomo della cultura, della lingua, dell’insegnamento, del territorio e del paesaggio sardi; e per l’altro prescrivano ai poteri regionali l’obbligo costituzionale di tutelare la specificità linguistica, culturale e paesaggistica della Sardegna.
A tale fine, si propone che il nuovo Statuto di autonomia includa i seguenti principi fondamentali:
– I valori e la cultura comunitari che costituiscono il patrimonio storico dei Sardi sono espressione di una originale identità e riconosciuti come un contributo fondamentale all’unità repubblicana dell’Italia.
– La Regione, i comuni e le province della Sardegna sono le istituzioni del governo autonomo dei Sardi. I loro rapporti sono improntati ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà. Più precisamente vale il principio di coesione territoriale indirizzato al riequilibrio e al sostegno alle aree più svantaggiate.
– La Regione collabora lealmente all’esercizio delle funzioni delle istituzioni repubblicane e contribuisce all’integrazione europea, anche attraverso proprie specifiche rappresentanze negli organi della Repubblica italiana e dell’Unione europea.
– La Regione tutela e sviluppa la lingua e la cultura dei Sardi, rispettandone le molteplici espressioni; concorre allo sviluppo della ricerca scientifica e della formazione universitaria; organizza l’istruzione garantendo a tutti la formazione e la crescita culturale.
– La Regione preserva il territorio, il paesaggio e le identità dell’Isola.
– La Regione promuove tutte le azioni necessarie per integrare pienamente la Sardegna nelle grandi reti di comunicazione e di distribuzione dell’energia, superando lo svantaggio dell’insularità.
7. Una questione nodale è il rapporto che dovrà instaurarsi tra Statuto speciale e Legge statutaria.
Per inquadrare correttamente il tema occorre anzitutto sottolineare una differenza strutturale tra i due atti sotto il profilo del principio autonomistico. È vero che attraverso la disciplina pattizia del procedimento di revisione statutaria lo Statuto sarà probabilmente destinato a divenire l’atto con cui la Regione sarda negozia con lo Stato la propria posizione costituzionale. Però è anche vero che si tratterà pur sempre di un atto bilaterale che non ricadrà interamente nella nostra disponibilità. Potrà essere modificato solo se c’è il consenso dei Sardi, ma a questo dovrà comunque aggiungersi il consenso delle istituzioni politiche nazionali.
Al contrario, la Legge statutaria è atto interamente deciso dal processo politico regionale, perché è approvato – come sappiamo – con una legge regionale rinforzata. Per tale ragione occorre finalizzare la revisione dello Statuto speciale alla valorizzazione più estesa possibile della Legge statutaria. In altre parole, la revisione dello Statuto dovrà servire soprattutto per porre la Legge statutaria nella condizione di fare ciò che attualmente le è precluso. A tal fine occorrerà estendere la competenza della Legge statutaria ben oltre i confini attuali; e ben oltre gli stessi confini che cingono la potestà statutaria delle regioni ordinarie[1].
Ciò dovrà avvenire in due modi: a) varando una massiccia decostituzionalizzazione di materie che altrimenti sarebbero di rango statutario; b) sancendo espressamente la prevalenza della Legge statutaria sulla legge regionale ordinaria, in ogni materia di competenza regionale.
8. Per quanto riguarda l’autonomia legislativa della Regione sarda, occorrerà raggiungere un accordo su un nucleo duro di competenze normative non scalfibili dal legislatore nazionale. Senza alcuna pretesa d’esausitività se ne suggeriscono alcune, soprattutto tenendo conto di quanto detto prima con riguardo ai principi che caratterizzano la specialità sarda in senso culturale-identitario. Sicché la Regione dovrà avere potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:
– tutela e valorizzazione dei beni culturali immateriali e materiali e del patrimonio;
– insegnamento della lingua e della cultura sarda;
– governo del territorio e tutela del paesaggio;
– organizzazione della giustizia di pace;
– porti e aeroporti civili;
– sviluppo economico regionale e locale, sistema tributario sardo e patto di stabilità interno;
– tutela della salute;
– istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche
– ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali degli Enti locali»
Ovviamente, l’esercizio di queste competenze legislative dovrà avvenire nel rispetto di tutti i vincoli che la Costituzione repubblicana pone a carico di tutte le potestà legislative, siano esse statali ovvero regionali. Oltre a questi vincoli, però, non ve ne dovranno essere altri, stabiliti in Statuto, come accade per quello ora vigente. Pertanto nel testo di riforma non dovranno più figurare i limiti alle potestà legislative sarde, costituiti da: l’«interesse nazionale», i «principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica» e le «norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica».
Inoltre, il legislatore sardo sarà, ovviamente, tenuto al rispetto dei «vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali» (art. 117, primo comma, Cost.). Tuttavia lo Statuto dovrà contemplare l’intervento regionale sia nella fase ascendente di formazione del diritto comunitario, sia nella fase discendente attuativa. A tale proposito si potrebbe prevedere che la Regione nelle materie in cui ha competenza partecipi con propri rappresentanti alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e alla stipula degli accordi internazionali; e che nello stesso modo partecipi alla formazione degli atti comunitari e internazionali che trovano applicazione nel proprio territorio.
9. La disciplina dei principi in tema di autonomie locali dovrà essere una delle parti più qualificanti e innovative del nuovo Statuto speciale. Su questo versante si giocherà una partita decisiva per il rilancio della specialità.
Come si è detto, la specialità avrà ancora un senso se costituirà un’espansione del principio autonomistico sancito dall’art. 5 della Costituzione. Questo però riguarda non solo l’autonomia regionale, ma altresì l’autonomia di tutti gli enti territoriali di cui la Repubblica si costituisce. La specialità perciò dovrà essere un’espansione di tutte le autonomie territoriali costituzionalmente riconosciute. Diversamente non sarebbe una realizzazione più intensa dei principi di equiordinazione, sussidiarietà e leale collaborazione (cioè del “sistema”del Titolo V), ma – ancora una volta – un elemento spurio rispetto a questi, se non proprio la loro negazione.
In coerenza con questa linea guida, il nuovo Statuto dovrà, per un verso, recepire i “principi di sistema” di cui sopra, con ciò colmando il gap che separa il nostro regime speciale dal regime comune; per l’altro offrirne una declinazione più intensa.
In particolare, l’innovazione più sensibile dovrà riguardare il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL). Il nuovo Statuto dovrà raffigurarlo come organo necessario della forma di governo regionale e, ovviamente, come organo rappresentativo delle autonomie sarde, sia quelle degli enti territoriali sub-regionali, sia quelle “funzionali”, come – ad esempio – le Università sarde.
Sotto il profilo della dotazione funzionale del CAL lo Statuto dovrà predisporre una disciplina che corregga sensibilmente la portata dell’art. 123, ultimo comma, Cost., laddove prevede il CAL come «organo di consultazione tra Regione ed Enti locali». In particolare è necessario che lo Statuto speciale riqualifichi il CAL sardo, superando eventuali limiti che possono discendere dalla sua espressa definizione costituzionale quale «organo di consultazione». A tale fine si può prevedere che il CAL partecipi al procedimento di formazione delle leggi regionali con un ruolo consultivo rafforzato, cioè con il potere di rendere parere vincolante nelle materie di interesse locale e sui progetti di modifica dello Statuto speciale e della Legge statutaria, e che il detto parere – qualora fosse negativo – possa essere superato solo da una nuova deliberazione del Consiglio regionale a maggioranza qualificata. Inoltre, dovrà godere del potere di iniziativa legislativa e del potere di richiedere alla Giunta regionale l’impugnazione di leggi statali lesive delle competenze locali e delle autonomie funzionali.
10. È soprattutto con riferimento al tema della forma di governo che deve emergere il carattere minimale della disciplina statutaria.
La riscrittura dello Statuto speciale dovrà prendere atto che la determinazione della forma di governo sarda è una scelta che spetta interamente al processo politico regionale. Ciò che lo Statuto speciale dovrà fare è semmai rafforzare e ampliare il margine di scelta riservato alle istituzioni politiche rappresentative dei Sardi, creando la condizione perché tale processo decisionale si esprima nel modo più libero e ampio possibile.
A tal fine, sarà necessario che lo Statuto si limiti ad individuare gli organi costituzionali della Regione e le loro funzioni fondamentali, rimettendo tutto il resto alla competenza della Legge statutaria. Quest’ultima, pertanto, salvo i vincoli espressamente previsti dal nuovo Statuto, potrà determinare liberamente la forma di governo regionale, senza soggiacere ai limiti che sono attualmente previsti dall’art. 15 del vigente Statuto. In particolare verrà meno il vincolo costituito dalla regola del simul stabunt simul cadent nei rapporti tra Presidente e Consiglio. Sarà il legislatore sardo di riforma a decidere se conservare questa regola o se superarla nella prospettiva di una diversa configurazione del sistema dei rapporti tra le istituzioni politiche che rappresentano i Sardi.
11. L’art. 59 dello Statuto dell’Autonomia dell’Università di Sassari pubblicato il 22 febbraio 2014 disegna le Relazioni con la Regione Sardegna: «L’Ateneo è aperto al confronto con la Regione Sardegna allo scopo di inserire l’attività universitaria nei processi di sviluppo, operando per il progresso culturale, civile, economico e sociale della Regione e per diffondere nel territorio le conoscenze scientifiche e le esperienze didattiche più avanzate a livello internazionale. Stipula con la Regione un’intesa triennale che consenta di interagire positivamente con le politiche regionali e di indirizzare gli investimenti sugli obiettivi strategici di medio e lungo termine nel campo dell’alta formazione, della ricerca, del trasferimento tecnologico, dell’assistenza, con definizione di meccanismi competitivi e di forme di premialità». L’articolo 12 indica come obiettivo la promozione del progresso: «L’Ateneo promuove il libero confronto delle idee e la diffusione dei risultati scientifici anche allo scopo di contribuire al progresso culturale, civile, sociale ed economico, operando in una prospettiva internazionale e favorendo lo sviluppo sostenibile e la tutela dell’ambiente, intesi come un unico sistema di risorse naturali, sociali ed economiche.
L’Ateneo ritiene che la conoscenza sia un bene comune e ne favorisce pertanto libera circolazione e la più ampia diffusione; a tal fine, esso promuove l’accesso aperto alla letteratura scientifica, sostiene pratiche di condivisione e di contenuti aperti e lo sviluppo del sistema bibliotecario di Ateneo.
In particolare, può partecipare alla definizione delle politiche pubbliche e delle scelte fondamentali relative allo sviluppo territoriale e può agire in accordo con gli operatori economici, il mondo produttivo, gli ordini professionali, i sindacati e le altre espressioni del mondo della cooperazione, del volontariato e del terzo settore.»
12. Un punto specifico che vorrei segnalare in questa sede è la posizione assunta dall’Università di Sassari in materia di lingua sarda, in forza proprio dell’art. 59 dello Statuto: «L’Ateneo promuove la tutela e la conoscenza dei beni e delle fonti dell’identità locale, con particolare riferimento alle lingue delle minoranze e alla lingua sarda nelle sue articolazioni territoriali, alle risorse naturali, ai beni storici, culturali, ambientali, paesaggistici e architettonici, ai saperi e alle tradizioni locali».
Voglio ribadire oggi che l’Ateneo è fortemente impegnato per la difesa della lingua sarda e delle altre lingue del territorio come lingue dell’oggi e del domani, come segni di identità e come elementi distintivi per le culture e per le tradizioni della Sardegna. L’Ateneo promuove il plurilinguismo, ma per la lingua sarda chiede – così come recitano le linee guida approvate dalla Regione – che si parta dalle radici, che si rispettino e si valorizzino le varietà locali in una reale ottica di protezione delle minoranze, che si difendano i territori senza atteggiamenti di dirigismo linguistico che sarebbero nefasti, pur in una prospettiva di semplificazione ortografica e, sul piano scritto, di standardizzazione progressiva.
[1] Non bisogna dimenticare, infatti, che rebus sic stantibus la potestà statutaria delle regioni ordinarie è, per estensione ed incidenza, più ampia della competenza che gli Statuti speciali riservano alla Legge statutaria.
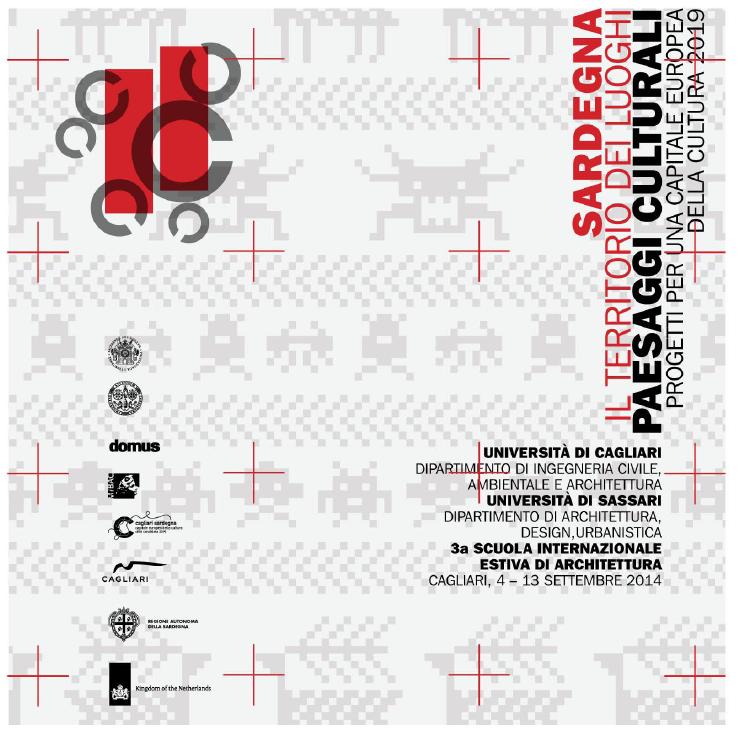
 Non conosco bene le ragioni per le quali il sindaco Antonio Diana, l’Assessore Francesca Demontis e il nostro Salvatore Rubino mi hanno scelto a presentare Mariotto Segni in questa solenne occasione per l’attribuzione del titolo di Stintinese doc. Considero questo incarico un grande onore, per il prestigio del personaggio e per il legame di stima e di amicizia che risale ad anni veramente lontani, prima ancora del mio arrivo a Sassari nel 1980 come assistente di Sandro Schipani e prima degli incontri politici dove lo vedevo all’opera con grande forza, con freschezza e con un forte spirito di iniziativa. In Facoltà di Giurisprudenza al fianco sempre di Antonio Serra.
Non conosco bene le ragioni per le quali il sindaco Antonio Diana, l’Assessore Francesca Demontis e il nostro Salvatore Rubino mi hanno scelto a presentare Mariotto Segni in questa solenne occasione per l’attribuzione del titolo di Stintinese doc. Considero questo incarico un grande onore, per il prestigio del personaggio e per il legame di stima e di amicizia che risale ad anni veramente lontani, prima ancora del mio arrivo a Sassari nel 1980 come assistente di Sandro Schipani e prima degli incontri politici dove lo vedevo all’opera con grande forza, con freschezza e con un forte spirito di iniziativa. In Facoltà di Giurisprudenza al fianco sempre di Antonio Serra.
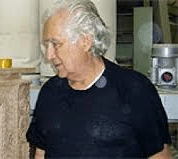 Cari amici,
Cari amici,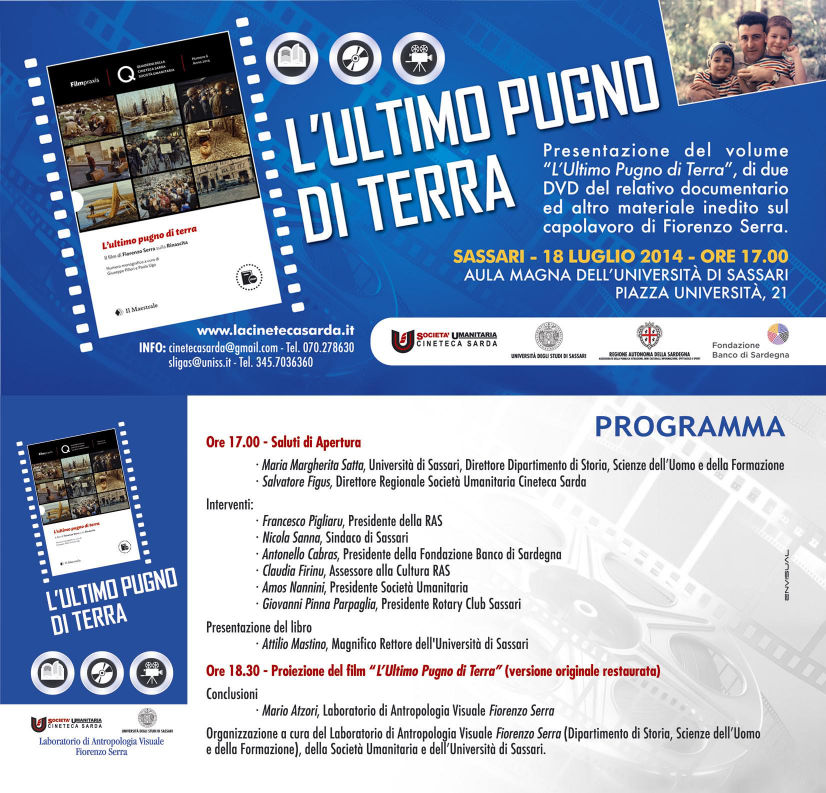
 Voglio esprimere la più grande soddisfazione della comunità accademica perché la ‘nostra’ Biblioteca universitaria trova una splendida collocazione in questo edificio, l’antico Ospedale SS. Annunziata, uno dei luoghi dell’identità della città di Sassari, uno spazio rinnovato, ricco di suggestioni significative, adeguato ad accogliere una preziosa collezione di opere che documentano mille e mille curiosità, interessi, ricerche sviluppatesi nel tempo: voglio citare almeno quel Condaghe di San Pietro di Silki che costituisce il documento iniziale della lingua volgare sarda e insieme testimonia la ricchezza delle eredità culturali classiche nel Regno del Logudoro giudicale.
Voglio esprimere la più grande soddisfazione della comunità accademica perché la ‘nostra’ Biblioteca universitaria trova una splendida collocazione in questo edificio, l’antico Ospedale SS. Annunziata, uno dei luoghi dell’identità della città di Sassari, uno spazio rinnovato, ricco di suggestioni significative, adeguato ad accogliere una preziosa collezione di opere che documentano mille e mille curiosità, interessi, ricerche sviluppatesi nel tempo: voglio citare almeno quel Condaghe di San Pietro di Silki che costituisce il documento iniziale della lingua volgare sarda e insieme testimonia la ricchezza delle eredità culturali classiche nel Regno del Logudoro giudicale. Caro Presidente Pier Paolo Vargiu, cari deputati, ho molto apprezzato il fatto che l’incontro con la Commissione parlamentare per la nascita del nuovo Ospedale sia stato promosso all’interno di questo straordinario Museo archeologico, che testimonia la qualità ambientale del futuro di Olbia, lo spessore storico, il collegamento tra medicina, salute e cultura, nel segno di Eracle e delle ninfe. Sono presenti per conto dell’Università di Sassari la Presidente della Facoltà di Medicina e Chirurgia prof.ssa Ida Mura, il Prorettore delegato alla sanità prof.ssa Maristella Mura, il direttore del Dipartimento di scienze biomediche prof. Andrea Montella, il consigliere d’amministrazione prof. Francesco Meloni, la prof.ssa Maura Pugliatti, membro del tavolo tecnico per la ricerca.
Caro Presidente Pier Paolo Vargiu, cari deputati, ho molto apprezzato il fatto che l’incontro con la Commissione parlamentare per la nascita del nuovo Ospedale sia stato promosso all’interno di questo straordinario Museo archeologico, che testimonia la qualità ambientale del futuro di Olbia, lo spessore storico, il collegamento tra medicina, salute e cultura, nel segno di Eracle e delle ninfe. Sono presenti per conto dell’Università di Sassari la Presidente della Facoltà di Medicina e Chirurgia prof.ssa Ida Mura, il Prorettore delegato alla sanità prof.ssa Maristella Mura, il direttore del Dipartimento di scienze biomediche prof. Andrea Montella, il consigliere d’amministrazione prof. Francesco Meloni, la prof.ssa Maura Pugliatti, membro del tavolo tecnico per la ricerca.
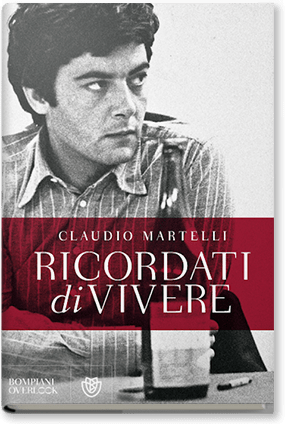 Il titolo di questo libro Ricordati di vivere si collega in maniera singolare all’esigenza che l’autore manifesta pressantemente negli ultimi anni di ricordare le proprie radici, di recuperare la formazione filosofica tanto amata ma che rischia di finire per essere quasi una gabbia di tipo intellettualistico che poteva rischiare di mettere in secondo piano emozioni e impegni personali tale dai rallentare il flusso della vita activa intesa come impegno politico forte deciso e pratico soprattutto quando Martelli raggiunge l’apice della carriera politica, esercitando dopo Claudio Vassalli il ruolo di Guardasigilli; Primum vivere, deinde philosophari recita la massima, attribuita ad Hobbes, ma di sicura derivazione classica (già presente all’interno della Politica di Aristotele nella contrapposizione tra vita attiva e otium speculativo). O non sarà alla rvescia, un rimpianto per aver trascurato la vita vera per inseguire la politica ?
Il titolo di questo libro Ricordati di vivere si collega in maniera singolare all’esigenza che l’autore manifesta pressantemente negli ultimi anni di ricordare le proprie radici, di recuperare la formazione filosofica tanto amata ma che rischia di finire per essere quasi una gabbia di tipo intellettualistico che poteva rischiare di mettere in secondo piano emozioni e impegni personali tale dai rallentare il flusso della vita activa intesa come impegno politico forte deciso e pratico soprattutto quando Martelli raggiunge l’apice della carriera politica, esercitando dopo Claudio Vassalli il ruolo di Guardasigilli; Primum vivere, deinde philosophari recita la massima, attribuita ad Hobbes, ma di sicura derivazione classica (già presente all’interno della Politica di Aristotele nella contrapposizione tra vita attiva e otium speculativo). O non sarà alla rvescia, un rimpianto per aver trascurato la vita vera per inseguire la politica ?