Roma, 12 maggio 2016 – Istituto Nazionale di Studi Romani, Piazza Cavalieri di Malta, 2
PRESENTAZIONE DEL VOLUME
Atti del XX Convegno Internazionale di studi “L’Africa romana. Momenti di continuità e rottura: bilancio di trent’anni di convegni” (Alghero – Porto Conte Ricerche, 26-29 settembre 2013). A cura di Paola Ruggeri (con la collaborazione di Maria Bastiana Cocco, Alberto Gavini, Edgardo Badaracco, Pierpaolo Longu). Tre volumi. Carocci editore, Roma 2015
PER INIZIATIVA DEL CENTRO DI STUDI INTERDISCIPLINARI SULLE PROVINCE ROMANE DELL’UNIVERSITÀ DI SASSARI E DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI ROMANI

- Saluto di Paolo Sommella, Presidente dell’Istituto Nazionale di Studi Romani
- Saluto di Marco Milanese, Direttore del Dipartimento di storia, scienze dell’uomo e della formazione dell’Università di Sassari
- Introduzione di Attilio Mastino, coordinatore del Dottorato di ricerca in Archeologia dell’Università di Sassari
- Presentazione di Sergio Ribichini, Scuola Archeologica Italiana di Cartagine
- Presentazione di Isabel Rodà de Llanza, Universitat Autònoma de Barcelona, Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana Department
- Conclusioni di Mario Mazza, Accademia Nazionale dei Lincei
- Presentazione della Rivista “Cartagine Studi e Ricerche” e della “Collana di Monografie della SAIC” di Antonio M. Corda, Dipartimento di Storia, Beni culturali e Territorio dell’Università degli studi di Cagliari
- Firma dell’accordo tra l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle della Tunisia e la Scuola Archeologica Italiana di Cartagine
INTRODUZIONE DI ATTILIO MASTINO
La prestigiosa ospitalità dell’Istituto Nazionale di studi romani e dell’amico e maestro Paolo Sommella ci conduce oggi a Roma a presentare gli Atti del XX Convegno internazionale de L’Africa Romana svoltosi ad Alghero nel settembre 2013, pubblicati dall’Editore Carocci a cura di Paola Ruggeri, con la collaborazione di Maria Bastiana Cocco, Alberto Gavini, Edoardo Badaracco e Pierpaolo Longu. Il volume è compreso nella collana del Centro di studi interdisciplinari sulle province romane e del Dipartimento di storia, scienze dell’uomo e della formazione dell’Università di Sassari (rappresentato oggi dal Direttore Marco Milanese) e tratta il tema di Momenti di continuità e rottura: bilancio di trent’anni di convegni L’Africa Romana. Lo abbiamo pubblicato grazie alla consueta generosità della Fondazione Sardegna e del suo presidente il sen. Antonello Cabras.
Grazie alla collaborazione di Massimiliano Ghilardi, torniamo in questo prestigioso Istituto dove il 17 dicembre 2012 avevamo presentato il XIX volume, curato da Maria Bastiana Cocco, Alberto Gavini e Antonio Ibba. Anche questa volta sono presenti tanti amici dell’Institut National du Patrimoine di Tunisi, dell’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle della Tunisia rappresentata da Samir Aounallah e delle Università del Maghreb. E sono trascorsi 33 anni da quando, il 16 dicembre 1983, nella sede della Camera di Commercio, si apriva a Sassari il I Convegno de L’Africa Romana, al quale parteciparono un campione degli Studi Africanisti, quale fu Marcel Le Glay, indimenticabile maestro e amico, e altri nostri cari colleghi, come Hedi Slim con la Signora Latifa, e poi Ammar Mahjoubi, Naidé Ferchiou, Giancarlo Susini e Angela Donati, Giovanna Sotgiu, Cinzia Vismara, l’allora Ispettore della Soprintendenza Archeologica di Cagliari Raimondo Zucca.
Lasciatemi tornare indietro commosso a quel momento lontano, ripercorrendo per un attimo tante storie e tanti avvenimenti, un pezzo lungo significativo e felice della vita di tanti di noi, un percorso che è stato di studi, di ricerche, ma anche di curiosità e di passioni vere.
Volgendoci indietro, quella di oggi è anche l’occasione per ripercorrere una storia lunga, intensa, stimolante, che ha prodotto risultati scientifici, numerose novità e significativi progressi nelle nostre conoscenze e nei nostri studi e insieme un ulteriore consolidamento di quella che è diventata negli anni una vera e propria rete di collegamento tra antichisti a cavallo tra le due rive del Mediterraneo, un rapporto di collaborazione paritario e stimolante tra studiosi di formazione e di provenienza tanto differenti.
Diverse generazioni di studiosi si sono susseguite con passione civile, fornendo contributi di grande interesse e presentando un’enorme quantità di materiale inedito.
È soprattutto grazie ai colleghi provenienti dall’Algeria, dal Marocco, dalla Tunisia e dalla Libia, che i nostri convegni hanno raggiunto nel tempo uno straordinario ampliamento territoriale e geografico, abbracciando la storia del Nord Africa nel suo insieme, al di là della stessa denominazione letterale: l’Africa, intesa non come singola provincia ma vista in alternativa all’Europa e all’Asia, come una delle tre parti dell’oikoumène romana, con un allargamento di orizzonti e di prospettive che permette di superare – scriveva Azedine Beschaouch – la visione ristretta del Mar Mediterraneo, prevalentemente basata su un asse Nord-Sud e di ricordare quello che fu il bilinguismo ufficiale dell’impero dei Romani. L’Africa può allora diventare una parte essenziale del più ampio bacino mediterraneo, un’area costiera non isolata ma che è in relazione con tutta la profondità del continente, trovando nel Mediterraneo lo spazio di contatto, di cooperazione e se si vuole di integrazione sovrannazionale.
A distanza di tre anni dal nostro Convegno il quadro generale del Mediterraneo è notevolmente modificato: le primavere arabe si sono rivelate “inverni” terrificanti, prosegue inarrestabile l’emorragia di profughi che partono dalla Libia e non solo, esposti ad una incivile tratta di persone disperate, soprattutto di bambini; l’insicurezza ha travolto alcuni paesi, il 18 marzo 2015 l’attentato al Museo Nazionale del Bardo è stato un colpo terribile inferto all’economia della Tunisia libera e democratica, ai beni culturali, al patrimonio, soprattutto alle relazioni tra studiosi. Eppure non mancano notizie straordinarie, come il premio Nobel assegnato per la pace al “quartetto” tunisino, espressione dell’ Unione Generale Tunisina del Lavoro (“Union Générale Tunisienne du Travail”, UGTT); della Confederazione Tunisina dell’Industria (“Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat”, UTICA), della Lega Tunisina per la Difesa dei Diritti dell’Uomo (“Ligue Tunisienne pour la Défense des Droits de l’Homme”, LTDH), dell’Ordine Nazionale degli Avvocati di Tunisia (“Ordre National des Avocats de Tunisie”, ONAT).
E poi la presenza dal I ottobre 2015 di 100 studenti magrebini che studiano in Sardegna presso le due Università grazie all’impegno di Unimed e della Fondazione Sardegna (nei prossimi 5 anni si parla di 500 studenti). Altri giovani magrebini che partecipano ai dottorati e agli scavi archeologici europei, come in passato gli studenti dell’Institut Supérieur des Métiers du Patrimoine. L’Agence ha pubblicato il prestigioso libro Je suis Bardo e presentato a Tunisi, per iniziativa del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e dell’Ambasciata d’Italia il 18 marzo 2016, questo XX volume degli Atti de L’Africa Romana e gli scavi archeologici tuniso-italiani.
A Sassari il 22 febbraio 2016 è stata costituita la Scuola Archeologica Italiana di Cartagine, oggi arrivata a 112 associati, interessata ad operare in campo internazionale. Il Consiglio scientifico si è riunito a Tunisi presso l’Istituto Italiano di Cultura il 18 marzo (in occasione delle cerimonie per ricordare l’attentato del Bardo), l’assemblea il 6 aprile a Sassari e oggi a Roma presso l’Istituto Nazionale di Studi Romani. Firmeremo tra poco la convenzione della Scuola Archeologica Italiana di Cartagine con l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle della Tunisia. La convenzione prevede l’assenso del prof. Ridha Kacem direttore generale dell’Agence per l’assegnazione in comodato d’uso di aule e locali di segreteria per la SAIC, con attività comuni, in particolare la pubblicazione di una Guida di Cartagine plurilingue. La SAIC si propone di favorire opportunità di ricerca, formazione e diffusione delle conoscenze sul patrimonio relativo alle civiltà preistoriche e protostoriche, preclassiche, classiche, tardo-antiche, islamiche, moderne; valorizzare gli apporti di ogni singola iniziativa in questo campo, mantenendo una visione ad ampio spettro e un coordinamento funzionale; contribuire attivamente al dialogo interculturale e alle politiche di sviluppo della Tunisia (e più in generale dei Paesi del Maghreb).
Lavoreremo d’intesa con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e con gli Istituti Italiani di cultura. Il Rettore dell’Università di Sassari prof. Massimo Carpinelli e il Presidente della Scuola archeologica italiana di Cartagine hanno firmato una convenzione quadro per coordinare l’attività di formazione, soprattutto all’interno del Dottorato di ricerca “Archeologia, storia, scienze dell’uomo” dell’Università di Sassari. Ma altri accordi sono in fase di elaborazione.
Dal nostro osservatorio, constatiamo che, nonostante le preoccupazioni, possono moltiplicarsi ora le grandi imprese di collaborazione internazionale. Questo volume vuole restituire l’unità della conoscenza, sbriciolata in mille rivoli dalle pratiche accademiche, quasi che s’assaporasse la condanna divina della confusione delle lingue di babelica memoria. Qui è restituita la lingua delle origini, che parlano all’unisono storici, archeologi, epigrafisti, numismatici, giuristi e scienziati delle scienze esatte che combinano i loro saperi a quelli umanistici, tutti provenienti da tanti paesi.
Da questa polifonia è restituita la lingua delle origini prima di Babele che parlarono gli uomini prima che i fratres in humanitas fossero separati dall’ignorantia, dall’incapacità di ascolto della parola, unica, di tutti gli uomini.
Cari amici, noi tutti abbiamo creduto che la nostra azione non potesse esaurirsi nell’attività di ricerca e di trasmissione di conoscenza: in questi anni abbiamo tentato di cooperare, con i nostri studenti, fianco a fianco con gli studenti e gli archeologi del Maghreb, in Tunisia e in Marocco, forse anche in una Libia non più lacerata dagli esiti terribili del colonialismo e della dittatura. Vogliamo oggi ripercorrere con orgoglio la strada percorsa, del resto torneremo presto in questo Istituto per raccontare le imprese africane di Antonino Di Vita raccolte nei due volumi recentemente pubblicati da L’Erma di Bretschneider.
Lasciatemi in chiusura ricordare due maestri che ci hanno lasciato di recente, Nicola Bonacasa (scomparso il I dicembre scorso, qualche settimana fa ricordato a Palermo) e un altro maestro che abbiamo ugualmente amato, Josè María Blázquez Martínez, scomparso a Madrid il 27 marzo. Avremo modo di ricordare la Sua opera davvero straordinaria, tra Preistoria, Storia Antica, Archeologia, Storia del cristianesimo, in Spagna ma più in generale nel Mediterraneo antico. Oggi vorrei presentarlo come un amico generoso de L’Africa Romana fin dal Congresso del 1989, come Maestro capace di spaziare tra tante discipline diverse, come punto di riferimento per tante generazioni di studiosi. Lascia un rimpianto tra i giovani ricercatori che hanno avuto la fortuna di incontrarlo a Sassari, a Tunisi, a Tozeur, a Djerba, a Rabat, a Siviglia, proprio in occasione dei nostri convegni, parlando soprattutto di mosaici. Non è mai mancato ai nostri incontri, ha presieduto le sessioni di lavoro ed ha scritto le conclusioni con generosità e affetto. Si è sempre fatto accompagnare da amici ed allievi, che ora continuano a coltivare le sue passioni e le sue curiosità. Con me è stato davvero un amico grande e fedele, solo se penso alla sua finestra sull’Oceano, nella Cadice che amava.
Presentazione di Sergio Ribichini
Confesso di avere accettato il compito di presentare questo volume con molto piacere e con un certo disagio. O per dire meglio: con un certo piacere e con molto disagio.
Con piacere, giacché l’invito veniva da Attilio Mastino, che ho conosciuto nel 1985 a Sassari, per il III convegno di Studi sull’Africa romana; che ho rivisto più volte e con il quale ora collaboro, per la Scuola Archeologica Italiana di Cartagine, la SAIC.
Dunque non solo non potevo dire di no, ma anzi dovevo ricambiare l’onore che Attilio mi faceva chiamandomi a questo ruolo.
Anche con disagio, però; perché nel libro c’è già una bella presentazione[1] e soprattutto perché Attilio è come un auriga sempre in corsa, che spinge il carro delle sue iniziative a velocità impressionante.
Ho scritto questi appunti con la mano sinistra, perché la destra era fissa sulle caselle di posta elettronica, dove i suoi messaggi arrivano in quantità notevole, per assicurare uno slancio laborioso alla nuova impresa della SAIC, che ci unisce, ci trascina, ci appassiona.
Con disagio, poi, perché non è facile rendere l’omaggio dovuto ai curatori del libro, a Paola Ruggeri che dal 1992 ha affiancato Mastino nel duro ed efficace impegno editoriale, e che per questa occasione si è avvalsa della collaborazione di Maria Bastiana Cocco, Alberto Gavini, Edgardo Badaracco e Pierpaolo Longu. Nomi che rappresentano gli epigoni di una scuola sarda di africanisti affermata a livello internazionale.
Con disagio, infine, perché è difficile trovare un criterio capace di compendiare gli atti di un grande convegno che è anche il bilancio di trent’anni di appuntamenti internazionali, con centinaia di partecipanti.
Un libro con oltre 2500 pagine: non potevo leggere tutto. Non avrei fatto in tempo per questo incontro e non sarei davvero riuscito ad assimilare tutti i contributi.
Consapevole dei miei limiti, lo stesso Attilio mi ha proposto di presentare solo i saggi più vicini ai miei interessi. E in tal senso mi sono accordato con Isabel, cui spetta il lavoro maggiore.
Scorrendo l’indice, ne ho selezionati una quarantina: dedicando un minuto ciascuno, avrei bisogno almeno del doppio del tempo di cui dispongo.
E farei giusto in tempo a dire i titoli. Forse.
Dovrei trascurare ad esempio, tra le presentazioni di volumi, quella degli Studi in ricordo di Giovanni Tore, che rende onore alla saggezza dell’amico punicologo precocemente scomparso[2].
Dovrei presentare chi propone una riflessione sulle forme di traduzione letterale o piuttosto di adattamento da una lingua all’altra, come nel caso delle bilingui libico-puniche e libico-latine di Dougga, quali espressioni di un preciso disegno politico avviato dal re numida Massinissa[3]. Dovrei riassumere decenni di ricerche d’epigrafia punica[4] e progetti di corpora per testi incisi, graffiti o dipinti su oggetti ceramici[5].
Dovrei riproporre problemi d’iconografia monetaria e il contenuto ideologico di rappresentazioni divine in Mauretania[6].
Dovrei presentare bilanci e prospettive di numismatica maghrebina, per lo studio delle serie monetali conservate nei musei tunisini[7].
Ma certo non avrei tempo per esaminare tutto con calma.
Dovrei inoltre spaziare tra geografia e storia: politica, economica e religiosa, per parlare di siti e di circolazione di beni nell’articolazione territoriale dei possedimenti cartaginesi[8]. Dovrei discutere d’inediti antroponimi d’origine punica in nuove epigrafi latine della Tunisia[9]. Dovrei evocare il sistema delle rotte tra il litorale nordafricano e la penisola iberica, agli inizi della colonizzazione fenicia[10].
Dovrei segnalare i progetti imperialistici di Alcibiade ricordati da Tucidide come elementi costitutivi dell’impero nella retorica di Aristide e Plutarco[11].
Dovrei dire di avere trovato l’eco di una tesi di dottorato su Massinissa come eroe letterario, della quale ho seguito gli esordi e presto ne vedrò il compimento[12].
Dovrei anche introdurre l’esame dei contributi che trattano dei rapporti tra mondo punico e quello numidico, sul piano linguistico e politico[13].
Ma il tempo di cui dispongo è davvero poco.
Ho pensato allora di selezionare gli studi sulla religione, specie quella punica, seguendo un percorso da spigolatore che potrebbe andare bene: non offenderebbe chi resta escluso e sicuramente coinciderebbe col primo impulso d’ogni lettore, giacché chiunque, in un libro appena edito, va subito a curiosare le cose a lui più vicine.
Potrei così elogiare la presenza di studi sulla sempre problematica interpretazione dei cosiddetti tofet, nella loro specificità e nel passaggio dal culto del Baal cartaginese a quello del Saturno africano[14].
Potrei questionare su significato e sopravvivenza del rito molk nell’Africa romana[15]. Potrei valutare la nozione della divinità presso gli antichi Libici[16] e la venerazione del dio dell’oasi di Siwa[17]. Potrei discutere di pluralismo religioso, sulla scia di un progetto sulle strategie di appropriazione religiosa dell’Africa romana[18].
Potrei anche rammentare, con Arnobio di Sicca, le statue che uscivano dai forni, gli dèi fabbricati col martello, i nastri appesi agli alberi, le pietre cosparse d’olio di oliva, secondo tradizioni indigene e finanche puniche[19].
Ma rischierei di sovrappormi a quanto dirà tra poco la collega Isabel.
Dovrei soffermarmi alquanto anche sui progressi degli studi sul culto di Sardus Pater ad Antas e su quel tempio in suo onore, per il quale si presentano qui alcune tematiche della decorazione architettonica fittile, pertinente alla fase repubblicana, e una ricostruzione grafica del personaggio divino[20].
E non potrei certo dimenticare l’attenta rilettura dell’iconografia di un anello d’argento recuperato nel corredo di una tomba d’epoca tardo-romana, che porterebbe ad escludere l’interpretazione offerta nel 1976 da Robert Du Mesnil du Buisson, che vi leggeva il nome di Sid Babi[21].
E finirei così, inesorabilmente, troppo lontano.
Dovrei poi dare spazio agli studi dei corredi funerari delle necropoli fenicie e puniche in Sardegna[22], ai cataloghi di materiali conseguenti che ne illustrano la tipologia[23] o l’uso continuativo in tarda età tardo-punica e nella successiva età romana[24].
Ma andare in cerca dei contributi che più m’incuriosiscono, rifletterebbe una preferenza comunque soggettiva, fatta di silenzi e di elogi; e perderei la vostra attenzione.
Sono allora tornato a sfogliare i tre volumi con un occhio rivolto ai fatti religiosi e l’altro al tema del convegno: “momenti di continuità e di rottura”. Mi son detto che avrei potuto additare la presenza di studi su interazioni e mutazioni nel credo; interferenze, tradizioni e cambiamenti nel culto, con l’attenzione rivolta all’esame dei rapporti tra Fenici, Greci, Romani e popolazioni indigene, sia in nord-Africa che in Sardegna, nonché sulle ripercussioni che per queste tematiche si rilevano nella storiografia antica e recente[25].
Ma erano davvero troppi i contributi che comunque avrei dovuto affidare al commento di Isabel.
Per non dire dell’attenzione da prestare agli studi sulle interferenze tra Sardi e Fenici, sulla nascita di nuove realtà sociali e comunitarie[26], sulla continuità tra il periodo punico-ellenistico e l’età romano-repubblicana[27]; come pure sulle relazioni tra Etruria e Sardegna agli inizi dell’età del ferro[28], e sui processi di formazione urbana e dei gruppi elitari delle comunità tra IX e VIII secolo, in ragione delle risorse agricole e minerarie[29] e con forme legate alla diffusione d’ideologie[30] e modelli orientali[31].
Da studioso di cose puniche, avrei potuto segnalare vari contributi sul territorio sulcitano in epoca punica e romana, con i risultati d’indagini archeologiche in siti e materiali specifici[32], su particolari strutture edilizie[33] o sulla caratterizzazione del patrimonio storico-archeologico di tutta la zona e in un periodo ancora più ampio[34].
E non potrei farcela, in ogni caso, a entrare nel dettaglio.
Né avrei dovuto dimenticare i più numerosi contributi dedicati a un altro importante insediamento, che costituiscono un corposo caso di studio, con la presentazione di obiettivi e primi risultati di un progetto di ricerca ad ampio spettro[35], le analisi archeometriche e le indagini subacquee[36]; le operazioni di scavo in settori ancora inesplorati[37]; i materiali da costruzione impiegati nelle diverse fasi edilizie dell’insediamento stesso[38]; i frammenti ceramici e i contenitori anforici che consentono di ricostruire i flussi commerciali[39] o si presentano come possibili indicatori di tensioni, nei rapporti commerciali del Mediterraneo antico[40].
Insomma: prediligere un argomento a detrimento di altri era comunque una scelta difficile; nè Isabel ed io potremmo certo presentare tutti gli articoli dei tre tomi, come ci ha scritto con ansia Attilio Mastino, qualche giorno fa, scorrendo lo scambio di mail che concordava i nostri interventi.
Oltretutto, non avrei voluto né dovuto sovrappormi a quanto ha già scritto Guido Clemente nel primo tomo[41], dove ha ricostruito la storia dei Convegni e sottolineato l’ampia collaborazione con Istituti di ricerca, Università, Società scientifiche nazionali e internazionali.
Né dovrei ripetere quello che lo stesso Mastino ha sostenuto nel saluto introduttivo, sulla rete di rapporti, relazioni, amicizie, informazioni, che sono il risultato dell’esperienza vissuta nei vari decenni di attività.
E non vorrei oltretutto perdere tempo a considerare il patrimonio di conoscenze raggiunto con questi convegni e nei volumi che lo testimoniano: libri che s’intitolano all’Africa Romana ma danno largo spazio anche al mondo fenicio e punico, a quello berbero e libico, al mondo nuragico e prenuragico, alle civiltà italiche e alle altre del Mediterraneo antico.
E certo avrei dovuto anche replicare a chi discredita la dimensione monumentale di questa cinquantina di tomi, a chi critica la vastità e la dispersione degli argomenti trattati. Risposta facile, peraltro, e semplice da argomentare, ponendosi a fianco di chi loda la varietà degli interessi, di chi apprezza il metodo interdisciplinare e la veste editoriale, di chi elogia l’immediatezza e la puntualità della pubblicazione, nonché la diffusione capillare dei volumi nelle biblioteche di antichistica.
Dovrei, potrei, vorrei: il tempo si va esaurendo e più non sono in grado di affermare.
Però, mentre scrivevo gli appunti per denunciare la mia insipienza, mi rendevo conto che una scelta comunque l’andavo facendo; che in fondo, e con il mio sinuoso cammino tra i contributi, andavo rispondendo all’invito dell’allora Rettore dell’Università di Sassari promotore dell’incontro di studio.
Quasi senza volerlo, mi andavo così convincendo che avrei potuto riprendere queste note, citando studi e mostrando argomenti; avrei offerto, almeno, una qualche idea del contenuto di questa Ventesima Africa Romana.
E potevo dunque confidare d’avere anche mostrato in questo modo quanto il Mediterraneo antico fosse luogo di confronto e di dialogo; quali spunti da esso e con le pagine dell’Africa Romana possiamo ancora trarre, per obbligare le nostre discipline a capirsi, in nome d’una fiducia reciproca, di raffronti costruttivi, d’una contaminazione scientifica fatta di rispetto, attenzione, apprezzamento.
Ripeto dunque, a mo’ di conclusione, l’auspicio di Mastino e il suo parere su questi Atti, scritti e pubblicati nel desiderio d’un incontro e d’una speranza, da rinnovare e alimentare anche negli anni terribili e difficili che andiamo vivendo[42].
PRESENTAZIONE DI ISABEL RODÀ DE LLANZA
L’evento di oggi commemora realmente un vero e grande successo. Ringrazio moltissimo per l’onore che mi è stato dato, di potere parlare in questa prestigiosa sede; e debbo confessare che la scelta e la distinzione mi ha commosso. Il programma stabilisce che sia quasi l’ultima, ma non per questo voglio omettere di riconoscere il grande merito di Attilio Mastino, che in 30 anni ha saputo non fermarsi nè disperarsi mai, nella continuità dell’organizzazione di 20 Convegni e la pubblicazione puntualissima degli Atti corrispondenti. Volumi che consolidano ancor di più il ponte storico tra la Sardegna e l’Africa, con un intenso e fluido scambio tra ricercatori europei e dei paesi del Nord-Africa e con il supporto di diverse istituzioni, in modo speciale quelle della Tunisia, come viene giustamente esposto nella presentazione di Claude Briand-Ponsart. È stata per Attilio una fatica di Ercole, ma per fortuna in questo caso non è rimasto da solo. Tutti sappiamo e riconosciamo il coraggio e la costanza del Professore e amico, Attilio Mastino, meritatamente nominato Socio Onorario dell’Associazione Nazionale Archeologi (ANA). È stato veramente lui il grande imprenditore; ma il “capitano della nave” ha avuto un equipaggio bravissimo e ha saputo lasciare a ciascuno un suo ruolo, protagonista e importante, incominciando per gli entusiasti professori e ricercatori dell’Università di Sassari come Giovanni Brizzi, Raimondo Zucca, Cinzia Vismara, Piero Bartoloni, Marco Milanese, Antonio Ibba, Alessandro Teatini … e un lungo altro elenco. A tutti loro va la mia testimonianza di ammirazione e di gratitudine perché hanno reso possibile questo punto di riferimento per la storia antica, l’archeologia e la filologia.
Il nostro omaggio sincero a Paola Ruggeri, direttrice adesso del Centro di Studi Interdisciplinari sulle province romane, diretto in precedenza da Raimondo Zucca. La prof.ssa Ruggeri è l’editrice di questi monumentali Atti del Convegno tenuto a Alghero-Porto Conte dal 26 al 29 di settembre di 2013, con l’aiuto inestimabile di Maria Bastiana Cocco, Alberto Gavini, Edgardo Badaracco e Pierpaolo Longu. Sono 3 volumi con 2570 pagine e un totale di circa 200 contributi, molti con diversi autori. È difficile immaginare il lavoro di coordinamento, con tanti interventi che non sempre arrivano puntuali e tutti prima o poi siamo stati amichevolmente e gentilmente sollecitati, così da arrivare in tempo alla pubblicazione finale. Stabilire un ordine, in questi condizioni, è opera ciclopica, e utilissimi sono gli indici alla fine.
Gli Atti di questo ventesimo Convegno sono, emotivamente, dedicati alla memoria delle vittime del terribile attentato del 2015 al Museo Nazionale del Bardo. Pagine sincere e piene anche di emozione sono quelle dedicate a coloro ci hanno lasciato, sempre troppo presto: Claude Lepelley, Enzo Aiello, Emilio Gabba, ai quali dobbiamo ora aggiungere la scomparsa di Nicola Bonacasa e, nel mese di marzo, del prof. Josè M. Blázquez che è stato per tanti anni un grande maestro, di molte generazioni di professori universitari in Spagna.
Mi è stato affidato il compito di parlare sui contributi di argomento romano, anche se in tanti saggi si parla di continuità dall’epoca protostorica fino quella romana e medievale, come del resto è giusto che sia, visto il tema principale del Convegno: “Momenti di continuità e rottura”. Fare un commento approfondito di ognuno è un’impresa impossibile, nella mezz’ora assegnata. Sarebbe come spiegare la guerra dei Cento anni incominciando: “alle ore 8 del primo giorno” …
Apriamo con i contributi del primo volume, che per il periodo romano comincia nella pagina 215 con tre magnifici articoli su Leptis Magna che toccano il Complesso Severiano, l’utilizzo del marmo pentelico, le maestranze e i modelli decorativi, per esaminare anche le recenti indagini nell’anfiteatro e le sue tre fasi costruttive, con una proposta di restauro. Andiamo subito ad un altro anfiteatro della Libia, quello di Sabratha e la sua tecnica edilizia, tenendo conto dei marchi di cava. Ancora in ambiente dei ludi, si esaminano le tabulae rinvenute nell’anfiteatro di Cartagine che offrono una nuova luce sulla organizzazione delle venationes e le emozioni che destavano tra gli spettatori e gli stessi venatores, di cui tratta la tesi di dottorato dell’autrice del contributo. Continuiamo a Cartagine per riesaminare gli altari augustei e giulio-claudii, tra i quali un pezzo capitale è l’ara gentis Augustae e anche due lastre scoperte tra l’anfiteatro e le cisterne; non sfugge all’autore la problematica del tempio sulla collina di Byrsa.
L’articolo seguente tratta delle piscinae o vivaria dell’Africa, con esempi a Cartagine, Thuburbo Maius e Bulla Regia. Quindi si presenta una nuova cartografia basata su tale tematica, per la zona di Thala-Haïdra, al centro della Tunisia.
Passiamo alla scultura. Una bella statua giovanile rinvenuta a Chemtou e databile al 200 d.C., viene qui considerata una replica del Ragazzo di Dresda, attribuibile a un originale policleteo. Segue un articolo molto ampio, che disegna lo sviluppo del ritratto romano nelle province africane d’epoca severiana fino all’invasione vandala; prova a rintracciare l’eredità indigena, ma forse in un’epoca assai tarda e personalmente ritengo che i rilievi funerari di Ghirza debbano essere esaminati sotto un’altra luce e su altri binari.
Si continua con una serie di contributi sui mosaici, a cominciare da una riconsiderazione dei Mamuralia nell’ambito dell’ideologia augustea, partendo della scena di un mosaico della “Maison des Mois” di Thysdrus, il celebre calendario figurato. Si discute poi della continuità e rottura nei mosaici nordafricani con riferimento al tema dei ludi pugilum, a proposito di committenti e artigiani in epoca vandala e bizantina. E arriviamo al contributo che pure ha avuto il tempo di consegnare lo scomparso Josè Mª Blázquez, su miti e leggende omeriche nei mosaici della Hispania e del Nord-Africa, con un repertorio molto completo di temi mitologici che l’Autore si proponeva di continuare, in un futuro che sfortunatamente non arriverà per lui. Il nostro ricordo e l’omaggio più sincero per il Professore Blázquez.
Viene quindi un gruppo di saggi dedicati ai mosaici, che s’inizia con l’articolo sulla continuità di circolazione di un modello orientale maschile, con tunica manicata, anaxyrides e berretto frigio, utilizzato in una assai ampia serie iconografica. Un nuovo mosaico è stato scoperto nel frigidarium delle terme della Colonia Iulia Neapolis, nel corso della campagna 2013, che ha messo in luce, grazie a prospezioni subacquee, anche quattro officinae per salsamenta.
Nella parte consacrata alle iscrizioni, incominciamo con le cosiddette “Bauinschriften”, che nell’Africa sono assai ricche d’informazioni e suggerimenti. L’epigrafia illumina anche lo status giuridico dei terreni dei templi costruiti dai cittadini di Thugga. Più avanti vediamo come un elenco di 88 iscrizioni consente di avanzare proposte sulla organizzazione di epula, banchetti offerti da cittadini evergeti, quali sono rappresentati in parecchi mosaici. Lo studio delle iscrizioni di Thibilis consente d’immaginare l’élite e le strutture sociali della città.
In parte collegati all’epigrafia, diversi contributi si dedicano alla rete viaria, prima dell’entroterra settentrionale di Hadrumetum e poi con un inquadramento generale dei problemi di viabilità antica nell’Africa Proconsolare, da non disgiungere dai rapporti di Roma con le popolazioni locali. Chiude questa sezione lo studio del limes africano, con un’analisi del dispositivo militare romano alla frontiera sud.
Andiamo avanti con Numidia e Mauretania e troviamo un quadro generale della storiografia sulla Numidia e la sua popolazione fino il regno di Giuba I. Nella regione dell’antica Satafis apprendiamo che scoperte accidentali hanno consentito di intravedere meglio lo sfruttamento delle campagne. Un articolo significativo è quello che parla della decorazione architettonica con foglie di acanto in Numidia e Mauretania, con un influsso dei modelli italici ed egei. A proposito del nome di Guelma, l’autore fa una riflessione sul peso del sostrato berbero. Proveniente da Calama è anche un tesoretto d’epoca alto-imperiale con 69 monete; finora nella regione si conosceva soltanto un altro tesoro, scoperto nel 1953.
E arriviamo al Marocco, cominciando per le vie settentrionali e per gli itinerari marittimi, tra l’antichità e il medioevo. Si continua con la valutazione della fondazione di tre colonie nella politica organizzativa romana nella fine del I secolo a.C. Entriamo nell’ambito dell’etnografia col tema del cambio e della continuità tra i Getuli del Sud della Mauretania Tingitana. Ingressi, porte e finestre sono per la prima volta studiati nel loro insieme a Volubilis, dove l’onomastica degli abitanti permette di distinguere tra autoctoni e forestieri, venuti soprattutto dall’Italia e dalle Hispaniae. Di Sala si studia un mosaico che è un pavimento di un frantoio. Nel quadro della numismatica, si analizza l’immagine della Mauretania nelle monete del regno di Adriano.
I tre ultimi articoli del primo tomo offrono quadri generali. Due saggi propongono una valutazione d’assieme di 30 anni d’archeologia funeraria nei Convegni L’Africa Romana e sulle prospettive di questa linea di ricerca. Un terzo presenta, dalla sponda meridionale, il cosiddetto “Cerchio dello stretto di Gibilterra”.
Il secondo tomo, con un totale di 71 contributi, per lo più di tematiche romane, continua con l’archeologia del Marocco, iniziando con una rivisitazione del sito di Tamuda, presso Tetuan, e le vicende della sua identificazione. Si continua ancora con Tamuda, in due lavori consecutivi firmati da una medesima équipe di ricercatori, che offrono i risultati della campagna di scavo del 2011 agli inizi del castellum e del suo urbanesimo e cronologia. Seguono contributi sui doni votivi nell’Africa romana, con una bella indagine sui votivi anatomici fittili come elemento di continuità culturale. Molto interessante è poi la riflessione sull’importanza delle culture native nella creazione e sviluppo dell’idea di città-stato e il salto allo “Stato” territoriale; in questo senso, la Grande Numidia di Massinissa ebbe un ruolo eccezionale.
A partire dalla pagina 955 si pubblicano articoli sui viaggi in Cirenaica nel XVIII e XIX secolo e sullo sviluppo dell’archeologia italiana in Libia durante la seconda guerra mondiale, con una notevole differenziazione osservabile tra la Tripolitania e la Cirenaica, come accade ancora oggi. Seguono un bilancio delle conoscenze su Cherchel, con le ricerche dal 1840 fino ai nostri giorni, e un riesame della storiografia sul Marocco antico. Una riflessione sulle gentes o nationes serve per analizzare l’organizzazione provinciale nel sud della Pronconsolare e della Cesariense.
Ritorniamo al Marocco col contributo sulle ricerche a Volubilis, nel periodo dei Mauri, e con le analisi della tabula Banasitana che permettono un approfondimento sugli spostamenti del personale equestre di alto ceto, secondo le interpretazioni lasciate dal grande H.-G. Pflaum più di 50 anni orsono. Viene in seguito uno studio su briganti e ribelli nelle campagne africane del III secolo.
Compaiono poi lavori d’insieme, relativi alla tarda antichità. Prima, sulla creazione della Mauretania Sitifense; poi, sui lavori di manutenzione dei templi dell’Africa proconsolare in epoca tetrarchica e costantiniana. Si parla anche del contrasto tra l’Imperatore e l’Usurpatore nei Panegirici latini costantiniani. Una riflessione d’insieme molto ampia e valida è quella che rientra nella attività commerciale mediterranea fra l’età imperiale e l’età tardo-antica, che diminuisce verso la fine del V secolo e scompare nel VII. È molto utile rivisitare anche la questione della fine dello sfruttamento delle cave, tramite il riesame del sito di Chemtou, l’antica Simithus, e dell’impianto di un ergastulum. La testimonianza di Agostino serve per parlare della conversione degli Ebrei al cristianesimo. Poi si analizza lo sviluppo del centro di Cartagine nel V e VI secolo. Si continua con un bilancio degli studi sulla tarda antichità e sul cristianesimo nei Convegni dell’Africa Romana, dal 1983; poi con un contributo su una tematica di lungo sviluppo, qual è il rapporto tra cristianesimo e Impero, in questo caso sotto la luce dottrinale di Agostino. Un dibattito tuttora aperto è anche la sopravvivenza del donatismo dopo il 411.
Identifichiamo quindi una parte consacrata alle fonti scritte, letterarie ed epigrafiche, incominciando con l’Anthologia latina, come è intitolata nei tempi moderni e come è l’obiettivo di molte ricerche recenti. Di seguito, si parla di Arnobio di Sicca, nella conversione dal paganesimo al cristianesimo. Un’iscrizione di Tipasa serve per tentare l’identificazione dei martiri venerati.
Entriamo nella parte dedicata all’epoca bizantina. Riletture di diversi autori servono per esaminare l’amministrazione provinciale dell’Africa sotto Giustiniano. La testimonianza del vescovo Gregorio di Agrigento permette d’indagare sul porto della sua città e lo stretto collegamento col Nord-Africa. Segue un lavoro sulla difesa dell’Egitto bizantino, zona davvero strategica per l’Impero romano-bizantino.
Passiamo adesso alla Cirenaica, per esaminare l’esercito privato di Sinesio contro gli Austoriani o Ausuriani, e per studiare anche le nuove strategie difensive, da Sinesio a Giustiniano.
Transitiamo quindi in Sardegna, per seguire il vescovo africano Fulgenzio, esiliato nell’isola per la sua fede ortodossa, e anche per seguire il Rutilius Palladius, autore del celebre Opus agriculturae e zio dello scrittore Rutilio Namaziano.
Un approccio all’esame della tradizione tardo-antica è ora possibile attraverso un esame dell’opera di Carlo Magno, fondatore del nuovo ordine in Europa.
Dopo queste pagine, entriamo in una parte consacrata alle produzioni artistiche ed epigrafiche. Prima, la musiva, con una nuova proposta di lettura del mosaico di Cartagine con uno splendido catalogo di animali e una iscrizione frammentaria di alto interesse. Segue la strana vicenda di una statua di Mustis consacrata a Giove Ottimo Massimo.
Entriamo con questo nella conoscenza di siti poco noti, grazie alle prospezioni e alle scoperte epigrafiche nella regione di Bou Arada in Tunisia, che consentono di approfondire l’onomastica degli abitanti romani; l’analisi dell’epitafio di Peculiaris permette di procedere verso il sito antico di Ksar Bou Khriss a un centinaio di chilometri dalla capitale Tunisi. Le iscrizioni rendono possibile determinare l’origine africana degli funzionari dei secoli II e III, e di apprendere che 61 spettacoli furono offerti in Numidia da 33 evergeti. I termini pubblici sono l’elemento più sicuro per determinare i confini, come in Mauretania, dove sei cippi terminali si riferiscono a proprietà imperiali.
Continuiamo in ambito epigrafico con la notevole presenza di iscrizioni imperiali di Mauretania Cesariense e Sitifense, che dimostrano più continuità che discontinuità. Sono esaminate le tabulae di ospitalità e di patronato, in particolare una tessera di Leptis Magna. Interessante è la presenza femminile nella medicina dell’Africa romana, con iscrizioni che parlano di 6 obstetrices e 1 medica. L’analisi della tegola di Palermo serve per un erudito esame, con tante considerazioni ipotetiche che non chiudono il dibattito sulla proprietà o no dei Minicii Natales Barcinonenses nell’Africa Proconsolare. Saltiamo a Luni, dove si rivisitano le epigrafi di imperatori e notabili di origine africana. Un’ampia visione del paesaggio epigrafico in Sardegna, Betica e Africa è breve, ma con interessanti suggerimenti.
Ancora sul piano dell’epigrafia, usciamo del territorio africano dapprima con una lettura dei tituli picti su anfore betiche rinvenute a Modena e Parma, e poi con lo studio degli graffiti latini del santuario di Son Oms, sito preistorico di lunga sopravvivenza nell’isola di Maiorca, la cui romanizzazione iniziale viene studiata alcune pagine più avanti (1651 ss.). L’epigrafia è stata una scienza che ha utilizzato molto precocemente le nuove tecnologie e qui si offrono i risultati attraverso un laser scanner 3D di un progetto di ricerca dell’Università degli Studi di Sassari. Continuiamo con la Sardegna, esaminando la nascita della praefectura provinciae Sardiniae, sicuramente dovuta a Tiberio. Infine, i supporti funerari consentono di considerare tipi concreti, come i cippi e le cupae.
Andiamo sulla capitale, Roma. Roma fondata dagli Etruschi? con punto interrogativo; la risposta dell’autore è positiva. Più avanti (p. 1689 ss.) si identificano i resti monumentali rinvenuti a Palazzo Valentini, che consentono l’identificazione col templum Divi Traiani et Divae Plotinae, e si analizzano anche i resti della domus B, molto attiva nel III secolo (p. 1717).
Dopo questa domanda sulla fondazione etrusca di Roma, rientriamo in continente africano, con una riflessione sulle influenze dell’Occidente romano su Marina-el-Alamein, in Egitto. Presentando esempi dall’Africa Proconsolare e dall’Hispania, si studiano i mosaici come documento della cultura letteraria. Si parla successivamente dell’Africa romana nei pavimenti musivi di Lusitania.
Siamo dunque in ambiente ispanico. In primo luogo, le Baleari con la romanizzazione iniziale nell’isola di Maiorca, lo studio dell’epigrafia e la vita municipale di Pollentia e gli initerari tra questa città e Palma. Un parallelismo che si dimostra in parecchie occasioni tra Hispania Citerior e Dalmazia, si può stabilire con l’attribuzione dello ius Italicum alle rispettive comunità sotto Augusto. Per continuare in Dalmazia, si presentano le evidenze epigrafiche di Dalmati nelle provincie africane.
Chiudono questo secondo tomo due articoli, il primo con l’analisi delle importazioni africane nella costa tirrenica cosentina, molto intense tra il III e il V secolo, e finalmente, un secondo che offre i risultati della ricerca archeologica nelle isole pontine maggiori, con un quadro cronologico della media e tarda età imperiale.
E arriviamo al terzo volume con 57 contributi, tutti meno 4 (pp. 2133-2177) dedicati alla archeologia in Sardegna. Di questi, 33 appartengono all’epoca romana.
Noi cominciamo dalla pagina 1807 dove troviamo un bell’articolo sulle produzioni ceramiche tra il II secolo a.C. e il I d.C., l’ una a vernice nera e l’altra conosciuta come sigillata sarda.
Dopo, entriamo in una parte molto ricca, centrata in differenti aspetti della città di Nora, oggetto di ricerca da parte di Università diverse. Dal tempio del culto imperiale a Nora è apparsa la dedica epigrafica a Mulciber. Più avanti nel volume, si analizza il contesto ceramico del pronao e, sempre a Nora, si esaminano anche contenitori anforici che permettono di conoscere meglio i flussi commerciali di Nora e della Sardegna meridionale. Non si trascura la continuità di vita a Nora nella tarda antichità fino al VIII secolo con lo studio della ceramica ad impasto.
Immediatamente dopo troviamo una sintesi sul territorio del Sulcis nel sudovest della Sardegna dove anche una équipe spagnola porta avanti un progetto per inventariare il ricco patrimonio. Più oltre si tratta delle ville e strutture produttive del territorio di San Giovanni Suergiu.
All’età repubblicana appartengono le terrecotte architettoniche del tempio di Sardus Pater ad Antas e di questa località si analizza anche un anello in argento con simbolismo giudeo-cristiano. In contesto alto-medievale si situano le strutture scavate a Selargius, ma i frammenti epigrafici consentono di scorgere l’ hinterland rurale di Cagliari.
Altri contributi ci portano all’anfiteatro di Aquae Ypsitanae-Forum Traiani con i recenti scavi che hanno messo in luce un terzo del monumento. In seguito andiamo al periodo tardo e bizantino della città romana di Cornus e al progetto di approfondire lo studio del paesaggio antico e dello sfruttamento di miniere di ferro. Continuiamo con l’archeologia del paesaggio tra le città di Tharros e Cornus tra il I e il VII secolo. Un altro contributo presenta lo scavo archeologico del ponte sul Rio Palmas, costruito sotto Traiano, mentre l’articolo successivo tratta della viabilità romana in territorio di Tuili. Continuità e rotture, tema centrale del Convegno, si rintracciano nei territori di Teti e Villanova Tulo dove è stato individuato nel 2012 un ambiente di età romana.
Entriamo poi nell’area di Turris Libisonis con due lavori che fanno conoscere importanti indagini archeologiche recenti su questa colonia. Parecchie pagine dopo (2425) si offre la scoperta nel 2013 di un nuovo tratto del suo acquedotto di 106 metri; un altro articolo pubblica una bella gemma vitrea decorata con una scena di caccia al grande felino che si collega ad un modello sulla figura di Alessandro Magno.
Seguono 2 articoli con i nuovi dati delle prospezioni subacquee nell’arcipelago della Maddalena, che offrono nuova luce sui relitti in questa zona di passaggio, chiave per le rotte marittime.
L’utilizzo del termine “Sardo Pellita” viene sottoposto a un’analisi in funzione dei modelli storici utilizzati nelle varie epoche.
Nell’hinterland di Cagliari sono state realizzate prospezioni nel territorio di Settimo San Pietro in età romana e hanno dimostrato un’intensa produzione agraria nei secoli romani e una occupazione capillare.
Proseguendo con i paesaggi rurali, andiamo nel centro della Sardegna, dove la presenza di comunità romanizzate appare più antica di quanto si credeva, come dimostra la villa rustica di Ortueri.
Andiamo avanti nel tempo, con le recenti indagini all’esterno della cattedrale di San Pietro di Bosa eretta nell’XI secolo; nell’area settentrionale sono state scoperte ceramiche africane A, C e D e altre ceramiche di mensa e dispensa dalla fine IV e gli inizi del V secolo. Continuiamo nella valle del Temo, tentando di ricostruire il paesaggio antico di Bosa, molto diverso di quello attuale.
Dopo, andiamo ad Alghero dove si studia una nuova iscrizione funeraria della necropoli di Monte Carru, appartenente a un personaggio della gens Caecilia.
Chiude il volume un bell’articolo d’insieme su continuità e trasformazione di flussi commerciali tra le Baleari, Sardegna, Corsica e alto Tirreno in epoca romana, rivalorizzando il carattere di ponte delle isole nel bacino del Mediterraneo Occidentale e le zone del continente.
Rimane soltanto da fare un breve riassunto degli 4 lavori nella parte centrale del volume (p. 2133 a 2186) che escono dell’area sarda per ritornare all’Africa e a soggetti generali. In primo luogo si tenta di distaccarsi della considerazione generale della provincia come un confine, per fare un elenco dei fines, delle arae e dei termini epigrafici che consentono di intravedere l’identità provinciale. Segue una sintesi sui mausolei romani dell’Africa Proconsolare, con un ricco paesaggio funerario di 400 monumenti all’incirca, molti inediti e in cattivo stato di conservazione; per questo il progetto appare di alto interesse, tenendo conto della distribuzione spaziale, delle tipologie architettoniche e, naturalmente, dell’epigrafia e del rango sociale degli defunti e le loro famiglie. Un terzo articolo parla, in un modo generico, della continuità iconografica in taluni mosaici romani di zone molto diverse. Il quarto articolo di questo blocco tocca il soggetto delle immagini scultoree della gente di colore, discusse al di là delle impostazioni dipendenti da pregiudizi razzisti o etnici: sono i cosiddetti “etiopi” delle fonti letterarie; solitamente rappresentano schiavi o prigionieri.
Con questo arriviamo alla fine del nostro percorso, un percorso di una grande densità e ricchezza, che dimostra una volta di più come la conoscenza del Mediterraneo occidentale non sarebbe la stessa se non avessimo avuto questi 30 anni di Convegni sull’Africa Romana.
Vivant, crescant, floreant !!!
CONCLUSIONI DI MARIO MAZZA

[1] Claude BRIAND-PONSART, Présentation: pp. V-XV.
[2] Attilio MASTINO, Presentazione del volume Epì oínopa pónton. Studi sul Mediterraneo antico in ricordo di Giovanni Tore, a cura di C. Del Vais: pp. 107-113.
[3] Intissar SFAXI, Expériences de traduction dans l’univers libyque: l’apport des inscriptions bilingues.
[4] Alessandro CAMPUS, L’Africa romana per l’epigrafia punica: trent’anni di ricerche.
[5] Paola CAVALIERE, Danila PIACENTINI, Epigrafia del quotidiano nel mondo fenicio e punico d’Occidente.
[6] Elena MORENO PULIDO, Melqart-Herakles nella monetazione mauritana.
[7] Zakia BEN HADJ NACEUR-LOUM, Trente ans de numismatique maghrébine: quel bilan et quelles perspectives?
[8] Alessandro DE BONIS, Distribuzione di siti e circolazione di beni nella Tunisia punica.
[9] Ali CHERIF, Prospections archéologiques et découvertes épigraphiques dans la région de Bou Arada (Tunisie).
[10] Caterina Maria COLETTI, Alcune considerazioni sugli itinerari marittimi del Marocco settentrionale tra l’antichità e il medioevo.
[11] Emilio GALVAGNO, Atene, Cartagine, Roma e la retorica di Elio Aristide.
[12] Mathilde CAZEAUX, Masinissa, traître loyal: paradoxes d’une figure héroïque chez Tite-Live. Cf. Mathilde CAZEAUX, « Dia tèn pros te theous kai tous anthrôpous athesian » (Polybe, XIV.1.4). Les alliés numides de la seconde guerre punique dans leurs rapports aux dieux et aux hommes, in « Guerre et religion dans les conflits entre Carthage et Rome. Traces et représentations ». Colloque Jeunes Chercheurs tunisiens, français et italiens, organisé par Corinne Bonnet, Mohamed Tahar et Sergio Ribichini. Toulouse, 31 mai – 1er juin 2016.
[13] Mansour GHAKI, Dougga, le libyque horizontal et la punicisation.
[14] Bruno D’ANDREA, Continuità e rottura in Nord Africa nel passaggio dall’età punica all’età romana: l’esempio delle stele votive, tipologie formali, iconografie e iconologie.
[15] Luis Alberto RUIZ CABRERO, «Non potevo fumare l’erba sul prato di mio padre». La supervivencia del molk en el África romana.
[16] Josuè RAMOS-MARTÍN, Antonio TEJERA GASPAR, La concepción de la divinidad entre los antiguos Libios.
[17] Najoua CHEBBI, Ammon: identité, espace et populations.
[18] Valentino GASPARINI, L’Africa romana, laboratorio di mutazioni religiose. Nuove prospettive su preferenze individuali e spazi di negoziazione. Gli obiettivi principali di un progetto di studio triennale Introducing New, Re-interpreting Old Gods. Religious Pluralism and Agency in Africa Proconsularis and Numidia (146 BC – 235 AD).
[19] Ridha KAABIA, Arnobe de Sicca du paganisme au christianisme: l’évolution cultuelle d’un lettré romano-africain.
[20] Giuseppina MANCA DI MORES, Il Sardus Pater ad Antas e la tarda repubblica romana.
[21] Paolo Benito SERRA, Su un anello d’argento da Antas-Fluminimaggiore e su un sigillo in bronzo da Scano Montiferro.
[22] Piero BARTOLONI, Le necropoli fenicie di Sulky. 1: le collezioni private.
[23] Elisa POMPIANU, La necropoli di Villamar nel contesto della presenza cartaginese nella Marmilla.
[24] Sara MUSCUSO, Le urne cinerarie di età ellenistica dalla necropoli sulcitana.
[25] Stefan ARDELEANU, Au-delà du couple “continuités et ruptures”. Problèmes de périodisation en Numidie entre le IIe s. av. J.-C. et la fin du Ier s. ap. J.-C. ; Nouzha BOUDOUHOU, Témoignages littéraires et archéologiques de circulations aux confins des Maurétanies aux époques préromaine et romaine. Orietta Dora CORDOVANA, Note su alcune dinamiche di relazioni culturali in Africa romana. Serena ZOIA, Rotture e continuità nel paesaggio epigrafico mediterraneo di età romana: un confronto. Carlo TRONCHETTI, Continuità e trasformazione nella Sardegna romana tra repubblica e primo impero. Hamid ARRAICHI, Le Maroc antique dans l’historiographie contemporaine: continuité, rupture ou mutation? Marco Edoardo MINOJA, Carlotta BASSOLI, Valentina CHERGIA, Fabio NIEDDU, Una città sul mare. Ricerche archeologiche a Bithia. Maria Adele IBBA, Alfonso STIGLITZ, Maura VARGIU, Paesaggi rurali dell’hinterland di Cagliari: il territorio di Settimo San Pietro. Elisabetta GARAU, Marco RENDELI, Ignazio MURA, Noemi FADDA, Enrico SARTINI, Sant’Imbenia: gli ambienti commerciali e la piazza. Beatrice Alba Lidia DE ROSA, Studi archeometrici preliminari su alcune ciotole carenate dell’età del Ferro dal sito nuragico di Sant’Imbenia.
[26] Jeremy Mark HAYNE, Emanuele MADRIGALI, Andrea ROPPA, Continuità e innovazioni formali nei materiali da S’Urachi: un riflesso di interazione tra Nuragici e Fenici.
[27] Michele GUIRGUIS, Rosana PLA ORQUÍN, Monte Sirai tra età punica e romana (IV-II secolo a.C.). Trasformazioni urbane e continuità culturale nella Sardegna di età ellenistica.
[28] Matteo MILETTI, Stefano SANTOCHINI GERG, Le relazioni fra Etruria e Sardegna nella Prima e Seconda età del Ferro.
[29] Mauro MARIANI, Sant’Imbenia e i processi di formazione urbana in Sardegna nell’età del Ferro.
[30] Paolo BERNARDINI, Tradizione e cambiamento, continuità e rottura in Sardegna nella Prima età del Ferro: l’esempio di Monte Prama.
[31] Alessandra GOBBI, Teresa MARINO, La Prima età del Ferro a Pontecagnano. Dinamiche insediative e topografia delle necropoli.
[32] Giovanna PIETRA, Il Sulcis in età romana. Antonella UNALI, Sulci in età repubblicana: la cultura materiale.
[33] Felicita FARCI, Gianfranca SALIS, Un contributo allo studio del Sulcis punico-romano: l’intervento 2011-12 in località Su Landiri Durci (Carbonia).
[34] Oliva Rodriguez GUTIERREZ, Jacinto SANCHEZ GIL DE MONTES, Araceli RODRIGUEZ AZOGUE, Alvaro FERNANDEZ FLORES, “In campis myrteis”. Un proyecto para el análisis diacrónico del territorio de la región sulcitana: una primera aproximación metodológica al estudio de la época antigua.
[35] Jacopo BONETTO, Anna BERTELLI, Filippo CARRARO, Giovanni GALLUCCI, Maria Chiara METELLI, Ivan MINELLA, “Nora e il mare”: ricerche e tutela attorno agli spazi costieri della città antica.
[36] Michele AGUS, Stefano CARA, Andrea Raffaele GHIOTTO, Le terrecotte figurate rinvenute nelle ricerche subacquee di Michel Cassien a Nora: uno studio integrato tra archeologia e archeometria.
[37] Romina CARBONI, Emiliano CRUCCAS, Luca LANTERI, Nora (Pula-Cagliari). Progetto Isthmos. Campagna di Survey e scavo 2013.
[38] Jacopo BONETTO, Giovanna FALEZZA, Caterina PREVIATO, Archeologia dell’edilizia a Nora (Sardegna). Dalla cava di Is Fradis Minoris ai monumenti della città.
[39] Eleonora Maria CIRRONE, I contenitori anforici dal riempimento della vasca-cantina dei vani V e Z dell’area AB a Nora.
[40] Bianca Maria GIANNATTASIO, Ceramica “greco-orientale” dall’area artigianale di Nora, come indicatore di rottura.
[41] Guido CLEMENTE, Momenti di continuità e rottura: bilancio di trent’anni di convegni dell’Africa romana: pp. 41-56.
[42] Attilio MASTINO, Saluto introduttivo: pp. 29-32.
 Tomasino Pinna è scomparso il 25 giugno dopo otto mesi di terribili sofferenze iniziate il 30 ottobre con l’incidente in Ogliastra: a 66 anni di età, lascia nel dolore Luciana e Adriano, ma anche tanti amici di una vita che, come me, lo conoscevano da quasi cinquanta anni, partendo dai luminosi anni della Facoltà di Lettere di Cagliari, dove era cresciuto alla scuola di Alberto Mario Cirese e della sua Clara Gallini.
Tomasino Pinna è scomparso il 25 giugno dopo otto mesi di terribili sofferenze iniziate il 30 ottobre con l’incidente in Ogliastra: a 66 anni di età, lascia nel dolore Luciana e Adriano, ma anche tanti amici di una vita che, come me, lo conoscevano da quasi cinquanta anni, partendo dai luminosi anni della Facoltà di Lettere di Cagliari, dove era cresciuto alla scuola di Alberto Mario Cirese e della sua Clara Gallini.







 Ho appreso mentre mi trovavo in Algeria la notizia della scomparsa, il 16 maggio, del prof. Ugo Carcassi, maestro e amico indimenticabile, che avevo incontrato per la prima volta grazie ad Eugenia Tognotti. Per noi a Sassari qualche anno fa (il 22 maggio 2014) aveva presentato il volume ‘Un medico in Sardegna’, per le edizioni di Carlo Delfino: un testo che apriva uno squarcio sulla sua vita operosa di medico, ricercatore infaticabile, scienziato di livello internazionale, professore universitario, Preside di Facoltà, Direttore di Clinica Medica. Sempre per l’editore Delfino, Carcassi aveva studiato le patologie di personaggi come Giuseppe Garibaldi (in tre diversi volumi), Giacomo Casanova, Galileo Galilei, Vincenzo Bellini, Nicolò Paganini, Carlo V. Ma Carcassi si era occupato assieme ad Ida Mura della pubblicazione del volume Sardegna e malaria e soprattutto aveva studiato la vicenda della salma di Garibaldi a Caprera.
Ho appreso mentre mi trovavo in Algeria la notizia della scomparsa, il 16 maggio, del prof. Ugo Carcassi, maestro e amico indimenticabile, che avevo incontrato per la prima volta grazie ad Eugenia Tognotti. Per noi a Sassari qualche anno fa (il 22 maggio 2014) aveva presentato il volume ‘Un medico in Sardegna’, per le edizioni di Carlo Delfino: un testo che apriva uno squarcio sulla sua vita operosa di medico, ricercatore infaticabile, scienziato di livello internazionale, professore universitario, Preside di Facoltà, Direttore di Clinica Medica. Sempre per l’editore Delfino, Carcassi aveva studiato le patologie di personaggi come Giuseppe Garibaldi (in tre diversi volumi), Giacomo Casanova, Galileo Galilei, Vincenzo Bellini, Nicolò Paganini, Carlo V. Ma Carcassi si era occupato assieme ad Ida Mura della pubblicazione del volume Sardegna e malaria e soprattutto aveva studiato la vicenda della salma di Garibaldi a Caprera.

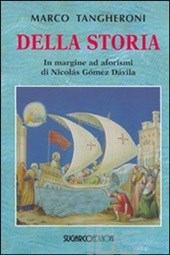 Sono felice di essere a Cagliari a questo Congresso della Mediterranean Studies Association, chiamato a presentare il volume postumo di Marco Tangheroni, Della Storia. In margine ad aforismi di Nicolás Gómez Dávila, un’opera inconsueta edita da Sugarco Edizioni di Milano, curata da Cecilia Iannella, con la presentazione di David Abulafia.
Sono felice di essere a Cagliari a questo Congresso della Mediterranean Studies Association, chiamato a presentare il volume postumo di Marco Tangheroni, Della Storia. In margine ad aforismi di Nicolás Gómez Dávila, un’opera inconsueta edita da Sugarco Edizioni di Milano, curata da Cecilia Iannella, con la presentazione di David Abulafia.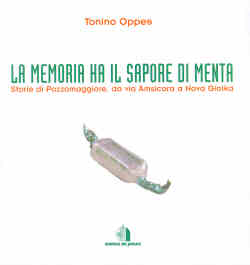 Questa nuova fatica di Tonino Oppes è un omaggio al suo dolce paese, un luogo tanto amato e presente nel ricordo e nella mente anche quando l’autore si trova a chilometri di distanza, guardandolo con rimpianto dalla città lontana: un luogo di cui Tonino porta sempre con se nel cuore le immagini, i suoni, i profumi, i sapori forti, come l’orecchio abbrustolito del maiale con le setole carbonizzate oppure la caramella dal sapore di menta avvolta in una carta trasparente e sottilissima che gustava con gioia quand’era bambino.
Questa nuova fatica di Tonino Oppes è un omaggio al suo dolce paese, un luogo tanto amato e presente nel ricordo e nella mente anche quando l’autore si trova a chilometri di distanza, guardandolo con rimpianto dalla città lontana: un luogo di cui Tonino porta sempre con se nel cuore le immagini, i suoni, i profumi, i sapori forti, come l’orecchio abbrustolito del maiale con le setole carbonizzate oppure la caramella dal sapore di menta avvolta in una carta trasparente e sottilissima che gustava con gioia quand’era bambino.